Apologia di Croce

 omposto nel 1928 su espressa richiesta della Enciclopedia Britannica, tradotto in inglese da Robin G. Collingwood, filosofo e amico di Croce, e pubblicato nel 1929 appunto nella 14ª edizione dell'Enciclopedia più prestigiosa al mondo, Aesthetica in nuce è il saggio dell'età matura, l'epitome crociana, l'Estetica in summa del più autorevole pensatore italiano del Novecento.
omposto nel 1928 su espressa richiesta della Enciclopedia Britannica, tradotto in inglese da Robin G. Collingwood, filosofo e amico di Croce, e pubblicato nel 1929 appunto nella 14ª edizione dell'Enciclopedia più prestigiosa al mondo, Aesthetica in nuce è il saggio dell'età matura, l'epitome crociana, l'Estetica in summa del più autorevole pensatore italiano del Novecento.
Benedetto Croce (1866-1952) fu scelto per scrivere la voce "Aesthetics" nell'Enciclopedia Britannica perché già dagli inizi del secolo era riconosciuto a livello internazionale quale uno dei più insigni filosofi dell'estetica. La sua opera principale, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1902), aveva avuto una vasta eco e influenza, venendo tradotta in svariate lingue e contribuendo a diffonderne in modo determinante il pensiero filosofico e critico ben oltre i confini italiani ed europei. ✦
"Aesthetica in nuce": un saggio per l'Enciclopedia Britannica
L'incarico, di prestigio e delicatezza notevole, volle riconoscere in lui il massimo esponente di un'estetica idealistica, sistematica e rigorosamente autonoma. Il testo, redatto in italiano, fu per l'occasione tradotto in inglese da R.G. Collingwood, giovane e brillante filosofo britannico, autore anch'egli di importanti riflessioni sull'estetica e ammiratore del pensiero crociano. L'amicizia tra i due si consolidò proprio in quegli anni, nel segno di un confronto intellettuale ricco e fecondo.
Pubblicato definitivamente sotto il titolo Aesthetica in nuce, il saggio rappresenta una sorta di cristallizzazione essenziale della teoria estetica di Croce. In una quarantina di pagine – sobrie ma dense – il filosofo napoletano propone una sintesi del proprio pensiero che non rinuncia né alla complessità interna né alla forza assertiva delle sue posizioni. Più che una voce enciclopedica in senso convenzionale, il testo si presenta come un compendium philosophicum, in cui Croce riformula i punti cardine della sua estetica, sottolineando la necessità di difendere l'autonomia della forma artistica, la natura intuitivo–espressiva dell'arte e il suo carattere radicalmente spirituale e storico.
Il contesto in cui Aesthetica in nuce prende forma non è irrilevante. A distanza di oltre un quarto di secolo dalla pubblicazione della sua "prima" Estetica sistematica (1902), e a tre lustri dal successivo potente Breviario (1913), Croce si trovava a dover ribadire le fondamenta del proprio pensiero contro una serie di derive filosofiche che giudicava erronee: da un lato, il formalismo estetizzante e simbolista; dall'altro, l'approccio scientifico–psicologistico che andava affermandosi nelle scuole anglosassoni. In questo scenario, la sua nuova sintesi (che non a caso passò tra gli studiosi con il nome di «terza Estetica»*), appariva non come un semplice compendio, bensì come un intervento critico militante, volto a riaffermare i princìpi primi dell'estetica filosofica in un'epoca che tendeva sempre più a disgregarli o a dissolverli nel generico.
È importante ricordare come Croce, all'altezza del 1928, fosse ormai riconosciuto come uno degli intellettuali più autorevoli d'Europa. Tradotto in tutte le principali lingue del continente e del mondo, corrispondente con filosofi e critici da Berlino a Londra, da Parigi a New York, egli rappresentava un punto di riferimento imprescindibile non solo per gli specialisti dell'estetica, ma per chiunque si occupasse, in termini teorici, del rapporto tra spirito, storia e arte. Aesthetica in nuce, in questo senso, ben lungi dall'essere un testo minore, costituisce un atto di presenza del filosofo italiano nella grande arena culturale internazionale del primo Novecento.
🖋 *Aesthetica in nuce vs «terza Estetica»
Cosa pensasse poi davvero don Benedetto dell'appellativo assegnato alla sua Aesthetica in nuce, è presto detto: "La prima serie dei saggi qui riuniti riguarda l'Estetica e si apre con una concisa riesposizione complessiva che di questa disciplina ebbi occasione di fare nel 1928, e che, venendo dopo l'Estetica del 1900 e il Breviario di Estetica del 1912, è stata chiamata la mia «terza Estetica». In verità, si tratta sempre di una medesima Estetica, da me attraverso il mio lavoro di critico e storico letterario continuamente rimeditata e pertanto approfondita e arricchita, non solo in quelle tre esposizioni complessive ma, prima e poi, in tutti gli altri miei scritti di varia estensione e occasione, che si riferiscono al medesimo argomento. Ben di rado, e solamente in qualche breve linea, ho dovuto, nel corso di questa attenta riconsiderazione, cancellare e rifare quel che avevo scritto; ma non poco ho dovuto aggiungere, perché la stessa risoluzione di certi problemi, sgombrando ostacoli alla vista, mi lasciava vedere più di quello che avevo veduto prima e progredire a ulteriori problemi. Del pari, gli altri saggi che tengono dietro a quest'esposizione ripigliano la mia Storia dell'Estetica (che già avevo ripigliata nei Nuovi saggi e in altri sparsi scritti), col precipuo intento di integrare quanto in quella mancava per effetto di certo giovanile radicalismo che qua e là vi persisteva, e di trasportare sempre più l'accento, come si conviene al racconto storico, dal negativo al positivo [...]".
Napoli, ottobre 1934
(Dall'"Avvertenza" a: Benedetto Croce. Ultimi saggi. Laterza, 1935)
L'idea di estetica in Croce: intuizione, espressione, storicità
All'interno del saggio, prendono forma, con sorprendente chiarezza e rigore, i principali assunti dell'estetica crociana. Di seguito, ne offriamo una lettura introduttiva d'insieme, utile ad orientarsi ancor prima di farne un'analisi dettagliata.
✦ Croce concepisce l'estetica come una teoria dello spirito. Essa è il luogo in cui si riflette quella forma originaria della coscienza che egli chiama intuizione espressiva: una conoscenza immediata, non logica, individuale e singolare, attraverso cui lo spirito si rappresenta nel mondo. L'arte, nella visione crociana, non è né un gioco né un abbellimento del reale, ma una delle forme fondamentali della vita spirituale. Essa è, anzitutto, espressione. Non descrive, non imita, non trasmette concetti: esprime. E questa espressione non è mai un'aggiunta secondaria al contenuto, ma il contenuto stesso. Non c'è un'idea che si veste d'arte: l'arte è l'idea nel suo manifestarsi come forma.
✦ Altro tratto originale e profondo è la strenua difesa dell'autonomia dell'arte. Croce rigetta ogni riduzione dell'opera d'arte a strumento di fini estrinseci: morali, religiosi, politici, pedagogici. L'opera è fine a se stessa, ed è questa autonomia a garantirne la verità e il valore. In questo, egli si distanzia tanto dalle estetiche moralistiche quanto da quelle edonistiche e formalistiche. L'arte, se vera, può anche urtare il buon costume, offendere la morale corrente o suscitare disagio: ma ciò non ne invalida in nulla la legittimità estetica, se essa è compiutamente espressiva.
✦ Ulteriore pilastro del sistema è lo storicismo assoluto. Ogni atto dello spirito è storico, e così pure l'arte: essa nasce in un tempo, da una civiltà, da una tensione spirituale determinata. Tuttavia, proprio perché storica, l'arte è anche portatrice di verità universale: essa è storica nel modo in cui è universale, incarnando lo spirito del tempo e insieme trascendendolo nella forma.
✦ Croce combatte le estetiche tradizionali, che classifica come insufficienti e fuorvianti. Le estetiche del piacere, che riducono l'arte a godimento sensibile; quelle del vero, che le attribuiscono compiti conoscitivi concettuali; e quelle del buono, che la sottomettono a fini etici. Tutte, per Croce, fraintendono la natura dell'estetico, che è anzitutto e soltanto espressione intuitiva.
✦ Inoltre, Croce insiste sull'unità dell'arte. Le distinzioni tra le diverse arti – poesia, musica, pittura, architettura – sono secondarie e accidentali: ciò che le accomuna è la loro natura espressiva. Per questo, egli rifiuta l'idea di una gerarchia tra arti maggiori e minori, o tra forme più "spirituali" e altre più "materiali". L'arte è una, ed è sempre arte dello spirito.
✦ Infine, aspetto meno evidente ma decisivo è pure la concezione linguistica dell'arte: Croce, in dialogo con Vossler e Humboldt, ma soprattutto in contrasto con ogni riduzione grammaticalistica della lingua, afferma che ogni atto artistico è un atto linguistico, in senso lato: è un'espressione in forma. La sua estetica, così, assume anche i tratti di una teoria generale del linguaggio come forma primaria di conoscenza e di vita spirituale.
✦ Non meno importante, in un quadro complessivo, è la qualità della lingua crociana, da cui già in questo saggio emerge una straordinaria arte della chiarezza concettuale. La prosa crociana è elegante, tagliente, rigorosa, e tuttavia sempre vibrante. Il lessico è preciso, quasi chirurgico, e riflette un'intelligenza filosofica pienamente consapevole della responsabilità del linguaggio. Nei suoi scritti – e Aesthetica in nuce non fa eccezione – Croce costruisce un universo linguistico che diventa esso stesso esempio di forma compiuta. Le sue opere sono "monumenti di stile", come si sarebbe detto nel Settecento: testi in cui il contenuto filosofico si salda inscindibilmente a una forma espressiva alta e perfettamente controllata.
 Testo e commento
Testo e commento
✦ Il testo di Aesthetica in nuce, composto di dodici paragrafi qui di seguito integralmente riportati, e corredato da commento e note originali, è tratto da: Benedetto Croce. Ultimi saggi. Bari, Laterza, 1963. ✦ Le sottolineature e i titoli fuori testo sono nostri.
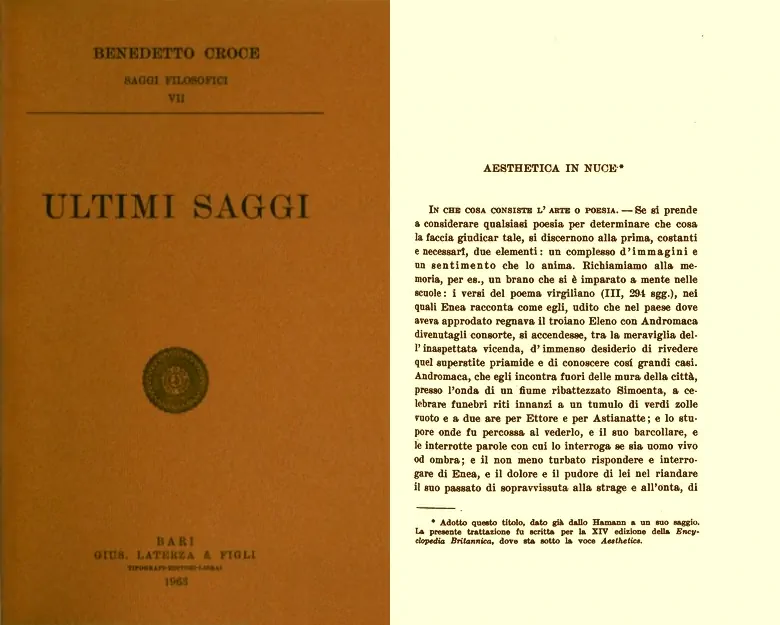
![]() Testo : 1,1
Testo : 1,1
IN CHE COSA CONSISTE L'ARTE O POESIA. — Se si prende a considerare qualsiasi poesia per determinare che cosa la faccia giudicar tale, si discernono alla prima, costanti e necessarî, due elementi: un complesso d'immagini e un sentimento che lo anima. Richiamiamo alla memoria, per es., un brano che si è imparato a mente nelle scuole: i versi del poema virgiliano (III, 294 sgg.), nei quali Enea racconta come egli, udito che nel paese dove aveva approdato regnava il troiano Eleno con Andromaca divenutagli consorte, si accendesse, tra la meraviglia dell'inaspettata vicenda, d'immenso desiderio di rivedere quel superstite priamide e di conoscere così grandi casi.
Croce apre il suo saggio affrontando il problema della definizione dell'arte, o, come precisa fin da subito, della poesia, termine che egli adotta in senso lato per designare ogni manifestazione estetica, non solo quella verbale o letteraria.
La risposta a questa domanda, formulata con chiarezza esemplare, individua due componenti fondamentali, apparentemente separabili solo per via di astrazione:
- Un complesso di immagini, ovvero rappresentazioni sensibili: persone, gesti, scene, ambienti, oggetti;
- Un sentimento che le anima, ovvero una vibrazione interiore, un'emozione, una tonalità affettiva che pervade e unifica quelle immagini.
Croce propone di procedere non a partire da definizioni astratte, ma attraverso l'osservazione concreta di un'opera poetica determinata, così da individuare in essa ciò che essenzialmente la qualifica come poesia.
Egli invita quindi il lettore a richiamare alla memoria un esempio familiare: il celebre episodio dell'Eneide (libro III), in cui Enea, approdato in un luogo che scopre abitato da superstiti troiani, è pervaso da un'intensa emozione nel sapere che lì regnano Eleno e Andromaca. Il poeta descrive l'incontro fra Enea e Andromaca: l'inattesa visione, il turbamento di lei, le sue parole smozzicate, lo sconcerto reciproco, il ricordo angoscioso della caduta di Troia, la schiavitù e l'umiliazione, l'ascesa di Eleno, la nuova città edificata a imitazione della patria perduta.
![]() Testo : 1,2
Testo : 1,2
Andromaca, che egli incontra fuori delle mura della città, presso l'onda di un fiume ribattezzato Simoenta, a celebrare funebri riti innanzi a un tumulo di verdi zolle vuoto e a due are per Ettore e per Astianatte; e lo stupore onde fu percossa al vederlo, e il suo barcollare, e le interrotte parole con cui lo interroga se sia uomo vivo od ombra; e il non meno turbato rispondere e interrogare di Enea, e il dolore e il pudore di lei nel riandare il suo passato di sopravvissuta alla strage e all'onta, di schiava tratta a sorte e tolta concubina da Pirro, e poi la ripulsa ricevuta da costui che la unì schiava ad Eleno schiavo, e l'uccisione di Pirro per mano di Oreste, ed Eleno, tornato libero e re; e l'entrare di Enea coi suoi nella città, accolto dal priamide in quella piccoletta Troia, in quella Pergamo che imita la grande, con quel nuovo Xanto, e il suo abbracciare la soglia della nuova porta Scea: – tutti questi, e gli altri particolari che tralasciamo, sono immagini di persone, di cose, di atteggiamenti, di gesti, di detti, mere immagini che non stanno come storia e critica storica, e non sono né date né apprese come tali. Ma attraverso esse tutte corre il sentimento, un sentimento che non è più del poeta che nostro, un umano sentimento di pungenti memorie, di rabbrividente orrore, di malinconia, di nostalgia, d'intenerimento, persino di qualcosa che è puerile e insieme pio, come in quella inane restaurazione delle cose perdute, in quei giocattoli foggiati da religiosa pietà, della parva Troia, dei Pergama simulata magnis, dell'arens Xanti cognomine rivus: un qualcosa d'ineffabile in termini logici e che solo la poesia, al suo modo, sa dire a pieno.
Croce evidenzia che tutto questo è, nella sua struttura profonda, un tessuto di immagini: persone, gesti, spazi, parole. Ma non sono immagini offerte come cronaca o documento, bensì forme espressive animate da un sentimento, un pathos diffuso che attraversa ogni dettaglio.
Questo sentimento – prosegue Croce – non appartiene più al solo poeta, ma si trasmette come risonanza umana universale: è malinconia, struggimento, nostalgia, tenerezza. E infine, è quell'inspiegabile commozione, quell'ineffabile che la logica non può dire, ma che la poesia "sa dire a pieno" con le sue sole forze, attraverso il linguaggio figurato, incarnato, immaginale.
📌 Poesia come complesso di immagini e sentimento
La scelta del passo virgiliano non è casuale, e non è citazione retorica: è un esempio incarnato di ciò che Croce vuole dire. In ogni gesto, ogni parola, ogni nome (Simoenta, Xanto, Pergamo), l'immaginazione poetica ricostruisce un mondo perduto, ma non come documento, bensì come simbolo emotivo, come esperienza spirituale restituita nella forma.
Il tono è di grande nobiltà espressiva: Croce scrive con un equilibrio perfetto tra rigore concettuale e struggimento poetico. Si avverte, in ogni frase, il rispetto per la grande poesia come manifestazione suprema dello spirito. L'arte, qui, non è una cosa da spiegare: è ciò che spiega tutto, pur senza concetti.
Il centro segreto della pagina è l'ineffabile, il "non dicibile" della logica che solo l'arte riesce a restituire con verità. Questo "qualcosa" – che si manifesta nella "pietà puerile" della parva Troia – è ciò che fa della poesia non un'imitazione del reale, ma una creazione spirituale assoluta, che ci riguarda sempre.
Croce, in fondo, non ha solo scritto una definizione dell'arte: ne ha offerto una dimostrazione poetica. Questa pagina, a ben vedere, è arte che pensa – ed è proprio in questo che consiste la vera estetica.
🏛️ La scena evocata: il mito dopo la rovina di Troia
Il brano dell'Eneide al quale Croce fa riferimento si colloca nel libro III, in una fase in cui Enea, fuggito da Troia distrutta, naviga verso il destino che lo porterà alla fondazione di Roma. Durante uno degli approdi lungo il suo viaggio nel Mediterraneo, giunge in un luogo inaspettato: Butroto, una terra governata da Eleno, figlio di Priamo, re troiano, e da sua moglie Andromaca, la vedova del grande eroe troiano Ettore.
 L'episodio è pervaso da un'intensissima aura malinconica e straniante: Enea scopre che in questa nuova terra i due troiani superstiti hanno costruito una piccola imitazione della patria perduta – una "parva Troia", con un fiume chiamato Xanto, una porta Scea, una Pergamo in miniatura. Tutto è ombra e memoria, tutto è simbolo di una grandezza distrutta e di un passato che, pur sopravvivendo, si spegne nel simulacro.
L'episodio è pervaso da un'intensissima aura malinconica e straniante: Enea scopre che in questa nuova terra i due troiani superstiti hanno costruito una piccola imitazione della patria perduta – una "parva Troia", con un fiume chiamato Xanto, una porta Scea, una Pergamo in miniatura. Tutto è ombra e memoria, tutto è simbolo di una grandezza distrutta e di un passato che, pur sopravvivendo, si spegne nel simulacro.
I personaggi e i loro destini
● Enea
Principe troiano, figlio del mortale Anchise e della dea Venere. Scampa alla distruzione di Troia portando con sé il figlio Ascanio e il padre Anchise. Virgilio lo elegge eroe della pietà (pius Aeneas), fondatore mitico della stirpe romana.
● Andromaca
Vedova di Ettore, dopo la presa di Troia viene ridotta in schiavitù da Pirro, figlio di Achille, che le ha già ucciso il figlioletto Astianatte gettandolo giù dalle mura della città. Subisce una vita di violenze, catene, umiliazioni. In seguito, Pirro la cede a Eleno, anch'egli prigioniero, che la fa sua sposa. Il destino dei due schiavi divenuti regnanti è paradossale, intriso di nostalgia e ombra.
● Pirro (Neottolemo)
Figlio di Achille. È tra i più feroci distruttori di Troia: uccide Priamo sull'altare e prende come concubina Andromaca. Verrà poi assassinato da Oreste, figlio di Agamennone, per vendetta o per amore conteso (Pirro era promesso a Ermione, figlia di Menelao ed Elena, amata da Oreste).
● Oreste
Figlio di Agamennone e Clitennestra, celebre per aver ucciso la madre e il suo amante per vendicare il padre. In questa versione mitica, si vendica anche di Pirro, uccidendolo. Il suo gesto segna la liberazione di Eleno.
● Eleno
Figlio minore di Priamo e fratello di Ettore e Paride. Dopo la guerra, ridotto in schiavitù, riceve Andromaca e in seguito si libera, divenendo re di una nuova città troiana, costruita in terra straniera. Uomo sapiente, vate e sacerdote, è un simbolo della sopravvivenza spirituale della civiltà troiana.
Luoghi e simboli
● Parva Troia
È la "piccola Troia" che Eleno e Andromaca costruiscono nel nuovo regno. Un'imitazione affettuosa e struggente della patria perduta, un gesto di pietà, ma anche di illusione, quasi infantile e sacra insieme. La "restaurazione inane" di cui parla Croce è il tentativo umano di rifare l'irrifacibile, un'architettura del ricordo.
● Pergamo
La cittadella fortificata di Troia, il suo cuore sacro. Nella nuova città, la "Pergama simulata magnis" (Pergamo che imita la grande) è un simulacro malinconico, un'eco. "Simulata" indica non la finzione, ma la replica devota.
● Xanto (Scamandro)
Fiume troiano, divinità fluviale. Eleno dà lo stesso nome a un ruscello del nuovo regno. Ma ora è solo un "arens rivus cognomine" (ruscello secco col nome di Xanto) – un rivolo secco che porta il nome di un dio. Al pari del "falso Simoenta" (Virgilio). Scamandro fu pure il secondo nome dato da Ettore al figlio Astianatte.
● Porta Scea
Era la principale porta di Troia, vicino alla quale si svolgono scene epiche: il duello tra Ettore e Achille, l'addio tra Ettore e Andromaca. Nella nuova città, Eleno ne costruisce una copia: è un portale del ricordo, non della storia.
Il senso profondo dell'episodio
Il brano virgiliano – e, crocianamente, l'opera d'arte – non è racconto storico, né mito congelato: è una "costellazione di immagini" cariche di sentimento, di nostalgia e pietà. Ogni nome, ogni oggetto, ogni figura porta con sé la vibrazione del passato e l'insufficienza del presente.
Croce ci guida a cogliere in queste immagini non nozioni, ma vita spirituale: la malinconia dell'irreversibile, la tenerezza verso ciò che si tenta di salvare ricreandolo, il dolore che si fa bellezza e quindi comunicabile.
È questo, per Croce, il miracolo della poesia: dare forma al sentimento puro attraverso immagini che non raccontano, ma commuovono. Per questo, la "parva Troia" non è solo una città: è l'emblema stesso dell'arte.
👉 Andromaca: memoria e dignità
La figura di Andromaca, moglie di Ettore, emerge con forza straordinaria nella letteratura classica come simbolo di dolore femminile, fedeltà coniugale e memoria storica. Ella è l'incarnazione della sofferenza privata che si intreccia tragicamente al destino pubblico della città di Troia. La sua parabola, da principessa a schiava, da sposa a vedova, da madre a madre privata del figlio, ha costituito una delle immagini più potenti della perdita e della resistenza, ripresa in diverse forme dagli autori antichi e interpretata con profondità nel pensiero estetico moderno, in particolare da Benedetto Croce.
Andromaca in Omero
La prima apparizione significativa di Andromaca si ha nel VI libro dell'Iliade, in uno degli episodi più toccanti di tutta l'epopea. In questo incontro sulle mura, ella cerca di trattenere il marito Ettore dal combattere, temendo la sua morte. La scena familiare, in cui compare anche il figlioletto Astianatte, è costruita con un'intensità emotiva straordinaria: non solo come lamento presago, ma come consapevolezza tragica del destino. Andromaca è colei che sa: che Ettore morirà, che Troia cadrà, che la propria vita sarà distrutta. Eppure, la sua è una voce che non accusa, che non rimprovera, ma che implora nel nome dell'amore e della fragilità.
Euripide e l'Andromaca della sconfitta
Nella tragedia Andromaca di Euripide, ambientata dopo la caduta di Troia, la donna è già schiava, concubina forzata di Neottolemo (figlio di Achille), in casa di Peleo. Ma anche in questa condizione umiliante, la sua grandezza morale resta intatta. Andromaca non rinuncia alla propria dignità né alla memoria del marito, e nel contrasto con Ermione, moglie legittima e gelosa, si staglia come figura di coerenza, fedeltà e dolore. Qui la tragedia non è solo nella perdita, ma nella sopravvivenza alla distruzione, nella resistenza silenziosa del corpo e dello spirito. L'eroina si fa portatrice di una forma di pietà che ha al tempo stesso radici profonde nella memoria e uno sguardo proteso verso il futuro del figlio sopravvissuto (Molosso), avuto con Neottolemo.
Virgilio e la parva Troia
Nell'Eneide (libro III), come abbiamo visto, Virgilio riprende il personaggio di Andromaca in un contesto profondamente romano e insieme elegiaco. Quando Enea, in viaggio verso la futura Roma, approda in Epiro, incontra Andromaca e il nuovo marito Eleno, ora sacerdote e re. La scena è fortemente malinconica: Andromaca, che ha ricreato una "piccola Troia" (parva Troia) con fiumi che portano i nomi degli originali Simoenta e Xanto, è l'emblema della memoria dolorosa. La nostalgia si fa paesaggio, la ferita si pietrifica nella topografia. Ma in questa rappresentazione non c'è solo rimpianto: c'è anche il tentativo di trasfigurare il passato in mito, di renderlo degno di un nuovo racconto e di una nuova civiltà.
Andromaca nell'estetica crociana
In Aesthetica in nuce, ripetiamo, Benedetto Croce richiama proprio questo episodio virgiliano della parva Troia per riflettere sul concetto di finzione poetica e realtà spirituale. Secondo Croce, è proprio nella creazione di questi mondi illusori e purissimi – come quello di Andromaca – che si compie l'opera della fantasia lirica, libera da ogni utilità o vincolo concettuale. Andromaca, che vive nel ricordo mitizzato della sua Troia perduta, è, per Croce, personaggio poetico perfetto, proprio perché trasforma la sofferenza in forma, il lutto in canto. In lei, l'arte si fa memoria e la memoria si fa arte: e in ciò, afferma Croce, si coglie il vero significato dell'estetico, che non è nella storia né nella morale, ma nella pura espressione spirituale.
💧 Il "falso Simoenta": simbolo di una nostalgia impossibile
Il Simoenta (in greco Σιμόεις, in latino Simois) era uno dei due grandi fiumi della Troade, la regione in cui sorgeva Troia, e confluiva nel principale, lo Xanto (Scamandro), gettandosi assieme a questo nell'Ellesponto. Erano fiumi sacri, cantati da Omero e associati alle battaglie dell'Iliade. Quando Eleno e Andromaca ricostruiscono la "parva Troia", danno a due piccoli fiumiciattoli del nuovo paese i nomi gloriosi di Xanto e Simoenta. Ma Virgilio specifica con struggente pietà che non sono i veri fiumi, bensì un "arens rivus cognomine Xanthus" – un rivolo secco che porta solo il nome dell'antico –, e il "falso Simoenta".
Croce richiama quest'immagine ("ribattezzato Simoenta") per mostrare come la poesia non offra la realtà, ma una realtà trasfigurata dal sentimento: immagini animate da un pathos che le rende vive, più vere della verità storica.
Quel Simoenta, quello Xanto, non sono i fiumi veri, ma sono veri nella memoria; è la finzione che dice la verità del dolore, dell'amore, del ricordo.
In questa illusione consapevole – chiamare "Simoenta", o "Xanto", due rigagnoli stranieri – c'è tutta la potenza espressiva dell'arte: essa non riproduce, ma rievoca, non copia, ma interpreta.
"Falso" non significa inganno, ma verità poetica
Quando Virgilio parla del falso Simoenta, non intende un falso nel senso morale o gnoseologico del termine, ma un falso simbolico, poetico, spirituale: è simulacrum, non menzogna; è omaggio, non usurpazione.
Anche la parva Troia, anche la Porta Scea, anche la Pergamo simulata magnis sono false – nel senso in cui è falso un sogno, o un ricordo: non corrispondono a un referente reale, ma custodiscono un significato più profondo.
In questo senso, possiamo dire che:
- il "falso Simoenta" è il paradigma dell'arte;
- la poesia è sempre "una nuova Troia", edificata sulla rovina, e destinata non a vivere nel tempo, ma a durare nel sentimento.
Questa è la verità che Croce trae dal mito: l'arte nasce là dove la realtà è perduta, ma il cuore la ricrea per salvarla.
E quel ruscello senz'acqua, con il nome di un fiume eroico, vale più del fiume stesso: perché è la vita dello spirito che si fa forma, memoria, bellezza.
L'analisi crociana è tanto semplice quanto radicale: ogni vera poesia è al tempo stesso immagine e sentimento, ma non come due elementi addizionabili o giustapposti. Il sentimento, egli afferma, non si sovrappone alle immagini, né si somma a esse: si converte in immagini, si risolve in esse. È, diremmo con lui, sentimento contemplato, superato nella forma, espresso nella purezza dell'intuizione.
🔎 Note testuali
Il concetto di "sentimento convertito in immagine" è una delle nozioni centrali dell'estetica crociana. Esso deriva dalla sua distinzione originaria tra conoscenza intuitiva ed espressione, elaborata già in Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale (1902): l'intuizione non è un presupposto dell'espressione, bensì coincide con essa. Dove c'è intuizione espressiva, c'è già forma artistica compiuta. Il sentimento non è dunque un contenuto grezzo, ma un pathos già spiritualizzato nella forma.
In questo incipit, Croce realizza una delle più alte convergenze tra forma e contenuto della filosofia del Novecento. Non definisce astrattamente l'arte, ma la mostra in atto, facendoci sentire prima ancora che capire che cos'è poesia.
1. Sintassi e ritmo: il respiro del pensiero
La costruzione sintattica crociana, in questo incipit, è ampia, fluente, periodica, ma sempre rigorosamente sorvegliata. Non c'è mai dispersione: ogni inciso ha un ruolo preciso nella gerarchia dell'enunciato. Il lungo esempio virgiliano, apparentemente narrativo, è in realtà costruito come una grande anafora argomentativa, che prepara la tesi.
La proposizione principale iniziale è semplice e assertiva:
«Se si prende a considerare qualsiasi poesia per determinare che cosa la faccia giudicar tale, si discernono alla prima, costanti e necessarî, due elementi…»
Questa frase è un esempio classico di apertura teoretica crociana: ipotetica, impersonale, immediatamente proiettata verso una tesi. Non c'è nulla di vago: l'articolazione è secca, pensata, chiara. A seguire, tuttavia, il periodo si dilata, con una sequenza di subordinate e apposizioni che imitano volutamente il respiro del testo virgiliano, evocando, tramite la struttura, la densità stessa del ricordo poetico.
La frase che descrive il passo dell'Eneide è un capolavoro di accumulo sintattico controllato: ogni elemento (incontro, stupore, barcollare, parole, turbamento, dolore, pudore, memoria, schiavitù, vendetta, fondazione di una nuova città...) è legato da "e" coordinative, come in una litania espressiva. Si tratta di un ritmo paratattico volutamente narrativo, in cui la prosa diventa essa stessa evocazione, partecipazione al pathos.
2. Lessico: precisione e sobria musicalità
Il lessico crociano è, qui come altrove, semplice nell'apparenza, ma profondamente raffinato nella scelta. Parole come immagini, sentimento, pungenti memorie, rabbrividente orrore, intenerimento, puerile e pio, ineffabile – non sono termini ornamentali, ma termini-funzione: ciascuno carica il discorso di una risonanza filosofica.
Si osservi l'espressione:
«un sentimento che non è più del poeta che nostro».
È un momento cruciale: una trasfigurazione soggettiva del sentimento, che si universa nell'esperienza estetica. Il possessivo "nostro" non è grammatica, è ontologia: l'arte ci restituisce a noi stessi, senza passare per il concetto, ma attraverso la vibrazione dell'immagine.
Il culmine lessicale è nella frase:
«un qualcosa d'ineffabile in termini logici
e che solo la poesia, al suo modo, sa dire a pieno».
Qui il termine "ineffabile" è posto in tensione con l'espressione piena, e ciò che non si può dire viene detto nel dirsi stesso – per via poetica. Questa è poetica della parola e insieme teoria della conoscenza, un crocianesimo allo stato puro.
3. Figure retoriche: forma invisibile del pensiero
a) Anafora e accumulo
Croce impiega il procedimento dell'accumulo anaforico e giustappositivo per restituire l'intensità della scena virgiliana. Il ripetersi del "e il..." ("e lo stupore... e il suo barcollare... e le interrotte parole... e il non meno turbato... e il dolore e il pudore...") crea un climax progressivo, non solo emotivo ma strutturale.
b) Chiasmo e contrasto
Notevoli anche i chiasmi impliciti tra forma e contenuto: il sentimento non è del poeta → ma nostro; la bellezza non è concetto → ma sentimento incarnato. Ogni opposizione è strutturalmente dialettica, riconciliata solo nella forma artistica.
c) Allusività simbolica
La frase finale sulla parva Troia e la Pergamo simulata magnis è intrisa di tenerezza e ironia tragica insieme. Il diminutivo "parva", l'ossimoro implicito della restaurazione inane, il "giocattolo" pietoso: l'arte diventa qui rito del ricordo, non riproduzione della realtà, ma forma sacra dell'irrecuperabile.
Questa pagina – definibile come letteratura allo stato puro – è una compiuta manifestazione della poetica crociana dell'espressione, in cui stile e concetto si fondono in un corpo unico. Non c'è nulla da "tradurre" in un altro linguaggio, perché questo linguaggio è già pensiero puro che si fa forma sensibile.
Croce, qui, non sta solo dicendo cos'è la poesia. La sta facendo.
Il nucleo concettuale è potente nella sua semplicità: ogni opera d'arte è composta da immagini e da sentimento. Ma questi due termini non vanno intesi in senso psicologico o empirico. Le immagini sono forme spirituali, e il sentimento è energia interiore che dà vita all'espressione, fondando il senso dell'opera come unità organica.
![]() Testo : 1,3
Testo : 1,3
Due elementi, che per altro appaiono due nella prima e astratta analisi, ma che non si potrebbero paragonare a due fili, neppure intrecciati tra loro, perché, in effetto, il sentimento si è tutto convertito in immagini, in quel complesso d'immagini, ed è un sentimento contemplato e perciò risoluto e superato. Sicché la poesia non può dirsi né sentimento né immagine né somma dei due, ma «contemplazione del sentimento» o «intuizione lirica», o (che è lo stesso) «intuizione pura», in quanto è pura di ogni riferimento storico e critico alla realtà o irrealtà delle immagini di cui s'intesse, e coglie il puro palpito della vita nella sua idealità.
Il sentimento, nel suo stato immediato e indeterminato, è indistinto, fluido, "caotico". Solo l'immagine lo definisce, lo "raffigura" in senso spirituale, rendendolo comprensibile e comunicabile, e dunque propriamente umano.
Croce ricorre a un'espressione illuminante: la poesia è "contemplazione del sentimento", o anche "intuizione lirica" – espressioni che non sono analoghe, ma equivalenti nel suo lessico. Egli precisa che si tratta di intuizione pura, cioè priva di ogni giudizio storico, critico o logico: una forma assoluta, che coglie "il puro palpito della vita nella sua idealità".
Il concetto di intuizione pura rimanda alla teoria crociana delle forme dello spirito, secondo la quale la conoscenza si articola in due gradi fondamentali:
• l'estetico (intuizione/espressione),
• il logico (concetto).
Ad essi si aggiungono le forme della volontà (economico/etico). L'estetica è la prima, ed è autonoma: ogni tentativo di subordinare l'arte alla logica o alla morale è, per Croce, una falsificazione.
![]() Testo : 1,4
Testo : 1,4
Certo nella poesia si possono trovare altre cose oltre questi due elementi o momenti e la sintesi loro; ma le altre cose o vi sono frammiste come elementi estranei (riflessioni, esortazioni, polemiche, allegorie, ecc.), o non sono che questi stessi sentimenti-immagini, disciolti dal loro nesso, presi materialmente, ricostituiti quali erano innanzi della creazione poetica: nel primo caso, elementi non poetici e soltanto introdotti o aggregati; nel secondo, svestiti di poesia, resi non poetici dal lettore non poetico o non più poetico, che ha dissipato la poesia, ora per incapacità di tenersi nella sua sfera ideale, ora per certi fini legittimi d'indagine storica o per certi altri fini pratici, i quali abbassano, o piuttosto adoperano, la poesia a documento e a strumento.
La parte centrale del paragrafo offre un'importante precisazione: quei due elementi – immagine e sentimento – sono tali solo in sede di analisi astratta. Ma nella realtà dell'opera poetica non sono separabili né distinguibili: il sentimento, si dice, si è "tutto convertito in immagini", e queste immagini non hanno significato storico né documentario. Esse vivono unicamente nella dimensione poetica, nella loro tensione lirica.
Croce qui risponde indirettamente – ma con forza – a ogni teoria della poesia come testimonianza: storica, morale, ideologica. Il poeta non è un testimone, ma un creatore. Il suo mondo è fatto di forme espressive, non di dati o verità extrapoetiche.
L'ultima parte del paragrafo assume una funzione diagnostica e critica. Croce distingue due modalità di "tradimento" dell'elemento poetico:
- L'una consiste nell'introdurre nell'opera elementi estranei, come allegorie, esortazioni, riflessioni: essi sono aggiunti, non generati dall'intuizione;
- L'altra consiste nel disgregare l'opera, nello "sciogliere" le immagini-sentimento e ridurle a materiali grezzi, funzionali a fini storici, morali o didattici.
In entrambi i casi, la poesia viene dissolta: o perché alterata in fase di creazione, o perché mal interpretata in fase di ricezione. La poesia cessa allora di essere tale non per difetto di forma, ma per vizio del lettore.
🔎 Note testuali
Croce introduce qui una distinzione fondamentale tra "poetico" e "letterario": la poesia non coincide con la letteratura, né ogni pagina scritta è poesia. La mera letteratura è per lui un insieme di parole prive di tensione lirica, benché corrette, dotte, strutturate. L'intenditore di poesia è colui che sa cogliere il battito poetico, che risuona solo in presenza di vera intuizione-espressione.
![]() Testo : 1,5
Testo : 1,5
Quel che si è detto della «poesia», vale di tutte le altre «arti» che si sogliono enumerare, della pittura, della scultura, dell'architettura, della musica: dovendosi, sempre che si disputa della qualità di questo o quel prodotto spirituale rispetto all'arte, attenersi al dilemma: o esso è un'intuizione lirica, o sarà qualsivoglia altra cosa, sia pure altamente rispettabile, ma non arte.
Infine, Croce estende questa struttura analitica a tutte le arti: pittura, scultura, musica, architettura. Ciò che le rende arte non è il materiale (suoni, colori, volumi), né l'effetto tecnico, ma la presenza – o assenza – dell'intuizione lirica.
![]() Testo : 1,6
Testo : 1,6
Se la pittura fosse, come talvolta è stato teorizzato, un'imitazione o riproduzione di oggetti dati, non sarebbe arte, ma cosa meccanica e pratica; se i pittori fossero, come in altre teorie, combinatori di linee e luci e colori con industre novità di ritrovati e di effetti, sarebbero inventori tecnici e non artisti; se la musica consistesse in simili combinazioni di toni, si potrebbe attuare il paradosso del Leibniz e del padre Kircher di comporre spartiti senza saper di musica, o ci sarebbe da temere, col Proudhon per la poesia e con lo Stuart Mill per la musica, che, esaurito il numero delle possibili combinazioni di parole e di note, la poeticità e la musicalità esulassero dal mondo.
Egli confuta le teorie che vedono nell'arte un gioco combinatorio (come Leibniz e padre Kircher per la musica), o che temono la "fine della poesia" come esaurimento delle combinazioni (Stuart Mill, Proudhon). In realtà, ciò che conta non è il numero delle combinazioni possibili, ma la presenza dell'atto espressivo vivente.
🔎 Note testuali
Questa posizione polemica è diretta contro le derive formalistiche, le estetiche dell'"effetto", e le concezioni tecniche dell'arte come artigianato raffinato. L'artista, per Croce, non è un tecnico della forma, ma un veggente dell'intuizione: la forma non si costruisce meccanicamente, ma scaturisce da un atto unitario dello spirito.
![]() Testo : 1,7
Testo : 1,7
Che poi in queste altre arti si mescolino talvolta, come nella poesia, elementi estranei, sia a parte obiecti sia a parte subiecti, sia nel fatto sia nel poco estetico giudizio dei riguardanti e ascoltatori, è ben noto; e i critici di quelle arti raccomandano di escludere o di non badare agli elementi che chiamano «letterarî» della pittura, della scultura e della musica, allo stesso modo che il critico della poesia raccomanda di cercare la «poesia» e non lasciarsi sviare dalla mera letteratura. L'intendente di poesia va diritto a quel cuore poetico e ne risente il battito nel suo; e, dove quel battito tace, nega che vi sia poesia, quali e quante siano le altre cose che ne tengono il luogo, accumulate nell'opera, e ancorché pregevoli per virtuosità e sapienza, per nobiltà d'intendimenti, per agilità d'ingegno, per gradevolezza di effetti. Il non intendente di poesia si svia dietro queste cose, e l'errore non è che egli le ammiri, ma che le ammiri chiamandole poesia.
Nel concludere il paragrafo, Croce ribadisce il valore della critica poetica autentica: essa non giudica secondo criteri esterni, ma cerca e riconosce il battito poetico interno, e nega il nome di poesia a ogni altro prodotto, per quanto sapiente, dotto, suggestivo o virtuoso.
Postilla
In sintesi, questo primo paragrafo è un compendio straordinariamente denso dei principi cardine dell'estetica crociana:
- l'unità di immagine e sentimento,
- la natura espressiva dell'intuizione,
- l'autonomia dell'arte,
- la necessità di distinguere la poesia dalla letteratura e dalle sue parodie.
Tutto vi è già presente: la teoria, la diagnosi critica, la polemica anti-intellettualistica, l'attenzione alla ricezione, il rigore del giudizio estetico. Ed è già pienamente riconoscibile la cifra stilistica di Croce: logica inflessibile, lessico alto, sintassi tesa, ma perfettamente controllata. La sua lingua filosofica è, come la sua estetica, espressione compiuta di un sentimento spirituale rigoroso, personale, universalmente comunicabile.
👉 Breviario di Estetica (1913) vs Aesthetica in nuce (1928)
Alla medesima domanda ("che cosa è l'arte"), Croce aveva risposto così nel suo Breviario di Estetica (1913): «... io dirò subito, nel modo più semplice, che l'arte è visione o intuizione. L'artista produce un'immagine o fantasma; e colui che gusta l'arte volge l'occhio al punto che l'artista gli ha additato, guarda per lo spiraglio che colui gli ha aperto e riproduce in sé quell'immagine. «Intuizione», «visione», «contemplazione», «immaginazione», «fantasia», «figurazione», «rappresentazione», e via dicendo, sono parole che ritornano di continuo quasi sinonimi nel discorrere intorno all'arte, e che tutte sollevano la nostra mente al medesimo concetto o alla medesima sfera di concetti, indizio di universale consenso».
Nel Breviario, come qui adesso, Croce tiene fermo il principio fondamentale della sua estetica: l'arte è espressione. Ma, in Aesthetica in nuce, introduce un elemento ulteriore, prima solo adombrato, ora esplicitato con maggiore chiarezza: l'arte è sì un complesso di immagini, ma animate da un sentimento.
In questo modo, Croce sembra voler rispondere anche alle critiche e ai malintesi che la sua concezione "puramente intuitiva" aveva suscitato. L'immagine da sola non basta: ciò che la fa essere arte è il sentimento che la pervade, la vita emotiva che la anima e la rende espressiva. Questa precisazione non contraddice la posizione precedente, ma la arricchisce e la completa. Croce vuole evitare che si pensi all'arte come ad una semplice rappresentazione fredda o ad una mera sequenza di immagini: l'arte è sempre espressione di un sentimento, di una vita interiore che si fa forma.
![]() Testo : 2,0
Testo : 2,0
CIÒ DA CUI L'ARTE SI DISTINGUE. — Con la definizione di intuizione lirica o intuizione pura, l'arte viene implicitamente distinta da tutte le altre forme di produzione spirituale.
Il secondo paragrafo di Aesthetica in nuce, che titola significativamente "Ciò da cui l'arte si distingue", rappresenta la prima articolazione sistematica del concetto introdotto in apertura: una volta stabilita l'identità della poesia come intuizione lirica o intuizione pura, Croce passa a delimitare per via negativa il suo territorio, distinguendola da tutte le altre attività spirituali.
Siamo nel cuore della teoria delle forme dello spirito. Il paragrafo segue una struttura enumerativa (sette distinzioni), ma il tono resta disteso, discorsivo, argomentativo, e non sistematico in senso scolastico.
Dopo aver descritto l'arte nella sua positività, Croce ne traccia i confini per contrapposizione: la poesia è ciò che è, anche e soprattutto, in quanto non è altro. L'identità dell'estetico si definisce attraverso una lunga serie di esclusioni. L'arte non si confonde con la filosofia, né con la storia, né con la scienza, né con il gioco, né con il sentimento immediato, né con l'oratoria o l'azione pratica. Si tratta, come nota implicitamente Croce, di negazioni costruttive, cioè volte a proteggere l'autonomia dell'arte e a impedire il suo travisamento.
![]() Testo : 2,1
Testo : 2,1
Rendendo ora esplicite tali distinzioni, si ottengono le seguenti negazioni:
1) L'arte non è filosofia, perché filosofia è pensamento logico delle categorie universali dell'essere, e l'arte è intuizione irriflessa dell'essere; e perciò, laddove la prima oltrepassa e risolve l'immagine, l'arte vive nella cerchia di questa come in suo regno. Si dice che l'arte non può comportarsi in guisa irrazionale né prescindere dalla logicità; e certamente essa non è né irrazionale né illogica: senonché la sua propria ragione e logica è affatto diversa da quella dialettico-concettuale, e, appunto per dare risalto alla sua peculiarità e originalità, furono ritrovati i nomi di «Logica sensitiva» o di «Estetica». Nelle non infrequenti rivendicazioni che si fanno della «logica» all'arte, si giuoca di parole tra la logica concettuale e la logica estetica, o si simboleggia la seconda nella prima.
1. L'arte non è filosofia
L'intuizione lirica o intuizione pura non va confusa con il pensiero concettuale. La filosofia, secondo Croce, si muove nell'ambito delle categorie universali dell'essere, attraverso un lavoro dialettico di concettualizzazione e giudizio. L'arte, invece, vive nella cerchia dell'immagine, senza oltrepassarla. L'errore – frequente sia nei filosofi che nei poeti-filologi – consiste nel trasferire sulla poesia una "logica" che le è estranea: la logica concettuale.
🔎 Note testuali
Croce chiama la logica propria dell'arte "logica sensitiva" o "logica estetica", per opporla alla dialettica del concetto. Questa distinzione è fondamentale per comprendere la dignità autonoma dell'arte: essa non è pre-filosofia o pre-concetto, ma una forma spirituale compiuta in sé. Questo punto riprende e rafforza quanto già teorizzato nel primo volume della Filosofia dello Spirito (1902).
![]() Testo : 2,2
Testo : 2,2
2) L'arte non è storia, perché storia importa critica distinzione tra realtà e irrealtà, realtà di fatto e realtà d'immaginazione, realtà di azione e realtà di desiderio; e l'arte è di qua da tali distinzioni, vivendo, come si è detto, di pure immagini. L'esistenza storica di Eleno, di Andromaca, di Enea è affatto indifferente alla qualità di poesia della poesia virgiliana. Anche qui si è obiettato che all'arte non è estraneo il criterio storico, e che essa osserva la legge del «verisimile»; ma, anche qui, il «verisimile» è nient'altro che una poco felice metafora per designare la coerenza tra loro delle immagini, le quali, se non avessero l'interna coerenza, non sussisterebbero nella forza loro d'immagini, come non sussistono gli oraziani delphinus in silvis e aper in fluctibus, salvo che, appunto, per bizzarria di scherzosa immaginazione.
2. L'arte non è storia
Anche rispetto alla storia, l'arte si distingue in modo netto. La storia si fonda sulla distinzione tra realtà e irrealtà, tra ciò che è avvenuto e ciò che si immagina. L'arte, invece, vive di immagini, e la loro verità non è storica, ma poetica. L'esempio virgiliano ritorna: poco importa se Eleno o Andromaca siano esistiti realmente – ciò che conta è la forza espressiva delle immagini.
🔎 Note testuali
Croce disinnesca qui ogni pretesa di realismo storico nell'arte. Il "verisimile" di cui si parla in poetica classica, secondo lui, è solo una metafora imperfetta per designare la coerenza interna dell'opera. L'arte non ha bisogno di corrispondere alla realtà storica, ma solo a se stessa.
![]() Testo : 2,3
Testo : 2,3
3) L'arte non è scienza naturale, perché la scienza naturale è realtà storica classificata e resa astratta; né è scienza matematica, perché la matematica opera con le astrazioni e non contempla. Gli accostamenti che sono stati fatti talvolta tra le creazioni dei matematici e quelle dei poeti, si fondano sopra estrinseche e generiche analogie; ed altresì una metafora è la cosiddetta matematica o geometria, annidata e operante nel fondo delle arti, con la quale inconsapevolmente si simboleggia la forza costruttiva, coesiva e unificatrice dello spirito poetico, che plasma il proprio corpo d'immagini.
3. L'arte non è scienza
Croce rifiuta ogni assimilazione dell'arte alla scienza naturale o alla matematica. La prima opera per classificazioni astratte; la seconda per astrazioni ideali. Nessuna delle due contempla, ossia coglie l'individuale in forma espressiva. Le analogie spesso tracciate tra creazione poetica e invenzione matematica sono, secondo Croce, metafore incaute.
🔎 Note testuali
Croce riconosce però una verità simbolica in tali analogie: la matematica dell'arte è la sua "forza costruttiva interna", la coesione formale dell'opera. Ma ciò va inteso in senso poetico, non tecnico. Un'arte "geometrica" non è arte nel senso letterale, ma nel senso di una armonia interna dello spirito espressivo.
![]() Testo : 2,4
Testo : 2,4
4) L'arte non è giuoco d'immaginazione, perché il giuoco d'immaginazione passa d'immagini in immagini, spinto dal bisogno della varietà, del riposo, dello svago, d'intrattenersi nelle parvenze di cose piacenti o di affettivo e patetico interesse; laddove nell'arte l'immaginazione è tanto infrenata dall'unico problema di convertire il tumultuoso sentimento in chiara intuizione, che si è sentita più volte l'opportunità di non chiamarla «immaginazione», ma «fantasia», fantasia poetica o fantasia creatrice. L'immaginazione in quanto tale è estranea alla poesia, come alla poesia sono estranee le opere di Anna Radcliffe o del Dumas padre.
4. L'arte non è gioco
Un'importante distinzione riguarda il gioco dell'immaginazione. Il gioco è distrazione, passaggio da un'immagine all'altra, inseguimento della varietà. L'arte, al contrario, è rigore espressivo: l'immaginazione viene trattenuta, disciplinata dalla forma. Per questo Croce preferisce parlare non di immaginazione, ma di fantasia creatrice.
🔎 Note testuali
Questo è un punto chiave della poetica crociana, spesso trascurato: l'arte non è evasione, ma concentrazione spirituale. La critica a Dumas padre e ad Anna Radcliffe, non casuale, prende di mira la narrativa "romanzesca" di consumo, che eccita la fantasia senza esprimerla artisticamente.
![]() Testo : 2,5
Testo : 2,5
5) L'arte non è il sentimento nella sua immediatezza. Andromaca, a vedere Enea, viene amens, deriguit visu in medio, labitur, longo vix tandem tempore fatur, e, nel parlare, longos ciebat incassum fletus; ma lui, il poeta, non delira, non impietra nel viso, non barcolla, non ritrova a stento la parola, non rompe in lungo pianto, ma si esprime in versi armoniosi, di tutte quelle commozioni avendo fatto l'oggetto del suo canto.
5. L'arte non è sentimento immediato
Questa distinzione è centrale. Croce oppone il sentimento agito al sentimento contemplato. Andromaca, nel momento descritto da Virgilio, vive il sentimento: si irrigidisce, sviene, piange ("si irrigidì in mezzo allo sguardo, si abbatté, e con grande fatica, dopo un lungo tempo, riuscì a parlare; pianse a lungo e invano" -n.d.c.). Il poeta, invece, non delira né barcolla: egli canta. Il sentimento viene convertito in forma.
![]() Testo : 2,6
Testo : 2,6
Certo anche i sentimenti nella loro immediatezza «si esprimono», come si suol dire, perché, se non si esprimessero, se non fossero al tempo stesso fatti sensibili e corporali («fenomeni psico-fisici», come li chiamavano i positivisti e neocritici), non sarebbero cose concrete, cioè non sarebbero punto; e Andromaca si esprimeva nel modo che si è detto. Ma cotesta «espressione», ancorché accompagnata da coscienza, scende anch'essa al grado di semplice metafora quanto la si ragguaglia alla «espressione spirituale» o «estetica», che sola veramente esprime, cioè dà forma teoretica al sentimento e lo converte in parola e canto e figura.
Qui si tocca il nodo concettuale della catarsi: l'arte non sfoga l'emozione, ma la trasfigura. La poesia non è il pianto, ma la forma del pianto. Solo così essa è "universale", capace di parlare a tutti perché ha superato la contingenza individuale. Croce connette questo alla dimensione del cosmico, l'infinità dell'arte che comprende in sé tutte le sfumature dell'animo umano. Questo passaggio è anche una critica diretta al sentimentalismo estetico e alla poetica dell'urgenza emotiva: il vero poeta non è un "cuore che trabocca", ma un intelletto che contempla l'emozione e la fa forma.
![]() Testo : 2,7
Testo : 2,7
In questa differenza del sentimento contemplato o poesia rispetto al sentimento agito o sofferto, sta la virtù che si è attribuita all'arte di «liberatrice dagli affetti» e di «serenatrice» (catarsi); e la congiunta condanna estetica di quelle opere o di quelle parti di opere d'arte in cui il sentimento immediato irrompe o si sfoga. Anche da questa differenza deriva l'altro carattere (che è poi sinonimo, al pari del precedente, dell'espressione poetica), la sua «infinità», contrapposta alla «finità» del sentimento o della passione immediata: il che si chiama anche il carattere «universale» o «cosmico» della poesia.
È questo uno dei punti cruciali dell'estetica di Benedetto Croce: la differenza tra il sentimento immediato, vissuto e agito (passione, emozione "sofferta"), e il sentimento contemplato, cioè espresso poeticamente nell'opera d'arte. In questa differenza risiede la virtù liberatrice e "serenatrice" dell'arte (catarsi), che ci permette di contemplare i sentimenti senza esserne travolti, di comprenderli e universalizzarli, liberandoci dalla loro immediatezza e dalla loro forza cieca
🔎 Note testuali
Sentimento agito o sofferto: è il sentimento così come lo viviamo nella vita quotidiana, nella sua immediatezza, nella sua "finità". È legato all'esperienza personale, concreta, limitata nel tempo e nello spazio, e spesso travolge chi lo prova.
Sentimento contemplato o poesia: è il sentimento che, attraverso l'arte, viene espresso, rappresentato, contemplato. Non è più vissuto in modo immediato, ma viene "trasfigurato" in forma poetica, diventando oggetto di intuizione e conoscenza.
👉 Il sentimento espresso poeticamente è "infinito" perché, attraverso la forma artistica, si stacca dalla contingenza individuale e assume un valore universale o "cosmico".
👉 Questa "infinità" è sinonimo di universalità: la poesia autentica, secondo Croce, è sempre espressione individuale e, nello stesso tempo, universale. In ogni vera opera d'arte, "il singolo palpita della vita del tutto, e il tutto è nella vita del singolo". L'arte, quindi, trasforma il sentimento personale in una forma che appartiene a tutti e che può essere riconosciuta come parte dell'esperienza umana universale.
![]() Testo : 2,8
Testo : 2,8
In effetto il sentimento, non vissuto nel suo travaglio ma contemplato, si vede diffondersi per larghi giri in tutto il dominio dell'anima, che è il dominio del mondo, con infinite risonanze: gioia e affanno, piacere e dolore, forza e abbandono, serietà e levità, e via dicendo, si legano in esso l'uno all'altro, e l'uno trapassa, con gradazione di sfumature, nell'altro: sicché ciascun sentimento, pure serbando la sua individuale fisionomia e il suo motivo originario e dominante, non si restringe ed esaurisce in sé stesso. Un'immagine comica, se è poeticamente comica, porta con sé qualcosa che non è comico, come si osserva in Don Quijote o in Falstaff: e un'immagine di cosa terribile non è mai, in poesia, senza qualche conforto di elevazione, di bontà e di amore.
Croce sottolinea che il sentimento, quando non è vissuto nel suo travaglio diretto – cioè non è semplicemente un'emozione momentanea e personale – ma è contemplato attraverso l'arte, si espande e si diffonde "per larghi giri" nell'anima. Questo significa che il sentimento diventa parte di un universo interiore più vasto, che Croce chiama "il dominio del mondo": l'anima dell'artista o dello spettatore si apre a una molteplicità di sensazioni e sfumature.
In questo processo, emozioni opposte o diverse – gioia e affanno, piacere e dolore, forza e abbandono, serietà e levità – si intrecciano e si fondono tra loro, passando l'una nell'altra con gradazioni sottili. Il sentimento, pur mantenendo la sua "individuale fisionomia" (cioè la sua identità specifica), non si esaurisce in se stesso, ma si arricchisce di infinite risonanze e sfumature.
🔎 Note testuali
Croce porta due esempi emblematici per spiegare come, nell'arte poetica, nessun sentimento si presenti mai in modo assoluto o unidimensionale:
• L'immagine comica: anche quando un'opera o un personaggio sono comici, portano con sé qualcosa che non è solo comico. Prendendo come esempio Don Chisciotte di Cervantes o Falstaff di Shakespeare, Croce mostra che la comicità è sempre accompagnata da elementi di umanità profonda, malinconia, nobiltà o saggezza. Non è mai una risata vuota o superficiale, ma una forma di espressione complessa che include anche aspetti seri, dolci o riflessivi.
• L'immagine terribile: allo stesso modo, un'immagine di cosa terribile – per esempio un dramma o una tragedia – non è mai priva di qualche "conforto di elevazione, di bontà e di amore". Anche nel dolore o nella paura più intensi, l'arte poetica riesce a trovare un senso, una luce, una speranza che eleva lo spirito e dà valore alla sofferenza.
![]() Testo : 2,9
Testo : 2,9
6) L'arte non è didascalica od oratoria, cioè arte oltrepassata e asservita e limitata da un intento pratico, quale che esso sia, così quello d'introdurre negli animi una certa verità filosofica, storica o scientifica, come l'altro di disporli a un certo particolare sentire e alla corrispondente azione. Tutt'insieme, l'oratoria toglie all'espressione l'«infinità» e l'indipendenza, e, facendola mezzo per un fine, la dissolve in questo fine. Da ciò il carattere che fu chiamato (dallo Schiller) «indeterminante» dell'arte, contrapposto a quello dell'oratoria che è di «determinare» o di «muovere». Da ciò, tra l'altro, la giustificata diffidenza verso la «poesia politica» (poesia politica, cattiva poesia): quando, ben s'intende, resti «politica» e non assurga a serena e umana poesia.
6. L'arte non è oratoria o didascalica
L'arte, dice Croce, non è mai strumentale. L'oratoria mira a suscitare effetti, a persuadere, a orientare l'animo verso un'azione. L'arte, invece, è "indeterminante": non conduce a nulla, non insegna, non esorta, non commuove per fini ulteriori. È fine a se stessa.
🔎 Note testuali
Croce cita implicitamente Schiller, ma si pone anche contro la poesia militante, in particolare quella politica, che egli giudica pericolosamente vicina all'oratoria. Il confine è sottile: una poesia "politica" può essere autentica solo se supera se stessa, ossia se si eleva a contemplazione dell'umano.
![]() Testo : 2,10
Testo : 2,10
7) L'arte, come non si confonde con quella forma di azione pratica che par le sia più vicina, la didascalica e l'oratoria, così, e a più forte ragione, con nessuna delle altre forme di azione, intese a produrre certi effetti di piacere, di voluttà e di comodo, o, anche, di virtuosa disposizione e di pio fervore. Non solo le opere meretricie debbono essere schivate nell'arte, ma anche quelle mosse da sollecitudine di bene, del pari, sebbene diversamente, inestetiche e perciò respinte dagli amatori di poesia; e, se il Flaubert avvertì che i libri osceni mancano di vérité, il Voltaire celiò di certe «Poésies sacrées», che erano veramente «sacrées (egli diceva), car personne n'y touche».
7. L'arte non è azione
Infine, Croce separa l'arte anche da ogni altra forma di azione pratica: dall'opera di seduzione all'intento edificante o religioso. Non solo l'osceno, ma anche il pio, se privo di forma poetica, è respinto. La vera arte non è mai intenzionale nel senso pratico: non vuole produrre effetti, ma essere.
🔎 Note testuali
È qui che Croce si distanzia sia dal moralismo sia dal clericalismo estetico. Voltaire viene citato con ironia per sottolineare come anche la poesia "sacra" può mancare di poesia. La poesia si giudica non dalla purezza delle intenzioni, ma dalla qualità dell'intuizione.
👉 L'espressione di Voltaire "sacrées, car personne n'y touche" ("sacre, perché nessuno vi mette mano"), riferita a certe "poesie sacre", è un esempio della sua celebre ironia e spirito critico verso le tradizioni religiose e l'autorità ecclesiastica. Con questa battuta, il filosofo francese ridicolizza l'atteggiamento dogmatico che circonda certi testi religiosi o tradizionali: essi vengono dichiarati "sacri" solo perché protetti da un'aura di inviolabilità, non perché effettivamente meritevoli di tale rispetto dal punto di vista letterario o morale.
Postilla
Croce ha costruito, con questo lungo passaggio, la mappa negativa dell'estetico: sette grandi esclusioni per custodire l'autonomia dell'arte. Ogni tentativo di ridurre la poesia a un effetto, a una funzione, a un mezzo, viene respinto con decisione. L'arte si distingue da tutto ciò che non è pura contemplazione espressiva, anche se in apparenza vi si avvicina.
Ma questo elenco non è un repertorio di negazioni. È, piuttosto, una dichiarazione di libertà. Croce difende l'arte da ogni appropriazione indebita: dal filosofo, dallo storico, dallo scienziato, dal retore, dal moralista, dal militante. L'arte è libera perché è forma pura dello spirito, intuizione incarnata, sentimento contemplato. Ed è proprio in questa libertà che risiede la sua verità.
![]() Testo : 3,1
Testo : 3,1
L'ARTE NELLE SUE RELAZIONI. — Queste «negazioni», che abbiamo rese esplicite, sono, per un altro verso, come è facile intendere, «relazioni», non potendosi concepire le varie e distinte forme dell'attività spirituale separate l'una dall'altra e operanti ciascuna isolatamente, nutrentesi ciascuna solo di sé stessa. Non è da questo luogo delineare un completo sistema delle forme o categorie spirituali nel loro ordine e nella loro dialettica; ma, restringendo il discorso all'arte, basterà dire che la categoria dell'arte, come ogni altra categoria, presuppone, a volta a volta, tutte le altre, ed è presupposta da tutte le altre: è condizionata da tutte e pur condiziona tutte.
1. Dalla negazione alla relazione
Ci troviamo ora nel cuore sintetico e dinamico del pensiero crociano: il paragrafo, titolato L'arte nelle sue relazioni, rappresenta un passaggio chiave, perché introduce quella visione organica delle forme dello spirito che costituisce l'ossatura della filosofia sistematica crociana, riformulata però qui in tono più accessibile e con accenti profondamente umani.
Dopo aver definito l'arte come intuizione lirica e averne circoscritto l'identità attraverso un processo di esclusione (filosofia, scienza, storia, oratoria, ecc.), Croce compie qui un movimento inverso e complementare: dimostra come l'arte, sebbene distinta, non sia mai isolata, e anzi sia in rapporto necessario con tutte le altre forme dell'attività spirituale.
Croce invita a superare una visione compartimentata delle categorie dello spirito: l'arte non vive in una torre d'avorio, né nasce da una mente chiusa alla vita. La sua autonomia non significa separatezza. Ogni forma dello spirito è, a un tempo, presupposto e condizione dell'altra.
Nel metodo, egli parte da un paradosso solo apparente: le "negazioni", che hanno permesso di definire l'arte nella sua specificità, sono in realtà anche relazioni. Ogni forma spirituale si alimenta delle altre e interagisce con esse. Nessuna può essere pensata isolatamente.
🔎 Note testuali
Questo è un punto tipico del metodo crociano: l'identità si forma per distinzione, ma la distinzione è dialettica, non assoluta. Le forme dello spirito (estetica, logica, economica, etica) sono distinte, ma internamente e dinamicamente connesse. Ogni atto spirituale, anche se prevale in una forma, porta con sé le altre.
![]() Testo : 3,2
Testo : 3,2
Come potrebbe nascere quella sintesi estetica che è la poesia, se non la precedesse uno stato d'animo commosso? Si vis me flere, dolendum est, con quel che segue. E questo stato d'animo, che abbiamo chiamato sentimento, che cosa è altro mai se non tutto lo spirito, che ha pensato, ha voluto, ha agito, e pensa e desidera e soffre e gioisce, e si travaglia in sé stesso? La poesia somiglia al raggio di sole che splende su questo buio e lo riveste della sua luce, e fa chiare le nascoste sembianze delle cose.
2. Il sentimento come spirito in atto
Il punto di partenza dell'arte è uno stato d'animo commosso. Ma questo sentimento – osserva Croce – non è mai qualcosa di puro o originario in senso naturalistico. Esso è già spiritualità: è lo spirito che ha pensato, voluto, agito. Non esiste sentimento "grezzo" che preceda l'arte come se questa fosse una sua sublimazione: l'arte è luce che illumina un travaglio spirituale già complesso.
La metafora solare che Croce introduce – la poesia come raggio che rende visibile il buio – ha una forza lirica e concettuale memorabile. L'arte, lungi dall'essere evasione o rifugio, è rivelazione luminosa della complessità del vivere.
🔎 Note testuali
L'arte, dunque, nasce sì da una commozione, ma non da un'anima cieca: è frutto di una personalità compiuta, di un soggetto morale, capace di sentire e di intendere. Questo è il nodo che unisce estetica e etica nella filosofia crociana, senza mai confonderle.
👉 Si vis me flere, dolendum est è massima oraziana tratta dall'Ars Poetica. La frase completa è: "Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi", che significa: "Se vuoi che io pianga, prima devi soffrire tu stesso". Orazio, in questo passo, si rivolge ai poeti e agli autori teatrali, sostenendo che, per suscitare emozioni autentiche nel pubblico, lo scrittore deve per primo provare sinceramente quelle stesse emozioni. Questa massima è diventata un principio fondamentale della poetica e della retorica: solo chi sente davvero ciò che scrive o recita può trasmettere tali sentimenti agli altri.
![]() Testo : 3,3
Testo : 3,3
Perciò essa non è opera da animi vuoti e da menti ottuse; perciò gli artisti che, mal professando l'arte pura e l'arte per l'arte, si chiudono verso le commozioni della vita e l'ansia del pensiero, si dimostrano affatto improduttivi, e tutt'al più riescono ad imitazioni dell'altrui o a un disgregato impressionismo. Perciò fondamento di ogni poesia è la personalità umana, e, poiché la personalità umana si compie nella moralità, fondamento di ogni poesia è la coscienza morale. Ben inteso, con questo non si vuol dire che l'artista debba essere pensatore profondo e critico acuto, e neppure che debba essere uomo moralmente esemplare o eroe; ma egli deve avere quella partecipazione al mondo del pensiero e dell'azione che gli faccia vivere, o per propria esperienza diretta o per simpatia con l'altrui, il pieno dramma umano.
3. L'artista e la moralità
Croce distingue con precisione: non si pretende che l'artista sia un santo o un filosofo, ma egli deve partecipare pienamente al dramma umano. Non basta che conosca il bene o il male: deve sentirne la gravità, la risonanza, l'eco morale. Può anche essere colpevole, vigliacco, smarrito – purché viva con coscienza questa tensione. È l'esperienza del bene sentito come esigenza, più che come possesso, a fondare la poesia.
🔎 Note testuali
Questo passaggio si collega alla critica crociana della figura dell'"artista puro", cioè dell'esteta disumanizzato, devoto alla sola Bellezza. Per Croce, l'arte è sempre umana, e quindi implicata in una coscienza morale vissuta, anche quando si esprime su temi apparentemente frivoli o ignobili.
![]() Testo : 3,4
Testo : 3,4
Potrà peccare e macchiare la purezza del suo animo e farsi colpevole in quanto uomo pratico; ma dovrà avere vivo, in una forma o in un'altra, il sentimento della purità e della impurità, della rettitudine e del peccato, del bene e del male. Potrà non esser dotato di gran coraggio pratico o addirittura dar segni di smarrimento e di timidezza; ma dovrà sentire la dignità del coraggio: molte ispirazioni artistiche sorgono non da quello che l'artista è praticamente come uomo, ma anzi da quel che non è e sente che si deve essere e ammira dove lo vede e cerca col desiderio; molte, e forse le più belle pagine di poesia eroica e guerresca, sono dovute a uomini che non avrebbero saputo o potuto brandir mai un'arma.
Lo scarto tra vita vissuta e ideale sentito è, secondo Croce, motore profondo dell'ispirazione. Le grandi poesie eroiche non sono scritte da eroi: sono l'opera di uomini che ammirano il coraggio e lo cercano nella forma espressiva. Anche la mancanza può generare arte, se è consapevole.
🔎 Note testuali
Questa affermazione introduce una nozione preziosa nella poetica crociana: la poesia come desiderio. L'arte nasce anche dall'assenza, dalla tensione verso qualcosa che manca. E proprio in questo suo "non essere possesso" risiede la sua forza utopica, la sua apertura all'universale.
![]() Testo : 3,5
Testo : 3,5
D'altra parte, non si vuol dire che basti possedere personalità morale per essere poeti e artisti: l'essere vir bonus non basta neppure a diventare oratore, se non vi si aggiunga il dicendi peritus. Per la poesia occorre la poesia, quella forma di sintesi teoretica che si è definita di sopra, la genialità poetica, senza la quale tutto il rimanente è la catasta di legna che non brucia perché non ci è modo di appiccarle il fuoco. Ma la figura del poeta puro, dell'artista puro, cultore della pura Bellezza, scevro di umanità è, nondimeno, non una figura, ma una caricatura.
Croce affronta qui il rapporto tra personalità morale e genialità artistica. Sostiene che, sebbene la moralità e la bontà d'animo siano qualità importanti, non sono sufficienti per fare di qualcuno un poeta o un artista. Analogamente, non basta essere una "brava persona" per essere un buon oratore: occorre anche la perizia tecnica, la capacità di esprimersi efficacemente.
Croce usa una metafora efficace: senza la "genialità poetica", cioè senza la capacità creativa e sintetica propria dell'arte, tutte le altre qualità (anche le più nobili) sono come una catasta di legna che non brucia: manca la scintilla, il fuoco dell'arte.
Infine, Croce critica la figura del "poeta puro" o dell'"artista puro", cioè colui che si dedicherebbe solo alla "pura Bellezza", senza alcun legame con l'umanità e la vita reale: questa, per Croce, non è una vera figura, ma una caricatura. L'arte autentica nasce sempre da una sintesi tra genialità creativa e umanità vissuta.
🔎 Note testuali
La locuzione "Vir bonus dicendi peritus" ("Un uomo retto, abile nell'arte del parlare") è una celebre definizione classica dell'oratore ideale.
L'espressione viene attribuita a Catone il Censore (Cato Maior), secondo quanto riportato da Quintiliano nell'Institutio Oratoria (XII, 1, 1).
Quintiliano riprende la definizione per sottolineare che il vero oratore deve essere sì moralmente integro, ma anche tecnicamente preparato nell'arte della retorica.
Croce richiama questa formula per ribadire che, così come per l'oratore serve sia la rettitudine sia la perizia tecnica, per l'artista non basta la moralità: serve la genialità poetica, la capacità di creare sintesi teoretica, cioè vera poesia.
![]() Testo : 3,6
Testo : 3,6
— Che poi la poesia non solo presupponga le altre forme dell'attività spirituale umana ma ne sia presupposta, che sia non solo condizionata ma a sua volta condizione, si dimostra da ciò che senza la fantasia poetica che dà forma contemplativa ai travagli del sentimento, espressione intuitiva alle oscure impressioni, e si fa rappresentazione e parola, parlata o cantata o dipinta o altra che sia, non sorgerebbe il pensiero logico, il quale non è il linguaggio, ma non è mai senza linguaggio, e adopera il linguaggio che la poesia ha essa creato; discerne, mercé i concetti, le rappresentazioni della poesia, ossia le domina, né dominar le potrebbe se prima queste future sue suddite non fossero nate. E, via continuando, senza il pensiero che discerne e critica sarebbe impossibile l'azione, e, con l'azione, la buona azione, la coscienza morale e il dovere.
A questo punto del paragrafo, Croce compie un ulteriore passaggio teorico rilevante: l'arte non è solo condizionata dalle altre forme (etica, logica, ecc.), ma le condiziona a sua volta. La poesia è originaria nel senso forte: essa crea le forme che la filosofia, la scienza e la morale utilizzeranno.
🔎 Note testuali
Questa idea risale direttamente a Estetica come scienza dell'espressione e trova piena formulazione anche nella Logica (1909): il linguaggio concettuale nasce da un linguaggio espressivo. I concetti filosofici non esisterebbero senza rappresentazioni; la morale senza immaginazione sarebbe cieca.
Il pensiero, ci ricorda Croce, non è il linguaggio, ma ha bisogno del linguaggio, e il linguaggio è opera della poesia. È solo grazie alla fantasia poetica, che rappresenta e dà parola ai moti dell'anima, che il pensiero può articolarsi.
Croce introduce qui un'idea quasi genealogica: la poesia precede e fonda le altre attività spirituali. Senza espressione, non vi sarebbe concetto; senza concetto, non vi sarebbe azione.
![]() Testo : 3,7
Testo : 3,7
Non vi ha uomo, per quanto sembri tutto logica e critica e scienza, o tutto versato nella pratica, o tutto dedito al dovere, che non serbi nel fondo dell'anima il suo tesoretto di fantasia o poesia; perfino il pedante Wagner, il famulus di Faust, confessava di avere sovente le sue «grillenhafte Stunden». Se ciò gli mancasse affatto in ogni guisa, non sarebbe uomo, e perciò neppure essere pensante e agente; e, poiché questa ipotesi estrema è assurda, solo in misura che quel tesoretto è più o meno scarso si accusa una certa superficialità e aridità nel pensiero, una certa frigidezza nell'azione.
5. Il "tesoretto di poesia" in ogni uomo
In chiusura, Croce regala una delle immagini più efficaci di tutto il saggio: il "tesoretto di poesia" che ciascuno porta in sé, anche l'uomo più arido, il logico più freddo, il pratico più calcolatore. Egli cita Wagner – non il musicista, ma il personaggio del Faust – per ironizzare su quella pretesa di ridurre l'uomo a macchina logica. In ogni coscienza umana resta, come una radice irriducibile, un nucleo di immaginazione, una scintilla poetica.
🔎 Note testuali
Il tono si fa qui affettuoso, quasi confidenziale. La poesia è garanzia di umanità: non c'è uomo, per quanto rigido o astratto, che non conservi in sé questo barlume. La freddezza del pensiero, la sterilità dell'azione, dipendono in gran parte da un impoverimento di questo nucleo primordiale.
👉 Perfino il pedante Wagner, il famulus di Faust, confessava di avere sovente le sue «grillenhafte Stunden»: si riferisce a un momento in cui Wagner, personaggio servile e pedante nel Faust di Goethe, ammette di avere delle "grillenhafte Stunden", cioè delle "ore bizzarre" o "momenti di stranezze" (dal tedesco grillenhaft, che significa capriccioso, stravagante, eccentrico, e Stunden che significa "ore" o "momenti"). Il significato di questa espressione è che anche un personaggio solitamente rigido, pedante e razionale come Wagner può sperimentare momenti di irrazionalità, strane idee o ispirazioni eccentriche.
Postilla
Questo terzo paragrafo rappresenta una svolta e un'apertura. Croce, dopo aver tracciato i confini dell'arte, li ricongiunge al mondo dello spirito nella sua interezza. La poesia non è un regno separato, ma un centro irradiatore. È la prima forma dello spirito, e insieme la più profonda: nasce da tutto l'uomo e lo fonda.
È in questa visione circolare e gerarchica al tempo stesso che si riconosce la grandezza del pensiero crociano. L'estetica non è più un settore, una disciplina, una specializzazione: è la condizione originaria della spiritualità umana. Ecco perché Aesthetica in nuce, pur nella sua brevità, ha il respiro di una metafisica.
![]() Testo : 4,1
Testo : 4,1
LA SCIENZA DELL'ARTE O ESTETICA, E IL SUO CARATTERE FILOSOFICO. — Il concetto dell'arte, che abbiamo esposto di sopra, è, in certo senso, il concetto comune, quello che luce o traluce in tutte le sentenze intorno all'arte e a cui per espresso o tacitamente ci si riporta di continuo, e che è come il punto verso cui tutte le discussioni in proposito gravitano. Né soltanto ai tempi nostri, ma in tutti i tempi, come si potrebbe comprovare col raccogliere e interpretare detti di scrittori, di poeti, di artisti, di laici, e perfino del popolo.
Con questo quarto paragrafo, titolato La scienza dell'arte o estetica, e il suo carattere filosofico, entriamo nell'ambito metateorico del saggio: Croce sposta il fuoco dall'identità dell'arte all'identità dell'estetica come disciplina, ossia alla sua giustificazione filosofica. Qui l'intento è più chiaramente sistematico, eppure il tono rimane accessibile, serrato, argomentato con limpidezza.
Dopo aver definito che cosa è l'arte, in sé e nei suoi rapporti, Croce passa a definire che cos'è l'estetica, ovvero quella forma del sapere che si occupa di comprendere, riflettere e sistematizzare il concetto d'arte. La distinzione, fondamentale nella sua opera del 1902, viene qui riaffermata: l'estetica non è arte, ma è scienza dell'arte. E, in quanto tale, non può che essere filosofia, anzi: filosofia nel suo intero esercizio, solo lumeggiata dal lato dell'estetico.
1. Il concetto comune di arte come apriori
Croce parte da un'osservazione in apparenza semplice ma carica di conseguenze: l'idea di poesia e di bellezza che egli ha definito non è un'invenzione personale o una dottrina minoritaria, bensì ciò che, in qualche misura, "luce o traluce" in ogni tempo e in ogni cultura. È il concetto "comune" dell'arte – ma attenzione: non naturale, non innato.
![]() Testo : 4,2
Testo : 4,2
Nondimeno conviene dissipare l'illusione che quel concetto esista come un'idea innata, e sostituirle la verità che esso opera come un apriori. Ora, l'apriori non sta mai per sé, ma soltanto nei singoli prodotti che esso genera; e come l'apriori dell'Arte, della Poesia e della Bellezza non esiste quale idea in alcuno spazio iperuranio, percepibile e ammirabile per sé, ma solamente nelle infinite opere di poesia, di arte, di bellezza, che ha plasmate e plasma; così l'apriori logico dell'arte non esiste altrove che nei particolari giudizi che esso ha formati e forma, nelle confutazioni che ha eseguite ed esegue, nelle dimostrazioni che conduce, nelle teorie che costruisce, nei problemi e gruppi di problemi che
ha risoluti e risolve. Le definizioni e distinzioni e negazioni e relazioni, esposte di sopra, hanno tutte la loro storia, e sono state via via elaborate nel corso dei secoli, e noi le possediamo come frutto di quel vario, faticoso e lento lavoro.
Questo concetto – che sembrerebbe un'idea universale presente ovunque – non è un'"idea innata", bensì un a priori, cioè una forma originaria della coscienza che non esiste in sé ma nei suoi atti, nei suoi prodotti.
🔎 Note testuali
Qui Croce distingue tra l'a priori come forma originaria dell'attività spirituale (kantianamente inteso), e l'idea astratta, intesa come entità precostituita. Non esiste un'idea di poesia "iperuranica" (contro ogni platonismo estetico), ma una forma spirituale che si realizza solo nelle opere: nelle creazioni poetiche, nei giudizi critici, nelle confutazioni e teorie. L'a priori si manifesta solo nell'immanenza della storia.
![]() Testo : 4,3
Testo : 4,3
L'Estetica, che è la scienza dell'arte, non ha, dunque, come s'immagina in certe concezioni scolastiche, l'assunto di definire una volta per tutte l'arte e svolgere la correlativa tela di concetti, in modo da coprire tutto il campo di quella scienza; ma è soltanto la continua sistemazione, sempre rinnovata e accresciuta, dei problemi ai quali, secondo i vari tempi, dà luogo la riflessione sull'arte, e coincide del tutto con la risoluzione delle difficoltà e con la critica degli errori che porgono stimolo e materia al progresso incessante del pensiero.
2. L'estetica come sistemazione critica e storica
L'Estetica, intesa come scienza dell'arte, non si propone di definire una volta per tutte che cosa sia l'arte, né di tessere una volta sola la trama concettuale che ne descriva i contorni. Al contrario, essa è una disciplina sempre in divenire, che avanza criticando gli errori, riformulando i problemi, risolvendo le contraddizioni che emergono di volta in volta nella storia della cultura.
🔎 Note testuali
Croce rigetta le concezioni scolastiche dell'estetica che la intendono come un sistema chiuso, manualistico, classificatorio. L'estetica, per lui, è un pensiero sempre in atto, che vive nella dialettica dei problemi reali. Non si dà fuori dal tempo, né fuori dalla storia della cultura.
![]() Testo : 4,4
Testo : 4,4
Ciò posto, nessuna esposizione dell'Estetica, e tanto meno un'esposizione sommaria, quale è dato fare in questo luogo, può mai pretendere di trattare ed esaurire gli infiniti problemi che si sono presentati o si presenteranno nel corso della storia dell'Estetica; ma può soltanto ricordarne e trattarne taluni, ancora resistenti, e persistenti nell'ordinaria cultura, sottintendendo un «eccetera», per invitare il lettore a continuare, secondo i criteri offertigli, la disamina, sia col ripercorrere i vecchi dibattiti, sia con l'attendere a quelli più o meno nuovi dei tempi nostri, che variano e si moltiplicano, per così dire, a ogni ora, assumendo nuovi aspetti.
Questo orientamento lo porta a concepire ogni esposizione dell'estetica – incluso questo stesso saggio – come un intervento parziale e aperto, che non pretende di esaurire il campo, ma invita il lettore a continuare la ricerca.
![]() Testo : 4,5
Testo : 4,5
Un'altra avvertenza non è da trascurare: cioè che l'Estetica, sebbene sia una particolare dottrina filosofica perché pone a suo principio una particolare e distinta categoria dello spirito, in quanto è filosofica non si distacca mai dal tronco della
filosofia, perché i suoi problemi sono di relazione tra l'arte e le altre forme spirituali, e però di differenza e identità: essa è, in realtà, tutta la filosofia, sebbene lumeggiata più insistentemente nel lato che riguarda l'arte.
3. L'estetica è filosofia, e non può non esserlo
Croce affronta qui una questione che aveva già trattato ampiamente nel Breviario di estetica (1912) e nel Saggio sullo Hegel (1913): la necessità che l'estetica sia fondata filosoficamente. Non esiste un'estetica neutra, asettica, che possa valere per tutte le filosofie, o stare fuori da ogni sistema. Ogni estetica presuppone una concezione dell'uomo, dello spirito, della realtà.
![]() Testo : 4,6
Testo : 4,6
Più volte è stata richiesta, ideata o vagheggiata un'Estetica che stia per sé, fuori di ogni determinata concezione filosofica generale, comportabile con parecchie di esse o con tutte; ma l'impresa è ineseguibile perché contraddittoria. Anche coloro che annunziarono un'Estetica naturalistica, induttiva, fisica, fisiologica o psicologica, e insomma non filosofica, nel passare dal programma all'esecuzione, introdussero surrettiziamente una concezione filosofica generale, positivistica, naturalistica o addirittura materialistica. E chi reputi fallaci e oltrepassate coteste concezioni filosofiche del positivismo, del naturalismo e del materialismo, non si attarderà a confutare le dottrine estetiche o pseudoestetiche, che sopr'esse si fondavano e che a loro volta esse concorrevano a fondare, e non considererà problemi ancora aperti, e degni di discussione o d'insistente discussione, i problemi che ne nascevano.
Perciò, anche coloro che hanno tentato di proporre un'estetica "non filosofica" – naturalistica, psicologica, fisiologica – hanno finito per introdurre surrettiziamente un impianto filosofico, spesso inconsapevolmente: positivista, materialista, empirista.
🔎 Note testuali
Il bersaglio qui sono gli autori che, nel nome della "scienza positiva", hanno tentato di fondare l'estetica sulle leggi dell'associazione delle immagini, su modelli fisico-biologici, o su categorie psicologiche. Croce mostra come ogni estetica, anche quella che si pretende "induttiva", presuppone inevitabilmente una filosofia.
![]() Testo : 4,7
Testo : 4,7
Con la caduta, per es., dell'associazionismo psicologico (ossia del meccanismo sostituito alla sintesi a priori), è caduto non solo l'associazionismo logico, ma anche quello estetico con la sua associazione di «contenuto» e «forma» o di «due rappresentazioni», che era (all'opposto del tactus intrinsecus, di cui parla il Campanella, che si fa cum magna suavitate) un contactus extrinsecus, nel quale i termini, accostati, subito dopo discedebant.
In particolare, Croce critica l'associazionismo psicologico, che concepisce l'opera d'arte come il risultato meccanico di una combinazione di elementi (contenuto + forma), o di rappresentazioni associate. Questa è una dottrina fallace, fondata su un contactus extrinsecus (un contatto esterno), a cui egli contrappone il tactus intrinsecus – l'unità intima e organica della forma poetica.
🔎 Note testuali
L'allusione a Campanella (tactus intrinsecus cum magna suavitate) è ironica e colta: Croce ridicolizza le teorie che pensano all'arte come giustapposizione di pezzi, come montaggio, e non come forma unitaria nata da un atto spirituale indiviso. L'estetica associazionistica, come già nella Logica, è la versione logica e mentale del meccanicismo materialista. Con la caduta di questo meccanismo (che sostituiva la sintesi a priori), sostiene Croce, è caduto anche l'associazionismo estetico, che vedeva la forma e il contenuto come due rappresentazioni separate accostate tra loro (un contactus extrinsecus).
👉 Tactus intrinsecus vs Contactus extrinsecus: Croce mette a confronto due modi di intendere il rapporto tra elementi nella percezione estetica o cognitiva, facendo riferimento a una distinzione filosofica che risale a Tommaso Campanella.
Tactus intrinsecus (dal latino, "tocco interno") del Campanella, indica un tipo di unione o sintesi interna, profonda e armoniosa tra elementi, che avviene "cum magna suavitate" (con grande dolcezza, naturalezza). È una fusione autentica e organica, non meccanica, che produce una nuova unità estetica o cognitiva.
Contactus extrinsecus ("contatto esterno") è invece un semplice accostamento esteriore di elementi, che restano separati e si allontanano subito dopo, senza vera sintesi o integrazione. È un contatto superficiale, meccanico, privo di quella "dolcezza" interna che caratterizza il tactus intrinsecus.
Quindi, il riferimento a Campanella serve a indicare un modello di sintesi profonda e armoniosa (tactus intrinsecus), opposto all'associazione meccanica e superficiale (contactus extrinsecus) dopo la quale gli elementi inevitabilmente tornavano a separarsi (discedebant).
![]() Testo : 4,8
Testo : 4,8
Con la caduta delle spiegazioni biologiche ed evoluzionistiche dei valori logici ed etici, è caduta anche quella analoga dei valori estetici. Con la dimostrata incapacità dei metodi empirici all'intelligenza della realtà, che essi possono soltanto tipeggiare e classificare, è caduta ogni speranza di
un'Estetica che si costruisca col raccogliere in classi i fatti estetici e indurne le leggi.
4. Il fallimento dell'estetica naturalistica
Croce estende la critica anche alle spiegazioni biologiche ed evoluzionistiche dell'arte, che cercavano nei bisogni di adattamento, piacere, sopravvivenza o coesione sociale le origini dell'esperienza estetica. Anche queste, egli sostiene, sono cadute con la crisi generale del positivismo.
Infine, Croce chiude il paragrafo ricordando l'inadeguatezza del metodo empirico all'intelligenza dell'arte. Raccogliere e classificare i "fatti estetici", indurre da essi delle "leggi" generali è operazione priva di fondamento. L'arte non è classificabile perché è atto unico, spirituale, irripetibile.
🔎 Note testuali
Croce non nega il valore della storia dell'arte, della filologia o dell'estetica comparata. Ma distingue rigorosamente tra questi saperi descrittivi e la vera estetica, che è critica e teoretica, e quindi filosofica. Nessuna induzione può restituire l'essenza dell'intuizione lirica, che è irriducibile al fatto empirico.
Postilla
Questo paragrafo ha una funzione strategica: riaffermare, con tono assertivo ma ragionato, il carattere filosofico e teoretico dell'estetica. Croce difende qui la sua posizione contro le correnti empiriste, psicologiche, naturalistiche che hanno dominato parte della cultura ottocentesca e che ancora, ai suoi tempi, tentano di imporsi.
L'estetica è per lui una forma della filosofia e, insieme, una manifestazione del pensiero storico: vive nel tempo, si sviluppa attraverso la critica, si alimenta dei problemi, e si riconosce nei suoi atti, mai fuori da essi.
È una riflessione affilata, rigorosa, ma anche profondamente antidogmatica: l'estetica non è una dottrina da conservare, ma una prassi da esercitare. E ciò che si conserva, si conserva soltanto nel pensiero che lo rifonda.
Con questo paragrafo si chiude, per così dire, la parte teorico-fondativa del saggio, con la struttura teoretica che appare ora compiuta:
- Che cos'è l'arte: intuizione lirica.
- Da cosa si distingue: negazioni costitutive.
- Con cosa si relaziona: dialettica interna dello spirito.
- Che cos'è l'estetica: la filosofia dell'arte, storicamente situata.
![]() Testo : 5,1
Testo : 5,1
INTUIZIONE ED ESPRESSIONE. — Uno dei problemi che prima si presentano, definita che si sia l'opera d'arte come «immagine lirica», concerne il rapporto tra «intuizione» ed «espressione» e il modo del passaggio dall'una all'altra. È questo, in sostanza, il medesimo problema che si presenta in altre parti della filosofia, come quello di interno ed esterno, di spirito e materia, di anima e corpo, e, nella filosofia della pratica, d'intenzione e volontà, di volontà e azione, e simili. In questi termini, il problema è insolubile, perché, diviso l'interno dall'esterno, lo spirito dal corpo, la volontà dall'azione, l'intuizione dall'espressione, non c'è modo di passare dall'uno all'altro dei due termini o di riunificarli, salvo che la riunificazione non si riponga in un terzo termine, che a volta a volta è stato presentato come Dio o come l'Inconoscibile: il dualismo mena di necessità o alla trascendenza o all'agnosticismo.
Questo paragrafo – Intuizione ed espressione – è uno dei nuclei concettuali più celebri e radicali dell'intero pensiero crociano. Qui Croce afferma e argomenta con vigore la tesi dell'identità di intuizione ed espressione, vero fulcro della sua concezione dell'arte e punto di massima originalità teorica. Il tono si fa qui più denso, persino metafisico, con richiami impliciti alla grande tradizione idealistica (Spinoza, Hegel) ma con una tensione antidualistica tutta sua.
Croce si confronta qui con un nodo teorico fondamentale: come si passa dall'intuizione all'espressione? Se l'arte è immagine lirica, cioè intuizione del sentimento in forma, qual è il rapporto tra il momento interno (l'immagine mentale) e quello esterno (la sua manifestazione)? La domanda è antica e scivolosa, e Croce non teme di riconoscerne fin da subito l'apparente insolubilità.
1. La falsa alternativa del dualismo
Il primo movimento del ragionamento è demolitorio: Croce smonta il problema nella sua forma tradizionale, mostrando che esso si fonda su una scissione artificiosa tra due termini – interno ed esterno, spirito e corpo, intenzione e azione, intuizione ed espressione – che vengono pensati come distinti in partenza.
Questa opposizione, nota Croce, genera un vicolo cieco teorico: se l'intuizione non è l'espressione, non c'è modo di passare logicamente dall'una all'altra. Si cade allora nell'agnosticismo (se si ammette che il passaggio è impensabile) o nella trascendenza (se si invoca un "terzo" che operi la connessione: Dio, l'inconscio, la volontà misteriosa).
🔎 Note testuali
Croce si colloca qui esplicitamente contro ogni forma di dualismo spiritualista, in particolare quello kantiano e neokantiano che postula forme a priori pure (intuizione) da cui derivano successivamente le forme articolate (espressione). Il dualismo è per Croce un errore metodologico che genera paralisi teorica.
![]() Testo : 5,2
Testo : 5,2
Ma, quando i problemi si provano insolubili nei termini in cui sono stati posti, non rimane se non criticare i termini stessi, e indagare come si siano generati, e se la loro genesi sia logicamente legittima. L'indagine in questo caso mette capo alla conclusione: che essi sono nati non in conseguenza di un principio filosofico, ma per effetto di una classificazione empirica e naturalistica, che ha formato i due gruppi di fatti interni e fatti esterni (come se quelli interni non fossero insieme esterni e gli esterni potessero stare senza interiorità), di anime e corpi, di immagini e di espressioni; e si sa che è vano sforzo congiungere in superiori sintesi quel che è stato distinto non già filosoficamente e formalmente, ma solo empiricamente e materialmente. L'anima è anima in quanto è corpo, la volontà è volontà in quanto muove gambe e braccia, ossia è azione, e l'intuizione in quanto è, nell'atto stesso, espressione. Un'immagine non espressa che non sia parola, canto, disegno, pittura, scultura, architettura, parola per lo meno mormorata tra sé e sé, canto per lo meno risonante nel proprio petto, disegno e colore che si veda in fantasia e colorisca di sé tutta l'anima e l'organismo; è cosa inesistente. Si può asserirne l'esistenza, ma non si può affermarla, perché l'affermazione ha per unico documento che quell'immagine sia corporificata ed espressa.
2. Critica dell'origine empirica del dualismo
Croce propone allora una strategia diversa: non risolvere il problema, ma riformularlo. La distinzione tra intuizione ed espressione nasce, egli afferma, da una classificazione empirica, non da una necessità concettuale. Essa deriva da un malinteso naturalismo: si osservano fenomeni "interni" e "esterni" e li si reificano in categorie filosofiche.
Ma l'atto spirituale vero non è mai scindibile: l'anima è tale solo in quanto si fa corpo, la volontà solo in quanto si realizza in azione, l'intuizione solo in quanto si esprime. Dove c'è intuizione autentica, lì già c'è espressione.
🔎 Note testuali
Il linguaggio di Croce si carica qui di valenza ontologica e vitalistica: il pensiero è tale solo se si manifesta, solo se è incarnato in forma sensibile. Non c'è spirito che non sia forma, non c'è immagine che non sia espressa. L'estetica, in questo senso, è filosofia della manifestazione, non della rappresentazione.
![]() Testo : 5,3
Testo : 5,3
Questa profonda proposizione filosofica dell'identità di intuizione ed espressione si ritrova, del resto, nel comune buon senso, che ride di coloro i quali dicono di aver pensieri ma di non saperli esprimere, di aver ideato una grande pittura, ma di non saperla dipingere. Rem tene, verba sequentur: se i verba non ci sono, non c'è nemmeno la res. Siffatta identità, che è da affermare per tutte le sfere dello spirito, in quella dell'arte ha un'evidenza e un risalto che forse le difetta altrove.
3. Contro il mito dell'ineffabile
Croce prende quindi di mira una delle illusioni più diffuse: quella dell'idea "che c'è ma non si riesce a esprimere". Si sente spesso dire: "Ho un pensiero, ma non trovo le parole"; "Vedo un'immagine bellissima, ma non riesco a dipingerla". Ma – osserva Croce con sarcasmo filosofico – se le parole mancano, non c'è nemmeno il pensiero. Se l'immagine non si esprime, non è ancora vera immagine.
🔎 Note testuali
Il riferimento al proverbio Rem tene, verba sequentur serve qui a rovesciarne il senso abituale: non è che "una volta che hai l'idea, le parole verranno", ma piuttosto che senza parole non hai l'idea. La res e i verba sono una sola cosa: l'idea vive solo nella sua espressione.
Croce recupera qui il significato del "buon senso comune" che, di fronte a chi si vanta di avere pensieri ineffabili, "ride". È una delle sue mosse retoriche preferite: riportare la filosofia alla chiarezza dell'evidenza vissuta, sbarazzandosi delle astrazioni opache.
4. L'identità di intuizione ed espressione
La proposizione fondamentale è dunque questa: l'intuizione è espressione. Non un'intuizione "che poi" si esprime, ma un atto unitario e indiviso che è già, nel suo nascere, espressione spirituale. Croce sottolinea che tale identità vale per tutte le forme dello spirito, ma trova nella sfera estetica una evidenza insuperabile.
🔎 Note testuali
Questa affermazione si connette direttamente all'ontologia idealistica che informa tutta la filosofia crociana: lo spirito è forma in atto. Non esiste contenuto senza forma, né forma senza contenuto. Nell'arte questa verità si fa trasparente: non c'è arte senza opera, né opera senza forma pienamente espressiva.
![]() Testo : 5,4
Testo : 5,4
Nel crearsi dell'opera di poesia, si assiste come al mistero della creazione del mondo; e da ciò l'efficacia che la scienza estetica esercita sulla filosofia tutta quanta, per la concezione dell'Uno-Tutto. L'Estetica, negando nella vita dell'arte lo spiritualismo astratto e il dualismo che ne consegue, presuppone e insieme da sua parte pone l'idealismo o spiritualismo assoluto.
Il passaggio sul "mistero della creazione del mondo" è particolarmente intenso: il fare artistico – la nascita dell'opera – appare qui come atto originario, cosmopoietico, rivelatore dell'unità del reale.
🔎 Note testuali
Croce paragona la nascita di un'opera poetica al "mistero della creazione del mondo". Questo significa che la creazione artistica è vista come un atto originario, profondo e quasi sacro, che genera qualcosa di nuovo e unitario, non semplicemente un assemblaggio di parti preesistenti. L'opera d'arte nasce come un tutto organico, un "Uno-Tutto" che contiene in sé la totalità della sua realtà.
👉 L'estetica, intesa come scienza dell'arte e dell'esperienza estetica, ha un ruolo fondamentale nella filosofia perché offre una concezione unitaria della realtà. Essa influenza la filosofia "tutta quanta" proprio perché propone una visione dell'Uno-Tutto, cioè di un'unità integrale e indivisibile che supera la frammentazione e il dualismo.
👉 La concezione dell'Uno-Tutto è un concetto chiave nella filosofia idealistica, e in particolare in Croce:
Uno indica l'unità fondamentale, l'essenza indivisibile della realtà o dello spirito;
Tutto indica la totalità concreta e complessa delle cose, che però non è una semplice somma di parti, ma un'unità organica.
👉 Per Croce, l'opera d'arte è un esempio paradigmatico di questa unità: non è una semplice combinazione di elementi (forme, contenuti, emozioni), ma un'unità viva e indivisibile, che manifesta lo spirito nella sua totalità.
👉 L'atto creativo dell'arte è perciò un momento fondamentale e misterioso, simile alla creazione del mondo, che esprime l'unità assoluta dello spirito. L'estetica diventa così una chiave di lettura filosofica che supera ogni dualismo e spiritualismo astratto, affermando un idealismo assoluto in cui l'Uno e il Tutto coincidono nell'opera artistica.
5. Estetica e filosofia: l'unità dello spirito
Egli conclude affermando che l'Estetica, in quanto nega ogni spiritualismo astratto e ogni dualismo, presuppone e pone un idealismo assoluto. È, dunque, molto più che una teoria dell'arte: è una via d'accesso alla verità del pensiero stesso, una parte viva della filosofia nel suo insieme.
🔎 Note testuali
Croce intende per "idealismo assoluto" una concezione dello spirito come attività creativa e unitaria, che non si spezza in sezioni compartimentate. L'estetica, da questo punto di vista, è la conferma vivente del monismo spirituale: l'arte mostra ciò che la filosofia pensa.
Postilla
Questo paragrafo è, in certo senso, il vertice teorico dell'intero saggio. Croce vi riassume in modo esemplare la sua concezione dell'arte come atto spirituale indivisibile, e al tempo stesso difende la dignità filosofica dell'estetica contro ogni residuo dualistico o psicologico.
La sua scrittura, in questo passo, si fa altamente riflessiva, ma mai oscura. Anzi: la chiarezza argomentativa si accompagna a una profondità speculativa che illumina tutto il saggio. È qui che Croce mostra con più forza la valenza ontologica del bello, non come categoria dell'ornamento, ma come forma prima della vita spirituale.
Il linguaggio si fa anche più lirico: la metafora della creazione del mondo, l'eco del pensiero mistico (l'Uno-Tutto), la critica dell'ineffabile, la sottile ironia – tutto contribuisce a fare di questa pagina una delle più alte dell'intera estetica crociana.
![]() Testo : 6,1
Testo : 6,1
ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE. — Le obiezioni contro l'identità di intuizione ed espressione provengono di solito da illusioni psicologiche onde si crede di possedere, in ogni istante, concrete e vive immagini a profusione, quando si posseggono quasi soltanto segni e nomi; o da casi male analizzati, come quelli di artisti dei quali si crede che esprimano solo frammentariamente un mondo di immagini che hanno intero nell'anima, laddove nell'anima non hanno appunto se non quei frammenti, e insieme con essi non quel mondo supposto, ma tutt'al più l'aspirazione o l'oscuro travaglio verso di esso, ossia verso una più vasta e ricca immagine, che forse si formerà e forse no.
Con il paragrafo Espressione e comunicazione, Croce affronta un problema cruciale e sottilissimo: la distinzione tra atto estetico autentico e processo di trasmissione o riproduzione, ovvero tra espressione spirituale e comunicazione pratica. La lucidità con cui egli scioglie questo nodo – senza mai cedere all'ambiguità terminologica o alla tentazione tecnicistica – è un modello esemplare di rigore filosofico applicato al campo estetico.
Dopo aver affermato l'identità tra intuizione ed espressione, Croce anticipa e affronta una serie di obiezioni diffuse, che nascono, a suo avviso, da una doppia fonte d'errore:
- illusioni psicologiche che scambiano nomi e segni per immagini vive,
- fraintendimenti teorici che confondono l'espressione con la comunicazione.
È proprio questa seconda confusione – apparentemente sottile, ma di enorme rilievo concettuale – che egli si prefigge di chiarire in questo paragrafo.
1. Illusioni sull'"inespresso" e sul frammento
Croce critica l'idea – tanto comune quanto insidiosa – che l'artista abbia in sé un mondo completo di immagini, ma riesca a esprimerle solo in parte. L'opera sembrerebbe così il residuo di un'ispirazione più vasta, un frammento tradito.
Contro questa visione romantica e psicologistica, Croce afferma con forza: nell'anima non c'è l'opera "intera" e non detta. Vi sono al massimo aspirazioni, tensioni, oscuri moti interiori che non sono ancora espressione, ma travaglio verso di essa. L'artista non trattiene un mondo inespresso: egli crea ciò che esprime, e non altro.
🔎 Note testuali
Questa critica al mito dell'"opera ideale" rimasta nella mente del poeta trova un'eco polemica nei confronti delle estetiche dell'ispirazione e del genio: l'arte, per Croce, non è il riflesso deformato di una perfezione interiore, ma l'atto stesso dell'esprimere, nella sua concretezza e interezza.
![]() Testo : 6,2
Testo : 6,2
Ma quelle obiezioni si alimentano anche di uno scambio tra l'espressione e la comunicazione, la quale ultima è realmente distinta dall'immagine e dalla sua espressione. La comunicazione concerne il fissamento dell'intuizione-espressione in un oggetto che diremo materiale o fisico per metafora, quantunque effettivamente non si tratti neanche in questa parte di materiale e di fisico, ma di opera spirituale. Nondimeno, poiché questa dimostrazione circa l'irrealtà di quel che si chiama fisico e la sua risoluzione nella spiritualità ha bensì interesse primario per la concezione totale filosofica, ma solo indiretto per il chiarimento dei problemi estetici, possiamo, per brevità, lasciar correre qui la metafora o il simbolo e parlare di materia o di natura.
2. L'equivoco espressione/comunicazione
Croce arriva ora al cuore del problema: molte delle confusioni derivano dal non distinguere l'espressione (estetica) dalla comunicazione (pratica). La prima è l'atto spirituale di formare un'immagine. La seconda è la trasmissione di quell'immagine ad altri mediante supporti, segni, mezzi fisici o convenzionali.
Ma Croce chiarisce subito che anche la "comunicazione" non è propriamente materiale: anch'essa è azione dello spirito, benché non estetica. È tuttavia utile – per comodità – mantenere la distinzione in termini metaforici tra "espressione" (come forma) e "comunicazione" (come diffusione, riproduzione, socializzazione dell'espressione).
🔎 Note testuali
Croce si muove qui con cautela terminologica: sa che parlare di "fisico" e "materiale" in estetica è pericoloso, perché può favorire letture empiristiche. Ma accetta, per convenzione, l'uso metaforico, pur ribadendo che tutto è spirito: non vi è nulla di realmente "materiale" nemmeno nella comunicazione. Tutto è vita dello spirito, ma in forme diverse.
![]() Testo : 6,3
Testo : 6,3
È chiaro che la poesia è già intera quando il poeta l'ha espressa in parole, cantandola dentro di sé; e che, col passare a cantarla a voce spiegata per farla udire ad altri, o a cercar persone che la imparino a mente e la ricantino altrui come in una schola cantorum, o a metterla in segni di scrittura e di stampa, si entra in un nuovo stadio, certamente di molta importanza sociale e culturale, il cui carattere non è più estetico ma pratico. Il simile è da dire nel caso del pittore, il quale dipinge sulla tavola o sulla tela, ma non potrebbe dipingere se in ogni stadio del suo lavoro, dalla macchia o abbozzo iniziale alla rifinitura, l'immagine intuita, la linea e il colore dipinti nella fantasia non precedessero il tocco del pennello; tanto vero che, quando quel tocco anticipa sull'immagine, viene cancellato e sostituito nella correzione che l'artista fa dell'opera sua. Il punto della distinzione tra espressione e comunicazione è certamente assai delicato a cogliere nel fatto, perché nel fatto i due processi si avvicendano di solito rapidamente e par che si mescolino; ma è chiaro in idea, e bisogna tenerlo ben fermo.
3. L'opera è già compiuta nella sua prima espressione
Ecco il punto decisivo: la poesia è già intera quando il poeta l'ha espressa per sé, nel suo animo, anche solo sussurrandola tra sé e sé. Cantare ad alta voce, trascrivere, stampare, insegnare ad altri, ripetere – tutte queste sono azioni successive, non estetiche, benché importanti sul piano culturale e sociale.
Allo stesso modo, il pittore non dipinge "per vedere" l'immagine: egli ha già l'immagine nella fantasia, e solo dopo la traduce sul supporto. Se la mano precede l'intuizione, ne nasce un errore che l'artista corregge.
🔎 Note testuali
Questa concezione richiama l'idea platonica del "modello interiore", ma è in realtà radicalmente immanentistica: l'opera non risiede in un mondo ideale, ma nel gesto spirituale dell'intuizione formante. L'atto artistico autentico è l'espressione nella coscienza, che può poi essere comunicata, ma non si fonda sulla comunicazione.
![]() Testo : 6,4
Testo : 6,4
Dall'averlo trascurato o lasciato vacillare nella poco attenta considerazione provengono le confusioni tra arte e tecnica, la quale ultima non è già cosa intrinseca all'arte ma si lega appunto al concetto della comunicazione. La tecnica è, in generale, una cognizione o un complesso di cognizioni disposte e indirizzate a uso dell'azione pratica, e, nel caso dell'arte, dell'azione pratica che costruisce mezzi e strumenti pel ricordo e la comunicazione delle opere d'arte: quali sarebbero le cognizioni circa la preparazione delle tavole, delle tele, dei muri da dipingere, delle materie coloranti, delle vernici, o quelle circa i modi di ottenere la buona pronunzia e declamazione, e simili. I trattati di tecnica non sono trattati di Estetica, né parti o sezioni di questi trattati.
4. La tecnica non è arte
Qui Croce tocca un punto delicatissimo, spesso frainteso ancora oggi: la distinzione tra arte e tecnica. La tecnica riguarda i mezzi per comunicare e conservare l'espressione: pennelli, pigmenti, impaginazione, pronuncia, metodi di stampa… Ma nulla di tutto ciò costituisce l'atto estetico. Sono attività pratiche, esteriori rispetto alla forma.
🔎 Note testuali
La distinzione è netta, ma non disprezzante. Croce riconosce l'importanza della tecnica, ma la colloca fuori dal dominio estetico. Confondere i due ambiti – come fanno molti artisti o critici – porta a pensare che si possa "imparare l'arte" con mezzi tecnici, senza la forma spirituale. Il risultato? Virtuosismo senza poesia, artigianato senza intuizione.
![]() Testo : 6,5
Testo : 6,5
Ciò, beninteso, sempre che i concetti siano pensati con rigore e le parole si adoperino con proprietà in relazione a quel rigore di concetti: ché non varrebbe certo la pena di stare a litigare sulla parola «tecnica» quando è adoperata, invece, come sinonimo dello stesso lavoro artistico, nel senso di «tecnica interiore», che è poi la formazione dell'intuizione-espressione; ovvero nel senso di «disciplina», cioè del legame necessario con la tradizione storica, dalla quale nessuno può slegarsi sebbene nessuno vi resti semplicemente legato.
Croce ammette che talvolta la parola "tecnica" viene usata in modo estensivo, come "tecnica interiore" (cioè la disciplina spirituale dell'intuizione) o come "disciplina storica" (il legame con le forme del passato). In questi casi, la parola può essere accettata, purché non si perda il rigore concettuale.
🔎 Note testuali
Qui si coglie lo spirito crociano più autentico: rigoroso ma non pedante, Croce distingue tra uso e abuso, tra significato e degenerazione. L'errore non è nelle parole, ma nell'uso che se ne fa. Se "tecnica" significa interiorità formante, ben venga; ma se significa mezzo pratico, allora non ha nulla a che fare con l'estetico.
![]() Testo : 6,6
Testo : 6,6
La confusione dell'arte con la tecnica, la sostituzione di questa a quella, è un partito assai vagheggiato dagli artisti impotenti, che sperano dalle cose pratiche, e dalle pratiche escogitazioni e invenzioni, quell'aiuto e quella forza, che non trovano in sé medesimi.
5. La tecnica come rifugio dell'artista impotente
Croce chiude il paragrafo con una considerazione tagliente: molti artisti si rifugiano nella tecnica perché non trovano in sé la forza della vera espressione. È una critica profonda, non psicologica ma spirituale. Dove manca la forma interiore, si cercano surrogati nell'abilità, nell'invenzione, nella sperimentazione, nell'effetto.
🔎 Note testuali
È una posizione polemica contro il modernismo formale, ma anche contro certo accademismo. L'arte vera, per Croce, non nasce dall'abilità, ma dall'intuizione. Tutta la tecnica del mondo non potrà dare fuoco alla "catasta di legna" se manca la scintilla dell'espressione.
Postilla
Questo paragrafo è uno dei più chiari e attuali dell'intero saggio. In un'epoca – come la nostra – ossessionata dalla comunicazione, dalla trasmissione, dall'accessibilità, Croce ricorda che l'essenza dell'arte non sta nel comunicare, ma nel formare.
L'arte è atto spirituale originario, e non si misura dalla sua diffusione. Il poeta è tale già nel suo silenzio, il pittore già nella sua visione, il musicista nella sua armonia interiore. Solo dopo nasce la comunicazione – e con essa, la tecnica. Ma esse non fondano l'arte: la seguono.
![]() Testo : 7,1
Testo : 7,1
GLI OGGETTI ARTISTICI : LA TEORIA DELLE ARTI PARTICOLARI E IL BELLO DI NATURA. — Il lavoro della comunicazione ossia della conservazione e divulgazione delle immagini artistiche,
guidato dalla tecnica, produce, dunque, gli oggetti materiali che si dicono per metafora «artistici» e «opere d'arte»: quadri e sculture ed edifici, e poi anche, in modo più complicato, scritture letterarie e musicali, e, ai giorni nostri, fonografi e dischi di fonografi, che rendono possibile di riprodurre voci e suoni. Ma né queste voci e suoni né i segni della pittura, della scultura e dell'architettura sono opere d'arte, le quali non altrove esistono che nelle anime che le creano o le ricreano.
Questo settimo paragrafo, dal titolo Gli oggetti artistici: la teoria delle arti particolari e il bello di natura, è uno dei momenti più densi, provocatori e articolati dell'intero saggio. Croce vi affronta due questioni fondamentali:
- la confutazione della teoria delle arti particolari, che riduce la differenza tra le arti a criteri materiali o tecnici;
- la chiarificazione del "bello di natura", ovvero del fenomeno estetico riferito a realtà naturali, al di fuori dell'intenzionalità artistica umana.
L'intero paragrafo si fonda su un principio cruciale per Croce: l'arte è un atto spirituale e unitario, che non esiste nei materiali ma solo nell'anima che crea e ricrea. È in questo spirito che si deve leggere la sua distinzione tra "opera d'arte" e "oggetto artistico", tra forma spirituale e supporto tecnico o naturale.
1. L'equivoco dell'"oggetto d'arte"
Croce apre questo paragrafo con una puntualizzazione forte: gli oggetti che chiamiamo "opere d'arte" non sono l'arte, ma mezzi tecnici per comunicare e conservare l'arte. Il quadro, la scultura, la partitura musicale, la registrazione audio: tutti questi sono strumenti, non l'essenza dell'opera.
🔎 Note testuali
Croce insiste sull'uso "per metafora" dell'aggettivo "artistico" applicato agli oggetti. L'opera d'arte, in senso proprio, non si trova sulla tela, nel marmo o nei solchi del disco fonografico, ma nella coscienza spirituale che la ha creata o ricreata. È un pensiero rigorosamente idealistico e antirealista.
![]() Testo : 7,2
Testo : 7,2
A togliere apparenza di paradosso a questa verità dell'inesistenza di oggetti e cose belle, sarà opportuno richiamare il caso analogo della scienza economica, la quale sa bene che in economia non esistono cose naturalmente e fisicamente utili, ma solo bisogni e lavoro, dai quali le cose fisiche prendono per metafora quell'aggettivo. Chi in economia volesse dedurre il valore economico delle cose dalle qualità fisiche di esse, commetterebbe una grossolana ignoratio elenchi.
Per dissipare l'apparente paradosso, Croce propone un'analogia con l'economia: anche in quel campo, non esistono oggetti fisicamente "utili", ma solo bisogni e attività spirituali (desideri, scambi, valutazioni) che conferiscono alle cose il valore d'uso. Analogamente, non esiste "cosa bella", ma atto estetico, che può servirsene per manifestarsi.
🔎 Note testuali
Questa analogia serve a rovesciare ogni materialismo estetico. Come l'oggetto economico nasce da un bisogno, così l'oggetto artistico nasce da un'espressione, e ne è solo il veicolo contingente. In entrambi i casi, ogni tentativo di dedurre il valore da proprietà materiali è una "ignoratio elenchi".
![]() Testo : 7,3
Testo : 7,3
E nondimeno questa ignoratio elenchi è stata commessa, ed ha ancora fortuna, in Estetica, con la dottrina delle arti particolari e dei limiti, ossia del carattere estetico proprio di ciascuna. Le partizioni delle arti sono meramente tecniche o fisiche, secondo cioè che gli oggetti artistici consistono in suoni, in toni, in oggetti colorati, in oggetti incisi o scolpiti, in oggetti costruiti e che non sembrano trovare rispondenza in corpi naturali (poesia, musica, pittura, scultura, architettura, ecc.). Domandare quale sia il carattere artistico di ciascuna di queste arti, ciò che ciascuna possa o non possa, quali ordini d'immagini si esprimano in suoni e quali in toni e quali in colori e quali in linee, e via dicendo, è come domandare in economia quali cose debbano per le loro qualità fisiche ricevere un prezzo e quali no, e quale prezzo debbano avere le une rispetto alle altre, quando è chiaro che le qualità fisiche non entrano nella questione e ogni cosa può esser desiderata e richiesta, e ricevere un prezzo maggiore di altre o delle altre tutte, secondo le circostanze e i bisogni. Messo inavvedutamente il piede su questo sdrucciolo, anche un Lessing fu spinto a conclusioni così strane come quella che alla poesia spettino le «azioni» e alla scultura i «corpi»; e anche un Riccardo Wagner si diè ad almanaccare di un'arte complessiva, l'Opera, che riunisse in sé, per
aggregazione, le potenze di tutte le singole arti.
2. La critica alla teoria delle arti particolari
Il secondo movimento del paragrafo è la demolizione della teoria delle arti particolari, che Croce considera frutto di un errore materiale. Classificare le arti secondo i materiali impiegati – suoni, colori, parole, volumi – non ha fondamento estetico, ma solo tecnico. È un'operazione empirica, non spirituale.
Chiedere, ad esempio, quali immagini siano proprie della pittura e quali della musica, è per Croce come chiedere quali cose "meritino" un prezzo in base alla loro struttura molecolare: una domanda priva di senso filosofico, e fondata su un errore di categoria.
Croce prende qui di mira due illustri rappresentanti della teoria delle arti particolari:
• Lessing, con la sua distinzione tra poesia (azioni) e scultura (corpi);
• Wagner, con il progetto dell'opera d'arte totale (Gesamtkunstwerk), fondata sulla somma delle arti.
Entrambi, a modo loro, cadono nel medesimo equivoco: quello di pensare l'arte come somma di elementi eterogenei, e non come unità spirituale.
![]() Testo : 7,4
Testo : 7,4
Chi ha senso artistico, in un verso, in un piccolo verso di poeta, trova tutt'insieme musicalità e pittoricità e forza scultoria e struttura architettonica, e parimente in una pittura, la quale non è mai cosa d'occhi ma sempre di anima, e nell'anima non sta solo come colore, ma anche come suono e parola, perfino come silenzio, che è a suo modo suono e parola. Senonché, ove si provi ad afferrare separatamente quella musicalità e quel pittoresco e le altre cose, esse gli sfuggono e si tramutano l'una nell'altra, fondendosi nell'unità, comunque si usi separatamente chiamarle per modo di dire: cioè sperimenta che l'arte è una e non si divide in arti. Una, e insieme infinitamente varia; ma varia non già secondo i concetti tecnici delle arti, sibbene secondo l'infinita varietà delle personalità artistiche e dei loro stati d'animo.
Croce oppone a queste visioni la sua idea di unità dell'arte: chi ha senso poetico, ritrova in un solo verso la musicalità, la pittoricità, la scultoricità, persino l'architettura. E in una pittura, non c'è solo colore: vi sono anche parole, silenzi, ritmi, toni.
Ma se si tenta di separare questi elementi, essi si dissolvono. La loro distinzione è solo modale e linguistica, non reale. L'arte, nella sua verità, è una e indivisibile.
🔎 Note testuali
È questo uno dei passaggi teoricamente più pregnanti del pensiero crociano: la forma estetica non si definisce per il mezzo, ma per la qualità spirituale dell'intuizione. Le differenze tra le arti sono secondarie e descrittive, non essenziali. Ogni artista vero, al di là del mezzo usato, è artista nella totalità dello spirito.
3. L'infinita varietà delle espressioni non è varietà di arti
Croce chiarisce quindi che l'infinita varietà dell'arte non corrisponde alle "arti" in senso tecnico, ma alla molteplicità delle personalità artistiche e dei loro stati d'animo. L'arte non si divide in pittura, musica, scultura... ma si moltiplica in ogni artista, in ogni creazione come variazione irripetibile dello spirito.
🔎 Note testuali
Qui Croce opera una distinzione sottile ma fondamentale: tra unità strutturale dell'arte (come forma spirituale) e varietà espressiva dell'arte (come incarnazione di singole personalità). L'arte è una nel principio, molteplice nella manifestazione.
![]() Testo : 7,5
Testo : 7,5
A questa relazione e a questo scambio tra le creazioni artistiche e gli strumenti della comunicazione o «cose artistiche» è da riportare il problema riguardante il bello di natura. Lasciamo da parte la questione, che pur si affaccia in qualche estetico, se, oltre l'uomo, altri esseri siano in natura poetanti e artisti: questione che merita risposta affermativa, non solo per dovuto omaggio agli uccelli canterini, ma più ancora in virtù della concezione idealistica del mondo, che è tutto vita e spiritualità: se anche, come nella fiaba popolare, noi abbiamo smarrito quel fil d'erba che, messo in bocca, consentiva d'intendere le parole degli animali e delle piante. Per «bello di natura» si designano veramente persone, cose, luoghi, che per gli effetti loro sugli animi sono da accostare alla poesia, alla pittura, alla scultura e alle altre arti; e non c'è difficoltà di ammettere siffatte «cose artistiche naturali», perché il processo di comunicazione poetica, come si attua con oggetti artificialmente prodotti, così anche può attuarsi con oggetti naturalmente dati. La fantasia dell'innamorato crea la donna a lui bella e la impersona in Laura; la fantasia del pellegrino, il paesaggio incantevole o sublime e lo impersona nella scena di un lago o di una montagna; e queste creazioni poetiche si diffondono talvolta in più o meno larghi cerchi sociali, nel che è l'origine delle «bellezze professionali» femminili, da tutti ammirate, e dei «luoghi di veduta» famosi, dinanzi ai quali tutti si estasiano più o meno sinceramente.
4. Il "bello di natura" come creazione soggettiva
Nel finale del paragrafo, Croce affronta il tema – raramente trattato in modo così lucido – del cosiddetto "bello naturale". Che cosa intendiamo, si chiede, quando parliamo della bellezza di un paesaggio, di una donna, di un fiore?
Non certo una bellezza "oggettiva": si tratta sempre di creazioni poetiche soggettive, frutto di fantasia individuale che proietta su un dato naturale un'immagine estetica.
L'innamorato "crea" Laura, e la vede come bella; il viaggiatore "inventa" un paesaggio sublime, e lo sente come tale. Tali creazioni, in alcuni casi, si diffondono socialmente, generando "bellezze condivise": volti celebri, vedute famose, icone culturali.
Per Croce, il bello non è una qualità oggettiva e stabile delle cose, ma nasce dall'atto creativo e interpretativo dello spirito umano. Questo vale anche per il cosiddetto "bello di natura":
- La natura, di per sé, non è "bella" in modo assoluto e immutabile. Le sue forme e colori sono soggetti a cambiamenti, influenze culturali, mode, stati d'animo e percezioni personali.
- Il "bello di natura" è quindi labile, mutevole e soggettivo: ciò che oggi appare incantevole può domani essere percepito come banale o addirittura sgradevole.
- La bellezza naturale non ha la stessa durata e universalità delle opere d'arte, che sono creazioni spirituali autonome, dotate di una loro necessaria coerenza interna e di un significato autentico.
- Inoltre, mentre l'opera d'arte consente interpretazioni autentiche e profonde, la bellezza naturale è spesso soggetta a interpretazioni superficiali, mutevoli e contingenti.
🔎 Note testuali
Croce riconosce la realtà di questi fenomeni, ma ne precisa il carattere: si tratta di creazioni poetiche individuali, condivise e trasmesse, ma non dotate della stabilità e profondità dell'opera d'arte. Il bello naturale, in questo senso, è poesia soggettiva e labile.
Il bello di natura è per Croce un fenomeno instabile, soggettivo e mutevole, diverso dall'opera d'arte che è una creazione spirituale autonoma e duratura.
La percezione del bello naturale dipende da fattori contingenti e personali, come dimostra l'aneddoto della dama russa, che cambia idea sullo stesso paesaggio.
![]() Testo : 7,6
Testo : 7,6
Vero è che queste formazioni sono labili: la celia talvolta le dissipa, la sazietà le lascia cadere, il capriccio della moda le sostituisce; e, diversamente dalle opere artistiche, non consentono interpretazioni autentiche. Il golfo di Napoli, visto dall'alto di una delle più belle ville del Vomero, fu, dopo qualche anno d'indistornabile visione, dichiarato dalla dama russa che aveva acquistato quella villa, une cuvette bleue, così odioso nel suo azzurro inghirlandato di verde, da indurla a rivendere la villa. Anche l'immagine della cuvette bleue era, del resto, una creazione poetica, circa la quale non c'è luogo a disputare.
Esemplare – e sottilmente ironico – è l'aneddoto della dama russa che, stanca della celebre veduta del golfo di Napoli, finisce per vederla come una bacinella blu. Anche questa è, per Croce, una forma di immaginazione poetica, legittima, benché del tutto soggettiva e non intersoggettivamente verificabile.
👉 L'aneddoto della dama russa e la "cuvette bleue"
L'aneddoto racconta che una nobildonna russa, dopo aver acquistato una villa sul Vomero con vista sul golfo di Napoli, inizialmente affascinata dal panorama, con il tempo ne fu talmente stanca da definirlo "une cuvette bleue" (una bacinella blu), immagine che esprimeva un giudizio negativo e quasi di fastidio verso quel paesaggio che prima aveva tanto ammirato.
Questo esempio serve a mostrare come la percezione della natura, e quindi del suo "bello", possa cambiare radicalmente a seconda dell'esperienza soggettiva, della moda, della noia o del capriccio.
L'espressione "cuvette bleue" stessa è una creazione poetica, cioè un'immagine soggettiva e interpretativa, che non può essere contestata come "vera" o "falsa" in senso oggettivo, perché nasce dall'atto creativo del soggetto.
In altre parole, anche il giudizio estetico sulla natura è sempre un atto di creazione poetica e interpretazione, e non una semplice constatazione oggettiva.
🔎 Note testuali
La differenza fondamentale tra bello naturale e arte è qui: l'opera d'arte consente interpretazioni autentiche, mentre il bello naturale è soggetto al capriccio, alla moda, alla sazietà, alla celia. È questa la ragione per cui solo l'arte vera può fondare un'estetica rigorosa.
Postilla
Questo paragrafo è, come pochi altri nel saggio, un esempio perfetto della forza sistematica e al tempo stesso ironica della filosofia crociana. Vi si incrociano:
- la teoria dell'unità spirituale dell'arte,
- la confutazione delle classificazioni materialistiche,
- la dissoluzione dell'illusione oggettiva del bello naturale,
- la difesa di una concezione integralmente spirituale e soggettiva del fatto estetico.
Croce non solo pensa con rigore, ma scrive con finezza: i suoi esempi, le sue analogie, i suoi sberleffi colti (Lessing, Wagner, la dama russa…) costruiscono una prosa filosofica pungente, vivace, capace di argomentare e al tempo stesso sorridere.
![]() Testo : 8,1
Testo : 8,1
I GENERI LETTERARÎ E ARTISTICI E LE CATEGORIE ESTETICHE. — Assai maggiori e più deplorevoli conseguenze ha avute nella critica e nella storiografia letteraria e artistica una teoria di origine alquanto diversa ma analoga, quella dei generi letterarî e artistici. Anch'essa, come la precedente, ha per fondamento una classificazione, per sé presa, legittima e utile: quella, gli aggruppamenti tecnici o fisici degli oggetti artistici, essa le classificazioni che si fanno delle opere d'arte secondo il loro contenuto o motivo sentimentale, in opere tragiche, comiche, liriche, eroiche, amorose, idilliche, romanzesche, e via dividendo e suddividendo. È praticamente utile distribuire secondo queste classi le opere di un poeta nell'edizione che se ne fa, mettendo in un volume le liriche, in un altro i drammi, in un terzo i poemi, in un quarto i romanzi; ed è comodo, anzi indispensabile, richiamare con questi nomi le opere e i gruppi di opere nel discorrerne a voce e in iscritto.
Eccoci a un paragrafo capitale, che chiude idealmente la critica crociana a ogni forma di catalogazione esterna dell'arte: dopo aver smantellato la teoria delle "arti particolari" e del "bello naturale", Croce affronta ora le due classificazioni più radicate e perniciose, quelle dei generi letterari e delle categorie estetiche. Il tono è asciutto ma tagliente, e l'argomentazione unisce lucidità logica a grande esperienza storica.
1. I generi: da strumento pratico a vincolo paralizzante
Croce apre riconoscendo che i generi letterari, come i lirici, i tragici, i romanzeschi ecc., sono classificazioni empiriche legittime, e anzi spesso utili sul piano editoriale o comunicativo. Mettere in ordine i testi di un autore, distinguere liriche e drammi, facilitare la conversazione critica: questi sono scopi pratici per i quali i generi hanno senso.
![]() Testo : 8,2
Testo : 8,2
Ma anche qui è da dichiarare indebito e negare il trapasso da questi concetti classificatorî alle leggi estetiche della composizione e ai criterî estetici del giudizio; come si usa quando si vuol determinare che la tragedia debba avere tale o tale argomento, tale o tale qualità di personaggi, tale o tale andamento di azione, e tale o tale estensione; e dinanzi a un'opera, invece di cercare e giudicare la poesia che le è propria, si pone la domanda se essa sia tragedia o poema, e se ubbidisca alle «leggi» dell'uno o dell'altro «genere».
Ma – ed è qui il nodo – l'errore nasce nel momento in cui da queste classificazioni si vogliono trarre regole normative o criteri estetici di valutazione. Quando cioè si pretende che la tragedia "debba" avere certi personaggi o certi temi, o che un'opera vada giudicata in base alla sua aderenza a un canone esterno.
🔎 Note testuali
Croce distingue qui tra uso strumentale e uso normativo dei generi. Il primo è lecito, il secondo profondamente fuorviante. La vera arte, dice, sfugge a ogni codice. Il giudizio estetico deve valutare la poesia effettiva dell'opera, non la sua conformità a un'idea preconcetta.
![]() Testo : 8,3
Testo : 8,3
La critica letteraria del secolo decimonono deve i suoi grandi progressi in molta parte all'aver abbandonato i criterî dei generi, nei quali restarono quasi imprigionate la critica del Rinascimento e quella del classicismo francese, come comprovano le dispute che allora sorsero intorno alla Commedia di Dante e ai poemi dell'Ariosto e del Tasso, al Pastor fido del Guarini, al Cid del Corneille, ai drammi di Lope de Vega. Non pari vantaggio hanno tratto gli artisti dalla caduta di questi pregiudizî, perché, negati o ammessi che siano in teoria, sta di fatto che quegli che ha genio artistico passa attraverso tutti i vincoli di servitù, e anzi delle catene si fa strumento di forza; e colui che n'è scarso o privo, converte in nuova servitù la stessa libertà.
Egli ricorda come la critica del Rinascimento e del classicismo francese restò impigliata in questi schemi: basti pensare alle dispute su Dante (era la Commedia una tragedia?), su Ariosto, Tasso, Guarini, Corneille, Lope de Vega. La critica moderna, nel XIX secolo, ha fatto enormi progressi proprio abbandonando i vincoli dei generi.
🔎 Note testuali
Ma non sempre con successo. Croce osserva con ironia che il vero artista scavalca i generi anche quando ci crede, e l'artista mediocre li usa come stampelle. La libertà può essere insopportabile per chi non ha una forza interiore: anche il pregiudizio può diventare rifugio, o paradossalmente strumento.
![]() Testo : 8,4
Testo : 8,4
È parso che delle partizioni dei generi fosse da salvare, dandole valore filosofico, almeno una: quella di «lirica», «epica» e «drammatica», interpretandola come dei tre momenti del processo dell'oggettivazione, che dalla lirica, effusione dell'io, va all'epica, in cui l'io distacca da sé il sentire narrandolo, e da questa alla drammatica, in cui lascia che esso si foggi da sé i proprî portavoce, le dramatis personae. Ma la lirica non è effusione, non è grido o pianto, sì, invece, è essa stessa oggettivazione, per la quale l'io vede sé stesso in ispettacolo e si narra e si drammatizza; e questo spirito lirico forma la poesia dell'epos e del dramma, che, dunque, non si distinguono dalla prima se non in cose estrinseche. Un'opera che sia tutta poesia, come il Macbeth o l'Antonio e Cleopatra, è sostanzialmente una lirica, di cui i personaggi e le scene rappresentano i varî toni e le consecutive strofe.
2. Il falso fondamento teorico della triade lirica-epica-drammatica
Croce prende ora di mira anche l'unico tentativo filosofico di fondare i generi su un processo spirituale: la triade lirica, epica, drammatica, come tre momenti dell'oggettivazione dell'io. Questa visione era stata proposta da Schlegel, Hegel e altri idealisti romantici.
Ma Croce la smonta con decisione: anche la lirica, lungi dall'essere un puro "grido dell'anima", è già un atto di oggettivazione; anch'essa si rappresenta e si struttura; ogni vera lirica, infatti, contiene narrazione e dramma, e viceversa.
🔎 Note testuali
L'esempio del Macbeth o dell'Antonio e Cleopatra è magistrale: sono drammi, certo, ma sono anche liriche spirituali complesse, dove i personaggi e le scene sono strofe e tonalità di un'unica anima poetante. Tutta la distinzione dei generi è dunque esteriore, e non tocca l'essenza della poesia.
![]() Testo : 8,5
Testo : 8,5
Nelle vecchie Estetiche, e ancor oggi in quelle che ne continuano il tipo, si dava grande parte alle cosiddette categorie del bello: il sublime, il tragico, il comico, il grazioso, l'umoristico, e simili, che i filosofi, segnatamente tedeschi, non solo impresero a trattare a mo' di concetti filosofici (laddove sono semplici concetti psicologici ed empirici), ma svolsero con quella dialettica che spetta unicamente ai concetti puri o speculativi, cioè alle categorie filosofiche, onde si trastullarono a disporli in una serie di fantastico progresso, culminante ora nel Bello, ora nel Tragico, ora nell'Umoristico. Intendendo quei concetti per quello che si è detto che essi sono, è da notare la loro sostanziale rispondenza ai concetti dei generi letterarî ed artistici, dai quali in effetto, e principalmente dalle «istituzioni letterarie», si riversarono nella filosofia. In quanto concetti psicologici ed empirici, non appartengono all'Estetica, e nel loro complesso designano nient'altro che la totalità dei sentimenti (empiricamente distinti e raggruppati), che sono la perpetua materia della intuizione artistica.
3. Le categorie estetiche: un altro errore di impostazione
Croce affronta infine un altro tipo di classificazione, non più per genere o contenuto, ma per qualità "estetica" attribuita all'opera: il sublime, il tragico, il comico, il grazioso, l'umoristico.
Tali categorie sono spesso presentate come categorie filosofiche, ma Croce le ricolloca nel loro giusto ambito: sono concetti psicologici ed empirici, non concetti puri. Quando i filosofi (soprattutto tedeschi) hanno provato a disporle in serie dialettiche – da cui scaturirebbe il Bello, o l'Umorismo come vetta dello Spirito – hanno travisato completamente il loro statuto concettuale.
🔎 Note testuali
Le categorie del bello non sono né universali né necessarie, come lo sono le vere categorie filosofiche (es. essere, divenire, causa…). Sono invece tipi di sentimento che, in modo vario e mescolato, costituiscono la materia espressiva dell'intuizione artistica.
In altre parole: il comico, il sublime o il tragico non sono forme, ma coloriture dell'emozione. Possono coesistere, fondersi, contraddirsi. Non servono a definire un'opera, né a determinarne il valore. È la poesia che li utilizza, li attraversa, li trasforma.
Postilla
Con questo paragrafo Croce completa la sua decostruzione critica di ogni tentativo di "etichettare" l'arte, che sia in base a strumenti (arti particolari), generi (lirico, epico, comico…), o sentimenti dominanti (tragico, sublime...).
Il suo principio è sempre lo stesso: l'arte è un atto spirituale indivisibile, e ogni tentativo di fissarla in concetti esterni porta a una riduzione, a una maschera.
👉 I generi letterari sono convenzioni pratiche, non categorie estetiche.
👉 L'opera d'arte non ubbidisce a leggi di genere, ma solo a quella dell'intuizione-espressione.
👉 Anche la triade lirico-epico-drammatico non coglie la vera forma dell'opera.
👉 Le categorie del bello (comico, tragico, sublime…) sono psicologismi, non strumenti del pensiero estetico.
![]() Testo : 9,1
Testo : 9,1
RETORICA, GRAMMATICA E FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO. — Che ogni errore abbia un motivo di vero e nasca da un'arbitraria combinazione di cose per sé legittime, è confermato dall'esame che si faccia di altre dottrine erronee, le quali hanno tenuto gran campo in passato e ancor oggi ne tengono uno, se anche più ristretto. È perfettamente legittimo valersi, per l'insegnamento dello scrivere, di partizioni come quelle dello stile nudo e del figurato, della metafora e delle sue forme, e avvertire che in tal luogo giova parlar senza metafora e in tal altro per metafora, e che in tal altro la metafora adoperata è incoerente o è tirata troppo in lungo, e che qui converrebbe una figura di «preterizione» e colà una «iperbole» o una «ironia».
Con il paragrafo Retorica, grammatica e Filosofia del linguaggio, si chiude il nucleo teorico più serrato della Estetica crociana: dopo aver smontato le illusioni dei generi, delle arti particolari, del bello naturale e delle categorie estetiche, Croce prende di mira Retorica e Grammatica, mostrando come anche esse, da strumenti didattici legittimi, siano state indebitamente promosse a concetti fondanti della filosofia dell'arte. È un brano densissimo, e proprio per questo, anche molto stimolante.
1. Il punto di partenza: il valore pratico delle distinzioni retoriche
Croce parte da una concessione di buon senso: le categorie della retorica (nudo/figurato, metafora, ironia, preterizione ecc.) sono utili nell'ambito dell'insegnamento e dell'esercizio stilistico. È perfettamente legittimo osservare che in un certo contesto "giova parlar senza metafora" o che una figura retorica è "tirata troppo in lungo".
🔎 Note testuali
Croce ammette la retorica come ars docendi, strumento per aiutare a scrivere e parlare meglio. Il problema – ricorrente nel suo pensiero – è il passaggio da un uso empirico-didattico ad un uso filosofico-normativo.
È legittimo ricorrere a distinzioni come "stile nudo e figurato", "metafora", "iperbole", "ironia" ecc. nell'insegnamento della scrittura o nell'esercizio stilistico: queste categorie aiutano a migliorare la consapevolezza espressiva, a correggere errori, a suggerire alternative più efficaci o adatte al contesto. Per esempio, si può consigliare a uno studente di usare una metafora per rendere più vivace un passaggio, oppure di evitarla dove la chiarezza richiede uno stile diretto; si può criticare una metafora "tirata troppo in lungo" o suggerire l'uso di una figura come la preterizione o l'ironia per ottenere un certo effetto.
Tuttavia, occorre mettere in guardia dal trasformare queste distinzioni pratiche in teorie filosofiche sull'arte e sull'espressione. Quando si inizia a pensare che esistano forme "nude" (cioè semplici, spoglie, non figurate) e forme "ornate" (cioè arricchite da figure retoriche), o che si possa distinguere una forma "logica" (razionale, concettuale) da una "affettiva" (emotiva, lirica), si commette un errore di prospettiva: si trasporta la retorica, che è disciplina tecnica e pratica, nel cuore dell'estetica, che invece riguarda la natura e il valore dell'espressione artistica in sé.
![]() Testo : 9,2
Testo : 9,2
Ma quando si perde la coscienza dell'origine affatto didascalica e pratica di queste distinzioni, e filosofando si teorizza la forma come distinguibile in una forma «nuda» e in una forma «ornata», in una forma «logica» e in una forma «affettiva» e simili, si trasporta nel seno dell'Estetica la Retorica e si vizia il concetto genuino dell'espressione. La quale non è mai logica ma sempre affettiva ossia lirica e fantastica, ed è sempre, e per ciò stesso non è mai, metaforica, e perciò sempre propria; non è mai né nuda da doversi coprire, né ornata da doversi caricare di cose estranee, ma sempre risplendente di sé stessa, simplex munditiis.
Quando però si crede che esistano forme "nude" e forme "ornate", o si voglia distinguere una forma "logica" da una "affettiva", si finisce per snaturare il concetto stesso di espressione.
🔎 Note testuali
Non esistono espressioni "nude" da rivestire, né espressioni "ornate" da spogliare: l'espressione autentica "risplende di sé stessa, simplex munditiis". La metafora, la figura, l'ironia non sono accessori che si aggiungono dall'esterno, ma modi naturali e organici in cui l'espressione si realizza quando è davvero necessaria.
La formula oraziana simplex munditiis ("semplice nella sua eleganza") indica l'essenza autentica della vera espressione: non orpello, non ornamento aggiunto, ma splendore intrinseco. Ogni espressione bella risplende di se stessa, non abbisogna di ornamenti.
2. Espressione come forma unica e indivisibile
Per Croce non esiste forma logica o forma affettiva. Ogni vera espressione artistica è sempre lirica, affettiva, fantastica, metaforica, in quanto nasce da un'urgenza interiore e si manifesta come sintesi originale di sentimento e immagine. E poiché tutto è già metafora in senso lato, la distinzione tra "proprio" e "figurato" perde significato: ogni linguaggio vero è già poetico.
👉 Un testo "nudo", secondo la retorica privo di ornamenti, potrebbe essere: "Il sole sorge". Un testo "ornato" potrebbe essere: "Il sole, con dita di fuoco, solleva il sipario della notte". Ma per Croce, se la seconda espressione nasce davvero da una visione autentica e sentita, non è "ornata" in senso accessorio: è semplicemente l'espressione giusta di quell'intuizione.
👉 Una "forma logica" sarebbe un'espressione che mira solo alla chiarezza concettuale, una "forma affettiva" quella che mira a suscitare emozioni. Croce rifiuta questa distinzione: anche quella logica, per lui, è espressiva, e ogni espressione autentica coinvolge sempre sentimento e intuizione.
📌 Croce accetta le categorie retoriche come strumenti didattici, ma nega che abbiano valore ontologico o estetico. L'espressione autentica non è mai un fatto di "ornamento" o di "nudo", di "logico" o di "affettivo": è sempre una sintesi organica, in cui forma e contenuto, immagine e sentimento, sono inseparabili. L'arte, per Croce, è sempre "bella" perché è sempre espressione vera e necessaria, non perché rispetta o meno certe regole retoriche.
![]() Testo : 9,3
Testo : 9,3
Anche il pensiero logico, anche la scienza, in quanto si esprime si fa sentimento e fantasia: che è la ragione per la quale un libro di filosofia, di storia, di scienza può essere non solo vero ma bello, e a ogni modo vien giudicato non solo secondo logica ma anche secondo estetica, e si dice talvolta che un libro è sbagliato come teoria o come critica o come verità storica, ma rimane, per l'affetto che l'anima e che in esso si esprime, in qualità di opera d'arte. Quanto al motivo di vero che si travagliava nel fondo di questa distinzione di forma logica e forma metaforica, di dialettica e retorica, esso era il bisogno di costruire accanto alla scienza della Logica una scienza dell'Estetica; ma malamente ci si sforzava di distinguere le due scienze nel campo dell'espressione, che appartiene a una sola di esse.
Lo stesso vale per i testi scientifici o filosofici: pure lì, se l'opera è espressiva, sarà anche bella. Un trattato scientifico potrà anche essere errato come teoria, ma valido come opera d'arte se esprime un sentimento autentico.
📌 Anche il pensiero logico, la scienza e la filosofia, per manifestarsi e comunicare, devono necessariamente trasformarsi in espressione. E l'espressione, per Croce, non è mai un semplice veicolo neutro o meccanico: è sempre sentimento, fantasia, intuizione. Questo significa che anche un testo scientifico o filosofico, per essere compreso e apprezzato, deve coinvolgere l'anima, deve essere in qualche modo "vivo" e "creativo".
Croce spiega che il tentativo di separare nettamente la forma logica (tipica della scienza e della filosofia) dalla forma metaforica (tipica dell'arte e della retorica) nasceva dal bisogno di fondare una scienza della Logica accanto a una scienza dell'Estetica. Tuttavia, questa distinzione è mal posta, perché entrambe le forme appartengono a un'unica realtà: l'atto espressivo.
L'espressione è unitaria e indivisibile: non si può separare la logica dall'estetica nell'atto comunicativo, perché ogni espressione vera è insieme razionale e creativa, concettuale ed emotiva. La divisione tra logica e estetica è quindi superata: l'atto espressivo è unico e comprende entrambi gli aspetti.
📌 Croce qui abbatte una frontiera: non c'è arte senza pensiero, ma anche il pensiero, per manifestarsi, deve diventare espressione – e dunque sentimento, fantasia, intuizione. Egli qui addita la via per il superamento della separazione netta tra la sfera del pensiero "logico" e "scientifico" e quella dell'arte e dell'estetica, mostrando come esse siano invece profondamente intrecciate.
L'arte e il pensiero non vanno visti come mondi separati, ma come poli di un'unica realtà espressiva. Il pensiero, per diventare comunicazione viva e significativa, deve farsi espressione, cioè sentimento, fantasia e intuizione. Allo stesso modo, l'arte non è solo emozione, ma anche pensiero e logica. Questa sintesi è la chiave per comprendere la natura profonda dell'atto artistico e comunicativo secondo Croce.
![]() Testo : 9,4
Testo : 9,4
Per un bisogno non meno legittimo, in quell'altra parte della didascalica che è l'insegnamento delle lingue si prese sin dall'antichità a scindere le espressioni in periodi, proposizioni e parole, e le parole in varie classi, e in ciascuna ad analizzarle secondo le loro variazioni e composizioni in radicali e suffissi, in sillabe e in fonemi o lettere: dal che sono nati gli alfabeti, le grammatiche, i vocabolarî, come, analogamente, per la poesia si sono avute le arti metriche, e per la musica e le arti figurative e architettoniche, le grammatiche musicali, pittoriche, e via.
3. La grammatica come errore speculare: l'illusione dell'analisi
Nel secondo movimento del brano, Croce ripete lo stesso schema applicandolo alla grammatica: anche qui, si parte da un'analisi didattica (parole, sillabe, fonemi) necessaria per imparare una lingua, ma si arriva a confondere l'analisi con la realtà.
🔎 Note testuali
L'errore consiste nel credere che il linguaggio sia costruito da parole, e queste da sillabe, radici, suffissi… mentre è vero l'opposto: è il parlare il fatto primario, e le "parole" sono astrazioni successive, come i "preparati anatomici" nella medicina.
Croce insiste: la lingua è un organismo continuo, non una somma di elementi. La frantumazione grammaticale è un'operazione intellettuale a posteriori, non l'essenza dell'espressione.
![]() Testo : 9,5
Testo : 9,5
Senonché nemmeno gli antichi riuscirono a evitare che altresì in questa parte si compiesse uno di quegli indebiti transiti ab intellectu ad rem, dalle astrazioni alla realtà, dall'empiria alla filosofia, che abbiamo osservati negli altri casi; e in questo si venne a concepire il parlare come aggregazione di parole e le parole come aggregazione di sillabe o di radici e suffissi: laddove il prius è appunto il parlare come un continuum, simile a un organismo, e le parole e le sillabe e le radici sono il posterius, il preparato anatomico, il prodotto dell'intelletto astraente e non punto il fatto originario e reale.
4. L'errore filosofico: la frattura tra espressione e mezzi
La combinazione tra retorica e grammatica ha generato, dice Croce, l'illusione che esistano i "mezzi" dell'espressione, come se potessero esistere indipendentemente dall'espressione stessa. Ma questa è una falsa duplicazione.
🔎 Note testuali
I "mezzi dell'espressione" sono l'espressione. Il pittore non "usa" il colore come mezzo: il colore, nella sua forma espressiva, è già l'opera. Ogni tentativo di separare forma e mezzo porta a una visione falsa e meccanica dell'arte.
![]() Testo : 9,6
Testo : 9,6
Trasportata la Grammatica al pari della Retorica nel seno dell'Estetica, ne è venuto uno sdoppiamento tra «espressione» e «mezzi» dell'espressione, che è poi un reduplicamento, perché i mezzi dell'espressione sono l'espressione stessa, frantumata dai grammatici. Questo errore, combinandosi con l'altro di una forma «nuda» e di una forma «ornata», ha impedito di vedere che la Filosofia del linguaggio non è una Grammatica filosofica, ma sta di là da ogni grammatica, e non rende filosofiche le classi grammaticali, ma le ignora, e, quando se le trova contro, le distrugge, e che, insomma, la Filosofia del linguaggio fa tutt'uno con la Filosofia della poesia e dell'arte, con la scienza dell'intuizione-espressione, con l'Estetica, la quale abbraccia il linguaggio nella sua intera estensione, che comprende il linguaggio fonico e articolato, e nella sua intatta realtà, che è l'espressione viva e di senso compiuto.
Croce critica l'idea, diffusa nella tradizione grammaticale e retorica, secondo cui esisterebbe una distinzione tra l'"espressione" (il contenuto creativo, vivo, dell'atto linguistico) e i "mezzi dell'espressione" (le parole, le regole, le strutture grammaticali). Secondo la prospettiva grammaticale, infatti, si potrebbe separare ciò che si vuole dire (il pensiero, il sentimento) dai mezzi tecnici con cui lo si esprime (la lingua, le sue regole, le sue categorie).
Per Croce questa distinzione è un errore: i mezzi dell'espressione sono l'espressione stessa, e separarli significa "frantumare" l'unità vivente dell'atto espressivo. La grammatica, nel tentativo di classificare e normare, riduce l'espressione a un insieme di parti astratte, perdendo di vista la realtà viva e indivisibile dell'atto linguistico.
👉 Pensare che la parola "amore" sia solo un mezzo per esprimere un sentimento che esiste già "dentro" e che viene poi rivestito di parole è, per Croce, un errore. L'atto di dire "amore", in un contesto concreto, è già di per sé espressione e creazione di quel sentimento: non c'è un "contenuto" separato dai "mezzi".
5. La filosofia del linguaggio come estetica
Nel finale, Croce riafferma un punto centrale: la filosofia del linguaggio non coincide con una grammatica filosofica, e non rende "filosofiche" le classi grammaticali: le ignora, o le distrugge.
Per lui, la filosofia del linguaggio coincide con l'Estetica, cioè con la scienza dell'intuizione-espressione: il linguaggio, in tutta la sua estensione (sia fonico e articolato, sia scritto, sia poetico, sia prosastico), è sempre espressione, cioè atto creativo, non semplice applicazione di regole. La grammatica, invece, è una disciplina pratica, utile per l'insegnamento e la comunicazione, ma non coglie la natura profonda e originaria del linguaggio.
🔎 Note testuali
La vera filosofia del linguaggio coincide con la filosofia dell'espressione, cioè con l'Estetica. Non si occupa di categorie analitiche (soggetto, predicato, complemento...), ma della pienezza dell'espressione viva, dell'intuitus che si fa parola.
In questa prospettiva, Croce arriva a identificare il linguaggio con l'arte: ogni atto linguistico è, in sé, un atto espressivo e creativo, analogo all'atto artistico. La differenza tra linguaggio comune e linguaggio poetico, secondo lui, è solo quantitativa, non qualitativa: entrambi sono atti di espressione, anche se solo alcuni raggiungono il livello dell'arte.
📌 Croce rifiuta la subordinazione dell'Estetica e della filosofia del linguaggio alla Grammatica e alla Retorica. L'atto linguistico è sempre espressione viva, non la somma di un contenuto e dei suoi "mezzi". La filosofia del linguaggio è, per Croce, filosofia dell'espressione e coincide con l'Estetica, abbracciando il linguaggio in tutta la sua realtà creativa e indivisibile. Le categorie grammaticali sono utili solo come strumenti pratici, ma non spiegano la vera natura del linguaggio.
Postilla
Con questo paragrafo, Croce completa la sua demolizione di ogni visione meccanica, didascalica o intellettualistica dell'arte. L'espressione non è mai l'effetto di regole, né si scompone in parti. L'arte è atto indiviso, lirico, primario, e tutte le classificazioni – retoriche, grammaticali, stilistiche – sono astrazioni successive, utili forse nella scuola, ma devastanti per la filosofia dell'arte.
🔎 Note testuali
• La retorica e la grammatica sono strumenti pratici, ma non hanno valore estetico.
• Non esiste una distinzione tra forma "nuda" e "ornata": ogni vera espressione è completa e viva in sé.
• Le "parole" non sono i mattoni del linguaggio, ma sue astrazioni retrospettive.
• Non esistono "mezzi" dell'espressione separabili dall'espressione stessa.
• La filosofia del linguaggio coincide con l'Estetica, intesa come scienza dell'intuizione-espressione.
![]() Testo : 10,1
Testo : 10,1
CLASSICITÀ E ROMANTICISMO. — I problemi che abbiamo ricordati appartengono piuttosto al passato, a un secolare passato, che non al presente, in cui delle loro fallaci posizioni e delle loro erronee soluzioni restano quasi soltanto stanche abitudini, e nei libri scolastici piuttosto che nella comune coscienza e cultura. Tuttavia bisogna fare molta attenzione a sempre tagliare e svellere le propaggini che i vecchi tronchi non lasciano di metter fuori di tempo in tempo, com'è al tempo nostro la teoria degli stili applicata alla storiografia artistica (Wölfflin e altri), ed estesa alla storia della poesia (Strich e altri), nuova invasione di astrattezze retoriche nel giudizio e nella storia delle opere d'arte.
Eccoci arrivati al culmine polemico e al punto forse più profetico dell'intera Estetica crociana: la riflessione su Classicità e Romanticismo non è più un semplice nodo storico-letterario, ma si trasforma in una diagnosi filosofica e morale del presente, e insieme in un grido d'allarme contro la dissoluzione dell'arte come forma dello spirito.
1. Dalle vecchie illusioni alle moderne deviazioni
Croce apre questo paragrafo ricordando che i problemi analizzati finora (generi, retorica, grammatica…) appartengono ormai al passato scolastico, a un patrimonio di dottrine superate. Tuttavia, le loro propaggini rispuntano ancora, sotto nuove forme.
La teoria degli "stili" in storia dell'arte (Wölfflin, Strich) ne è un esempio. Secondo lui, questi tentativi di classificare l'arte per categorie astratte (barocco, classicismo, manierismo...) ricadono in un vizio retorico, estraneo all'essenza spirituale e individuale dell'espressione artistica.
Croce vede in queste teorie una sorta di "propaggine" di vecchie concezioni meccanicistiche e positivistiche, che cercano di spiegare l'arte con schemi fissi e rigidi, senza coglierne la vitalità e la profondità. Egli invita a "tagliare e svellere" queste tendenze, per mantenere l'estetica come scienza dell'intuizione e dell'espressione, capace di abbracciare l'arte nella sua totalità e unità.
🔎 Note testuali
Heinrich Wölfflin, storico dell'arte svizzero, è noto per aver elaborato un metodo analitico basato su categorie formali per descrivere e distinguere gli stili artistici (ad esempio, la contrapposizione tra Rinascimento e Barocco). Le sue cinque coppie di concetti fondamentali (lineare-pittorico, superficie-profondità, forma chiusa-forma aperta, molteplicità-unità, chiarezza assoluta-chiarezza relativa) mirano a individuare schemi visivi e formali ricorrenti nelle opere d'arte, indipendentemente dal contenuto o dall'autore.
Analogamente, Strich ha applicato simili approcci stilistici anche alla storia della poesia, cercando di classificare le opere secondo categorie formali.
L'analisi di Wölfflin, secondo Croce, rischia di ridurre l'opera d'arte a un insieme di "forme" da classificare e confrontare, perdendo di vista la sua natura spirituale e creativa. Questo è ciò che Croce chiama "astrattezze retoriche": categorie che, pur utili in ambito didattico o descrittivo, non possono diventare criteri filosofici o critici per giudicare l'arte.
![]() Testo : 10,2
Testo : 10,2
Ma il problema principale del tempo nostro, che l'Estetica deve dominare, è quello che si ricongiunge alla crisi nell'arte e nel giudizio dell'arte, che si produsse nell'età romantica. Non già che di quella crisi non sia dato indicare nelle età anteriori alcuni precedenti e casi simili, come nell'antichità l'arte ellenistica e la letteratura degli ultimi secoli di Roma, e, nei tempi moderni, l'arte e la poesia barocca, seguite a quelle del Rinascimento. Ma nell'età romantica la crisi ebbe, con proprie motivazioni e propria fisionomia, ben altra grandiosità, ponendo a contrasto poesia ingenua e poesia sentimentale, arte classica e arte romantica, dividendo, mercé questi concetti, l'unica arte in due arti intimamente diverse, e parteggiando per la seconda, come quella conforme ai tempi moderni, col rivendicare in arte il diritto primario del sentimento e della passione e dell'immaginazione.
2. Il vero problema attuale: l'eredità del Romanticismo
Il cuore del brano è qui. Croce individua nel Romanticismo la vera frattura da cui origina la crisi moderna dell'arte. Non che che crisi simili non si fossero già manifestate in epoche precedenti – come nell'arte ellenistica, nel Barocco o nella tarda letteratura romana – ma il Romanticismo ha dato a questa crisi una dimensione nuova e più profonda, con motivazioni e forme proprie.
Nel Romanticismo si afferma un contrasto netto tra poesia ingenua e poesia sentimentale, tra arte classica e arte romantica. Questa divisione ha portato a concepire l'arte non più come un'unica realtà spirituale e sintetica, ma come due arti "intimamente diverse", quasi opposte.
Croce considera questa separazione un'"eresia tedesca", un errore che ha diviso l'arte in due e ha portato a un giudizio estetico frammentato e contraddittorio. Egli ritiene che:
- L'arte non possa essere divisa in "due arti" diverse, perché essa è sempre un atto unitario di intuizione ed espressione.
- Il sentimento romantico, inteso come immediata espressione passionale, non coincide con il vero sentimento estetico, che è sempre "sentimento contemplato", cioè meditato, sintetico, trasformato in forma.
- Il Romanticismo ha avuto il merito di ribellarsi a un classicismo freddo e privo di vita, ma ha anche esagerato, portando a uno squilibrio verso l'immediatezza e la frammentarietà.
🔎 Note testuali
• L'arte classica rappresenta l'arte della sintesi, dell'armonia, della forma chiara e definita, in cui sentimento e intuizione si fondono in un'unica espressione equilibrata e universale. È l'arte che esprime la "purezza" dell'intuizione e della forma, tipica del Rinascimento e dell'Antichità classica.
• L'arte romantica, invece, pone al centro il sentimento, la passione, l'immaginazione come elementi primari e autonomi. Il Romanticismo rivendica il diritto dell'arte di esprimere l'interiorità, l'io, le emozioni immediate, spesso attraverso forme meno rigorose, più frammentarie, "vaporose" e indeterminate.
![]() Testo : 10,3
Testo : 10,3
Per un verso, era questa una reazione giustificata contro la letteratura razionalistica e classicistica di stampo francese, ora satirica ora frivola, povera di sentimento e di fantasia, destituita di profondo senso poetico; ma, per un altro verso, il romanticismo era ribellione non contro il classicismo, ma contro la classicità stessa, contro l'idea della serenità e infinità dell'immagine artistica, contro la catarsi e a favore della torbida passionalità, indocile e recalcitrante alla purificazione. Il che comprese benissimo il Goethe, poeta di passione e insieme di serenità, e, come tale, e perché poeta, classico; il quale si pronunciò avverso alla poesia romantica, considerandola «poesia da ospedale».
La contrapposizione tra "poesia ingenua" e "poesia sentimentale", tra arte classica e arte romantica, ha prodotto una divisione interna all'arte, elevando l'immediatezza affettiva e passionale a principio estetico, fino ad arrivare alla confusione tra arte e vita.
Il Romanticismo, scrive Croce, non è solo una reazione contro il razionalismo arido del classicismo francese – il che sarebbe anche giustificato –, ma è anche una ribellione alla classicità stessa, cioè alla concezione dell'arte come immagine pacata, serena, purificata della realtà.
Questa crisi ha segnato la storia dell'arte e della critica, portando a:
- Una polarizzazione tra forme e contenuti, con la tendenza a privilegiare o il sentimento o la forma, l'io o l'armonia.
- Una confusione nel giudizio estetico, che spesso si basa su categorie rigide e contrapposte (classico vs romantico, ingenuo vs sentimentale).
- La necessità, per Croce, di superare questa divisione, recuperando l'unità dell'arte come espressione sintetica e universale.
La crisi romantica, secondo Croce, ha posto un problema centrale all'estetica: come riconciliare la dimensione passionale e soggettiva dell'arte con la sua dimensione formale, universale e sintetica. La risposta crociana è che l'arte è sempre un atto unitario di intuizione-espressione, in cui sentimento e forma non sono separabili, bensì momenti di una stessa realtà spirituale.
🔎 Note testuali
Croce condivide l'avversione goethiana per una poesia "da ospedale", tutta travaglio e turbamento, senza sintesi né catarsi. Goethe – poeta di passione ma anche di forma – resta per Croce l'emblema di un'arte spiritualmente classica, capace di trasfigurare la vita, non semplicemente di registrarla.
![]() Testo : 10,4
Testo : 10,4
Più tardi si credette che la malattia avesse compiuto il suo corso e il romanticismo fosse trapassato; ma passati erano certi suoi contenuti e certe sue forme, e non già l'anima sua, la quale stava tutta in questo squilibrio dell'arte verso l'immediata espressione delle passioni e delle impressioni. Mutò dunque nome, ma continuò a vivere e operare: si chiamò «realismo», «verismo», «simbolismo», «stile artistico», «impressionismo», «sensualismo», «immaginismo», «decadentismo», e si chiama ai nostri giorni, nelle sue forme estreme, «espressionismo» e «futurismo».
3. Dal Romanticismo alle avanguardie: il travestimento della crisi
La diagnosi si fa più acuta: il Romanticismo non è affatto superato. Ha solo cambiato nome: Realismo, Verismo, Simbolismo, Impressionismo, Decadentismo, Espressionismo, Futurismo.
🔎 Note testuali
In tutte queste correnti Croce coglie un tratto comune: l'eccedenza del sentimento sull'idea, l'immediatezza dell'impulso sull'elaborazione spirituale, la rinuncia alla forma a favore del grido, del gesto, dell'istante.
Tutto questo porta, a suo dire, alla dissoluzione del concetto stesso di arte, a favore di qualcosa che arte non è: una sorta di vitalismo gesticolante, che non sublima la vita nella contemplazione, ma si limita a prolungarla nell'urlo, nel colore, nello shock.
![]() Testo : 10,5
Testo : 10,5
Il concetto stesso dell'arte viene scosso in queste dottrine, che tendono a sostituirlo con quello della non-arte, di una o altra specie; e che la lotta sia contro l'arte è confermato dall'aborrimento che nell'estrema ala di questa scuola si manifesta verso i musei e le biblioteche, verso tutta l'arte del passato, cioè verso l'idea dell'arte, che esistenzialmente coincide con l'arte che si è storicamente attuata. I legami di questo movimento, nella sua guisa odierna, con l'industrialismo e con la psicologia che esso favorisce e promuove, sono evidenti: il diverso dell'arte è la vita pratica, quale modernamente si vive; e l'arte non vuol essere già l'espressione e perciò il superamento di codesta vita nell'infinito e universale della contemplazione, ma anzi la parte gridante e gesticolante e sprizzante colori della vita medesima.
4. L'arte come antitesi della vita pratica: il nodo teorico
Qui si tocca un punto cardine del pensiero crociano:
- La vita pratica è azione, immediatezza, urgenza.
- L'arte è contemplazione, distacco, sintesi.
L'errore delle avanguardie, secondo Croce, sta nel voler fare dell'arte un prolungamento diretto della vita pratica, "gridante e gesticolante e sprizzante colori", invece che una forma spirituale di elaborazione e superamento.
🔎 Note testuali
Il legame con l'"industrialismo" è emblematico: la civiltà moderna tende a livellare tutto sull'utile e sull'effimero, e così produce anche un'estetica fondata sull'impatto, sull'istantaneità, sull'eccitazione sensoriale, non sulla forma pensata e spiritualmente compiuta.
![]() Testo : 10,6
Testo : 10,6
Come è naturale, d'altro lato, i poeti e gli artisti che siano veramente tali, rari sempre in ogni tempo, continuano oggi come sempre a lavorare secondo l'antica e unica idea dell'arte, a esprimere il loro sentire in forme armoniche, e gli intendenti d'arte (anch'essi più rari che non si pensi) continuano a giudicare secondo quell'idea. Ma ciò non toglie che la tendenza a distruggere l'idea dell'arte sia un tratto caratteristico dei tempi nostri, e che questa tendenza prenda origine dal proton pseudos che confonde l'espressione spirituale o estetica con l'espressione naturale o pratica, quel che tumultuando passa attraverso i sensi e prorompe dai sensi con quel che l'arte elabora, costruisce, disegna, colora e plasma, e che è la sua creatura bella.
5. Ma l'arte non muore: resistenza e minoranza
Croce non è disperato: gli artisti veri esistono, e continuano a creare nel solco dell'arte classica, anche oggi. Sono pochi, come sempre. E anche i veri intenditori sono pochi.
Ma resta vitale anche la tendenza a "distruggere l'idea dell'arte", scaturente dal "proton pseudos", dall'errore cioè di confondere l'espressione spirituale o estetica con l'espressione naturale o pratica.
🔎 Note testuali
L'espressione greca "proton pseudos" significa letteralmente "il primo falso" o "l'errore originario". Croce la usa per indicare quella radice di errore o di confusione da cui derivano molte delle storture e delle crisi nella concezione dell'arte nei tempi moderni.
Secondo Croce, la tendenza a distruggere o a svuotare di senso l'idea stessa di arte nasce proprio da questa confusione tra i due tipi di espressione. Quando si scambia l'arte con un semplice sfogo naturale o pratico, si nega la sua specificità e la sua dignità come forma di espressione spirituale e sintetica.
👉 Espressione spirituale vs espressione naturale/pratica
• Espressione spirituale o estetica: è l'atto creativo e sintetico dell'arte, che elabora, plasma, costruisce forme nuove, belle e significative. È un processo interiore e intellettuale, che trasforma la materia in opera d'arte, dando vita a qualcosa di unico e originale.
• Espressione naturale o pratica: è ciò che "tumultuando passa attraverso i sensi e prorompe dai sensi", cioè le manifestazioni immediate, spontanee, non elaborate della natura o della vita pratica. È l'espressione grezza, non mediata, che si manifesta direttamente nei fenomeni sensibili o nelle azioni quotidiane.
Questo errore è, per Croce, un lascito perverso del romanticismo ideologico, che ha enfatizzato il sentimento e la passione immediata fino a farli coincidere con l'arte stessa, dimenticando che l'arte è un'opera di elaborazione, di forma, di bellezza costruita.
Le conseguenze di questa confusione sono che:
- Si svaluta l'arte come attività creativa e raffinata, riducendola a mera espressione naturale o emotiva.
- Si perde la consapevolezza che l'arte è una creatura bella, cioè un prodotto costruito e plasmato dallo spirito, dotato di forma e significato.
- Si genera una crisi dell'estetica e del giudizio artistico, che porta a relativismi e a dissoluzioni del concetto stesso di arte.
![]() Testo : 10,7
Testo : 10,7
Il problema attuale dell'Estetica è la restaurazione e difesa della classicità contro il romanticismo, del momento sintetico e formale e teoretico, in cui è il proprio dell'arte, contro quello affettivo, che l'arte ha per istituto di risolvere in sé, e che ai nostri giorni le si rivolta contro e cerca di usurparne il posto. Certamente, portae Inferi non praevalebunt contro l'inesauribile fattività dello spirito creatore; ma lo sforzo di ottener quella prevalenza conturba, per intanto, il giudizio dell'arte, la vita dell'arte, e, in corrispondenza, la vita intellettuale e morale.
La forza dell'arte, in sé, non è scalfita. Portae Inferi non praevalebunt (le porte degli inferi non prevarranno), dice Croce evocando il Vangelo di Matteo: l'arte non può morire, perché è una funzione eterna dello spirito umano.Tuttavia, la confusione tra espressione estetica e espressione naturale continua a minare la cultura, a sviare la critica, e a produrre una diseducazione del gusto, una decadenza non dell'arte in sé, ma della coscienza estetica e della stessa vita morale.
Postilla
Con questo paragrafo, Croce propone un vero manifesto della classicità spirituale, in opposizione non tanto al Romanticismo come epoca, quanto al suo residuo ideologico, che sopravvive in molte forme dell'estetica moderna.
🔎 Note testuali
• Il Romanticismo ha prodotto una crisi del giudizio artistico, elevando il sentimento immediato a principio estetico.
• Questa crisi è continuata sotto altre forme: realismo, simbolismo, futurismo...
• Si assiste oggi a una tendenza alla dissoluzione dell'arte, che viene confusa con la vita pratica e sensoriale.
• L'Estetica ha il compito di difendere l'arte come espressione spirituale, contro l'invasione del vitalismo cieco.
• Il vero artista continua a creare nell'armonia della forma, al di là delle mode e delle correnti.
![]() Testo : 11,1
Testo : 11,1
LA CRITICA E LA STORIOGRAFIA ARTISTICO-LETTERARIA. — Un altro gruppo di questioni che si trovano nei trattati di Estetica, sebbene vi siano opportunamente unite, appartengono, nel loro intrinseco, alla Logica e alla teoria della storiografia. Sono quelle riguardanti il giudizio estetico e la storia della poesia e delle arti. L'Estetica, col dimostrare che l'attività estetica o l'arte è una delle forme dello spirito, è un valore, una categoria, o come altro si voglia chiamarla, e non (come si è pensato da teorizzatori di varia scuola) un concetto empirico riferibile a certi ordini di fatti utilitarî o misti, con lo stabilire l'autonomia del valore estetico, ha con ciò stesso dimostrato e stabilito, che essa è predicato di uno speciale giudizio, il giudizio estetico, ed è argomento di storia, di una storia speciale, la storia della poesia e delle arti, la storiografia artistico-letteraria.
Eccoci giunti al nodo conclusivo dell'Estetica di Croce: la riflessione sulla critica e sulla storiografia artistico-letteraria, che fa da ponte tra la teoria dell'arte e la prassi del giudizio e della narrazione storica delle opere. Questo brano è densissimo, e merita di essere articolato passo a passo, coerentemente con il registro logico-ermeneutico adottato qui dallo stesso autore.
1. Estetica, Logica e Storiografia: distinzioni e legami
Croce apre notando che molte questioni solitamente trattate nei manuali di Estetica, in realtà appartengono più propriamente alla Logica e alla Teoria della Storia, poiché riguardano:
- il giudizio estetico
- e la storia dell'arte e della poesia.
![]() Testo : 11,2
Testo : 11,2
Le questioni, che si sono agitate intorno al giudizio estetico e alla storiografia artistico-letteraria, si ritrovano, pur avuto riguardo al carattere proprio dell'arte, sostanzialmente le medesime questioni metodologiche che s'incontrano in tutti i campi della storiografia.
Ciò non toglie che sia l'Estetica a porre le basi corrette per queste pratiche:
- essa riconosce all'arte una forma autonoma dello spirito, dunque un valore in sé, che non può essere ridotto né al piacere, né all'utile, né ad altri fini pratici o morali;
- e da ciò deriva che si possa fondare un giudizio estetico autonomo e una storiografia propria, specifica della poesia e dell'arte.
![]() Testo : 11,3
Testo : 11,3
Si è domandato se il giudizio estetico sia assoluto o relativo; ma ogni giudizio storico (e tale è il giudizio estetico che afferma la realtà e qualità dei fatti estetici), è sempre assoluto e relativo insieme: assoluto, in quanto la categoria con la quale si costruisce è di universale verità; relativo, in quanto l'oggetto, da essa costruito, è storicamente condizionato; onde nel giudizio storico la categoria s'individualizza e l'individualità si assolutizza. Coloro che in passato negavano l'assolutezza del giudizio estetico (estetici sensisti, edonisti, utilitarî) negavano, in effetto, la qualità e realtà dell'arte, la sua autonomia.
2. Il giudizio estetico: assoluto o relativo?
Un primo nodo è il seguente: Il giudizio estetico è assoluto o relativo?
Croce risponde: è entrambi, perché:
- è assoluto, in quanto basato su una categoria universale dello spirito (la forma estetica);
- ma è relativo, in quanto l'opera nasce in un tempo determinato e riflette una situazione storica.
Dunque, come ogni giudizio storico, anche quello estetico assolutizza l'individuale e storicizza l'universale: è un atto spirituale che unisce struttura e contenuto, forma e contesto, in una sintesi concreta.
🔎 Note testuali
Croce respinge tanto l'assolutismo estetista, che isola l'opera dal suo tempo, quanto il relativismo storicista, che la dissolve nelle condizioni esterne (biografia dell'autore, società, economia, ecc.).
![]() Testo : 11,4
Testo : 11,4
Si è domandato se la cognizione dei tempi, cioè di tutta la storia di un dato momento, sia necessaria pel giudizio estetico; e certamente è necessaria, perché, come sappiamo, la creazione poetica presuppone tutto l'altro spirito che essa converte in immagine lirica, e la creazione estetica singola, tutte le altre creazioni di un dato momento storico (passioni, sentimenti, costumi ecc.).
3. Giudicare un'opera senza il suo contesto? No. Ma nemmeno scioglierla nel contesto.
Altra questione:
È necessario conoscere il contesto storico per giudicare un'opera d'arte?
Risposta: sì, perché l'arte è sempre elaborazione di tutto ciò che lo spirito vive in quel momento storico: affetti, costumi, visioni del mondo. Ma il punto di arrivo non è la società, è l'immagine poetica, l'elaborazione artistica che da quella materia trae forma.
![]() Testo : 11,5
Testo : 11,5
Da ciò si vede come errino del pari gli opposti sostenitori di un mero giudizio storico dell'arte (storicisti) e di un mero giudizio estetico (estetisti); perché i primi vogliono vedere nell'arte tutte le altre storie (condizioni sociali, biografia dell'autore, ecc.) e non, insieme e sopra tutte, quella che è propria dell'arte, e i secondi vogliono giudicare l'opera d'arte fuori della storia, cioè privandola del suo senso genuino, e dandogliene uno di fantasia o commisurandola ad arbitrarî modelli.
Croce critica:
- gli storicisti, che vedono nelle opere solo "documenti" sociali, e non espressioni individuali;
- e gli estetisti, che ignorano la storia e giudicano secondo modelli arbitrari.
![]() Testo : 11,6
Testo : 11,6
Infine, si è manifestata una sorta di scetticismo sulla possibilità di entrare in relazione d'intendimento con l'arte del passato: scetticismo che, in tal caso, si dovrebbe allargare a ogni altra parte di storia (a quella del pensiero, della politica, della religione, della moralità), e che si confuta da sé con la riduzione all'assurdo, perché anche l'arte e la storia che si dice moderna o del presente è «passata», al modo di quella delle età più remote, e si rifà presente, al modo di quella, solo nell'animo che la risente e nell'intelligenza che la comprende.
4. Comprendere l'arte del passato: si può?
Terzo interrogativo:
È possibile capire l'arte di epoche lontane dalla nostra?
Risposta: sì, nella misura in cui la riviviamo spiritualmente. Quando mancano in noi le condizioni interiori per questa risonanza, non è colpa dell'opera, ma nostra, così come capita di non capire un'azione politica o una dottrina religiosa remota.
![]() Testo : 11,7
Testo : 11,7
Che poi ci siano opere ed età artistiche che ci rimangono oscure, non vuol dire altro se non che mancano attualmente in noi le condizioni di riviverle interiormente e di intenderle, come ci mancano per le idee e i costumi e le azioni di tanti popoli ed età. L'umanità, come l'individuo, ricorda alcune cose e ne dimentica molte altre, salvo a rinnovarne in sé il ricordo, quando a ciò la porta il corso dello svolgimento spirituale.
![]() Testo : 11,8
Testo : 11,8
Un'ultima questione concerne la forma che conviene alla storia artistico-letteraria, la quale, nel tipo formatosi principalmente nell'età romantica e che ancor oggi prevale, espone la storia delle opere d'arte in funzione dei concetti e dei bisogni sociali delle varie epoche, come loro espressioni estetiche, legandole strettamente alla storia civile: il che mena a trascurare, e quasi a soffocare, l'accento proprio e individuale delle opere d'arte, quello che le fa opere d'arte, inconfondibili l'una con l'altra, e a trattarle come documenti di vita sociale.
5. Come si scrive la storia della letteratura e dell'arte?
E qui viene la stoccata più vibrante.
Croce critica il modello prevalente di storiografia romantica, che:
- lega le opere ai bisogni e alle ideologie dell'epoca,
- e le interpreta come documenti sociali, anziché come creazioni spirituali autonome.
Così facendo, si annulla l'individualità dell'opera, la sua forma unica, la sua essenza poetica.
![]() Testo : 11,9
Testo : 11,9
Vero è che, in pratica, questo metodo è contemperato dall'altro, che si potrebbe dire «individualizzante» e che dà rilievo al carattere proprio delle singole opere; ma il contemperamento ha il vizio di ogni sorta di eclettismo.
6. La storiografia vera: individualizzante, non eclettica
Croce ammette che spesso si cercano equilibri tra i due approcci (sociale e individuale), ma questi compromessi sono sempre eclettici e inefficaci.
![]() Testo : 11,10
Testo : 11,10
Per uscire da questo, non c'è altro partito che svolgere in modo conseguente la storia individualizzante e trattare le opere d'arte non in relazione alla storia sociale, ma ciascuna come un mondo a sé, in cui confluisce di volta in volta tutta la storia, trasfigurata e sorpassata, per virtù della fantasia, nell'individualità dell'opera poetica, la quale è una creazione e non un riflesso, un monumento e non un documento.
- trattare ogni opera come un mondo a sé, come creazione irriducibile e originale, in cui tutta la storia confluisce e viene trasfigurata dalla fantasia.
È solo allora che l'opera diventa "monumento" e non semplice "documento".
![]() Testo : 11,11
Testo : 11,11
Dante non è soltanto un documento del medio evo, né Shakespeare un documento dell'età elisabettiana, nel quale ufficio documentario essi hanno molti altri pari o più abbondevoli d'informazioni tra i cattivi poeti e i non-poeti.
Dante non è solo un documento del Medioevo, né Shakespeare dell'Inghilterra elisabettiana: altrimenti basterebbero gli scrittori minori, ben più ricchi di dettagli storici, per "capire" quelle epoche!
![]() Testo : 11,12
Testo : 11,12
È stato obiettato che, con questo metodo, la storia artistico-letteraria si configura in una serie di saggi e monografie, senza nesso tra loro; ma è chiaro che il nesso è dato da tutta la storia umana, della quale le personalità poetiche sono parte e parte assai cospicua (l'avvenimento della poesia shakespeariana non è meno importante dell'avvenimento della Riforma religiosa o della Rivoluzione francese), e, appunto perché sono parte, non debbono sommergersi e perdersi in quella storia, cioè nelle altre parti di quella storia, ma mantenere il loro proprio e originale rilievo e carattere.
7. Obiezione e risposta: una serie di saggi isolati?
Si obietta che così si finisce per produrre una serie di monografie senza nesso tra loro. Ma Croce ribatte:
- il nesso tra le opere non è esterno, bensì interno allo sviluppo spirituale dell'umanità;
- ogni grande creazione artistica è parte integrante della storia universale dello spirito, non meno che una rivoluzione politica o una riforma religiosa.
🔎 Note testuali
Gli eventi estetici, per Croce, non sono effetti della storia: sono anch'essi eventi della storia, e dei più alti.
Postilla
Con questa sezione, Croce completa il suo impianto teorico: dopo aver stabilito che l'arte è una forma dello spirito, e dopo aver chiarito cosa non è (genere, ornamento, stile, emozione grezza…), ora definisce le regole per giudicarla e per raccontarla storicamente.
👉 Tesi crociana sulla critica e sulla storia dell'arte:
• Il giudizio estetico è atto spirituale, non opinione soggettiva.
• La storiografia dell'arte deve esprimere la forma individuale dell'opera, non i suoi presunti "contenuti".
• L'opera d'arte è una creazione, non un sintomo.
• La storia dell'arte è storia dello spirito, non sociologia culturale.
![]() Testo : 12,1
Testo : 12,1
LA STORIA DELL'ESTETICA. — La storia dell'Estetica, per il già notato carattere di questa come scienza filosofica, non si può separare dalla storia di tutta l'altra filosofia, che le apporta luce, e altrettanta ne riceve in cambio. Per es., si vede da quella come l'avviamento che si dice soggettivistico, preso dal pensiero filosofico con Cartesio, favorendo l'indagine della potenza creativa dello spirito, per indiretto favorisse anche l'indagine circa la potenza estetica; e, d'altra parte, per quel che riguarda l'efficacia esercitata dall'Estetica sulla restante filosofia, basta ricordare quanto la progredita coscienza della Fantasia creatrice e della Logica poetica contribuisse a liberare la Logica filosofica dal tradizionale intellettualismo e formalismo, e, riavvicinando il moto del pensiero al moto della poesia, a innalzarla a Logica speculativa o dialettica nelle filosofie dello Schelling e dello Hegel.
Nella sua sintetica ma densa ricostruzione della storia dell'Estetica, Benedetto Croce traccia un itinerario critico che va dall'antichità greco-romana fino alle soglie del pensiero contemporaneo, proponendo non tanto una cronaca erudita quanto una valutazione teoretica della maturazione (e dei fraintendimenti) della coscienza estetica in Occidente. Al centro della sua analisi vi è un'istanza essenziale: il riconoscimento dell'arte come funzione autonoma dello spirito, distinta dalla logica, dalla morale, dalla religione, dalla retorica e da ogni subordinazione eterogenea.
Croce sostiene che la storia dell'Estetica, in quanto disciplina autenticamente filosofica, non può essere considerata isolatamente, ma va compresa in connessione organica con l'intero sviluppo della filosofia. Essa riceve chiarimenti dal pensiero generale e, al tempo stesso, restituisce contributi illuminanti a quest'ultimo.
Ad esempio, l'orientamento soggettivistico inaugurato da Cartesio, pur avendo come oggetto principale l'esplorazione delle capacità generative dello spirito, ha favorito indirettamente anche una riflessione più profonda sull'attività estetica, intesa come espressione creativa dello spirito stesso.
In senso opposto, l'Estetica ha esercitato una significativa influenza sul pensiero filosofico complessivo: l'affinamento della consapevolezza circa il ruolo della fantasia creatrice e della logica poetica ha contribuito in modo decisivo a emancipare la logica tradizionale dai suoi connotati rigidamente intellettualistici e formalistici.
Questa riabilitazione del momento immaginativo e poetico ha consentito di ricollegare il movimento del pensiero a quello della poesia, elevando la logica a un piano superiore, ossia quello della logica speculativa o dialettica, così come è concepita nelle filosofie di Schelling e di Hegel.
📌 Scheda esplicativa 1
Nel primo passaggio di quest'ultimo lungo paragrafo dedicato a La storia dell'Estetica, Croce pone le basi della sua concezione dell'estetica come disciplina pienamente filosofica, inserita all'interno del divenire della coscienza speculativa. La tesi fondamentale è che la storia dell'estetica non si può separare dalla storia della filosofia nel suo insieme, poiché l'una illumina e alimenta l'altra in un rapporto di reciproca necessità.
Il riferimento al soggettivismo cartesiano è centrale: con Cartesio, infatti, la filosofia moderna inaugura un nuovo orientamento, centrato sullo spirito come principio attivo e fondante. Questo "avviamento soggettivistico", anche se originariamente volto alla fondazione della certezza logica e gnoseologica, ha favorito indirettamente – ma potentemente – la valorizzazione della dimensione creativa dello spirito, aprendo così il varco anche alla riflessione estetica. Il soggetto non è più mero recipiente del mondo, ma fonte di espressione e di costruzione simbolica.
Dall'altro lato, Croce evidenzia l'influenza che l'estetica stessa ha esercitato sulla filosofia generale. L'emergere della coscienza della fantasia creatrice e della logica poetica – due nozioni cardine nel pensiero crociano – ha contribuito a spezzare la gabbia dell'intellettualismo e del formalismo tradizionali. In particolare, ciò ha consentito di liberare la logica filosofica dal suo irrigidimento classificatorio, restituendole il carattere di movimento speculativo, vivo e dialettico.
Croce riconosce che tale rinnovamento trova la sua massima espressione nelle filosofie di Schelling e di Hegel, dove la logica non è più regola dell'argomentazione corretta, ma sviluppo interno e necessario del pensiero assoluto. L'estetica, in tal senso, non è un episodio marginale ma un punto di passaggio decisivo nella genesi della logica speculativa: riavvicina il pensiero alla poesia, la concettualità all'intuizione, la forma astratta al gesto espressivo.In sintesi, Croce propone una visione organica del sapere, in cui l'estetica, lungi dall'essere un'appendice sentimentale o decorativa, è momento essenziale della spiritualità, capace di influenzare e riplasmare l'intera architettura del pensiero filosofico moderno.
![]() Testo : 12,2
Testo : 12,2
Ma se la storia dell'Estetica deve essere integrata nella storia totale della Filosofia, questa storia medesima dev'essere, per altro rispetto, allargata fuori dei confini, nei quali d'ordinario è mantenuta e nei quali si usa farla coincidere con la serie delle opere dei filosofi cosiddetti di professione e delle trattazioni didascaliche che si chiamano «sistemi di filosofia». I nuovi pensieri filosofici, o i loro germi, si ritrovano spesso vivi ed energici in libri che non sono di filosofi professionali, né sistematici nell'estrinseco: per l'etica, nei libri ascetici e religiosi; per la politica, nei libri degli storici; per l'estetica, in quelli dei critici d'arte, e via dicendo. Inoltre, si rammenti che, a parlare con rigore, il subbietto della storia dell'Estetica non è il problema, l'unico problema, della definizione dell'arte, ed esauribile con questa definizione quando sia stata o sarà raggiunta; ma gli infiniti problemi che sempre rampollano intorno all'arte, e nei quali quell'unico problema, la definizione dell'arte, si particolarizza e si concreta, e solo veramente esiste. Con queste avvertenze, che bisogna tenere ben presenti, si può dare una delineazione generale di storia dell'Estetica, che serva di orientazione preliminare, senza correre il rischio che essa venga intesa in modo rigido e semplicistico.
Croce sostiene che, se l'estetica deve essere letta nel contesto della storia complessiva della filosofia, allora è necessario che anche quest'ultima – la storia della filosofia – venga a sua volta ampliata rispetto ai limiti tradizionali nei quali viene solitamente circoscritta.
Non si può continuare a ridurre la storia del pensiero filosofico alla mera successione cronologica delle opere dei cosiddetti "filosofi di professione" o alle trattazioni sistematiche e didascaliche che si autodefiniscono "sistemi di filosofia".
I germi di nuovi pensieri filosofici, o persino le loro formulazioni più efficaci, si rinvengono frequentemente in opere che non appartengono propriamente alla tradizione accademica o sistematica: nell'ambito dell'etica, ad esempio, si trovano nelle opere ascetiche o religiose; nel campo della politica, nei testi degli storici; per quanto riguarda l'estetica, nelle opere dei critici d'arte. Questa diffusione dei nuclei speculativi al di fuori delle sedi canoniche indica, per Croce, la vitalità e la pervasività del pensiero filosofico.Inoltre, l'oggetto della storia dell'estetica non può essere inteso – se si vuole parlare con rigore – come la semplice ricerca della definizione dell'arte. Tale ricerca non esaurisce né delimita l'estetica, nemmeno nel caso in cui la definizione venga finalmente raggiunta.
Croce chiarisce che il vero contenuto della storia dell'estetica è costituito dalla moltitudine di problemi concreti, sempre rinnovati e differenziati, che sorgono attorno all'arte. È in tali questioni specifiche che l'unico problema teorico della definizione dell'arte si articola, si particolarizza e prende corpo, trovando così la propria autentica esistenza.
Conclude infine che, tenendo ben presenti queste avvertenze – cioè l'ampliamento della fonte e l'irriducibilità dell'estetica a una definizione unica – è possibile tracciare una linea generale di sviluppo storico dell'estetica. Tale orientamento preliminare, lungi dall'essere rigido o dogmatico, permette un approccio critico e dinamico, evitando semplificazioni grossolane.
📌 Scheda esplicativa 2
Croce qui insiste su una tesi metodologica fondamentale: per comprendere la storia dell'estetica, è necessario abbandonare una visione accademicamente ristretta della storia della filosofia. Non è sufficiente prendere in considerazione i soli filosofi "ufficiali", ossia coloro che hanno prodotto sistemi coerenti e didascalici: il pensiero filosofico – e dunque anche l'estetico – si manifesta vitalmente anche fuori da questi confini.
Egli rifiuta la distinzione netta tra filosofia "professionale" e riflessione filosofica sostanziale. Il vero pensiero, secondo Croce, può emergere anche da testi non sistematici: nei libri religiosi si trovano intuizioni etiche profonde; negli storici, riflessioni politiche autentiche; nei critici d'arte, elaborazioni estetiche vive e penetranti. È quindi necessario estendere il campo d'indagine a tutte le espressioni dello spirito che abbiano una portata filosofica.Croce introduce inoltre una critica implicita al riduzionismo definitorio: l'idea che la filosofia dell'arte si esaurisca nella ricerca della sua definizione essenziale è, per lui, un grave fraintendimento. Il pensiero estetico è invece costellato da una pluralità di problemi concreti, storicamente e teoricamente determinati, che fanno vivere il problema centrale, ovvero "che cos'è l'arte", in forme particolari e situate.
Il nucleo dell'estetica crociana emerge qui in modo chiaro: l'arte non è un concetto da definire una volta per tutte, ma un'attività spirituale che genera continuamente interrogativi teorici e pratici. La storia dell'estetica deve quindi riflettere questa ricchezza, evitando di irrigidirsi in schematismi o astrazioni troppo generalizzanti.
![]() Testo : 12,3
Testo : 12,3
In questa delineazione generale conviene accettare, perché risponde non solo ad opportunità espositiva ma a verità storica, la comune sentenza che l'Estetica è una scienza moderna. L'antichità greco-romana non speculò, o assai poco, sull'arte, ma intese soprattutto a creare la didascalica di essa: non la «filosofia», si potrebbe dire, ma la «scienza empirica» dell'arte. Tali sono i suoi trattati di «grammatica», di «retorica», di «istituzioni oratorie», di «architettura», di «musica», di «pittura» e «scultura»: fondamento di tutta la didascalica posteriore, e anche della nostra odierna, nella quale quelle trattazioni sono state semplificate e vengono interpretate cum grano salis, ma non punto abbandonate, perché praticamente sono indispensabili. La filosofia dell'arte non trovava condizioni favorevoli e stimoli nella filosofia antica, che era soprattutto «fisica» e «metafisica», e solo secondariamente ed episodicamente «psicologia», o, come si deve dire più esattamente, «filosofia dello spirito». Ai problemi filosofici dell'Estetica fu fatto qualche accenno in modo negativo, con la negazione platonica del valore della poesia, e, in modo positivo, con la difesa aristotelica, che cercò di assicurare alla poesia un dominio proprio tra quello della storia e quello della filosofia, e, per un altro verso, con le speculazioni di Plotino, che per primo congiunse e unificò i due concetti, i quali erravano staccati, dell'«arte» e del «bello».
Nel tracciare un profilo generale della storia dell'Estetica, è opportuno accogliere la diffusa opinione secondo cui questa disciplina è, in senso proprio, una scienza moderna. Tale affermazione non risponde soltanto a un criterio di chiarezza espositiva, ma corrisponde anche a una verità storica sostanziale.
L'antichità greco-romana non elaborò un'autentica speculazione filosofica sull'arte: essa si concentrò piuttosto sull'elaborazione di trattati di natura didascalica e tecnica. In altri termini, non sviluppò una filosofia dell'arte, ma produsse una sorta di scienza empirica dell'arte, orientata alla norma e alla prassi.
Croce enumera le principali forme di questa trattatistica antica: testi di grammatica, retorica, istituzioni oratorie, architettura, musica, pittura e scultura. Tali opere, pur nella loro distanza dalla riflessione speculativa, costituirono il fondamento della successiva didattica artistica, compresa quella moderna. Questi testi, sebbene oggi reinterpretati con maggiore senso critico (cum grano salis), non sono mai stati davvero abbandonati, in quanto svolgono ancora un ruolo pratico insostituibile.
Croce aggiunge che la filosofia antica, essendo prevalentemente orientata verso la fisica e la metafisica, e solo marginalmente interessata alla psicologia – o, per dirla con maggior precisione, alla filosofia dello spirito – non offriva un terreno adatto per la nascita di un'autonoma filosofia dell'arte.
Riconosce però che, sebbene in modo frammentario, alcuni accenni filosofici rilevanti si trovano anche nell'antichità: negativamente, nella condanna platonica dell'arte poetica; positivamente, nella difesa aristotelica della poesia, a cui Aristotele assegna un proprio spazio teoretico, intermedio tra quello della storia e quello della filosofia.
Infine, Croce sottolinea l'importanza delle speculazioni di Plotino, il quale è il primo pensatore che abbia cercato di unificare i due concetti tradizionalmente separati di "arte" e "bello", stabilendo un nesso speculativo tra estetica e metafisica.
📌 Scheda esplicativa 3
Croce introduce qui una distinzione cronologica e concettuale fondamentale: l'Estetica, come riflessione propriamente filosofica sull'arte, è una disciplina moderna. L'antichità non ha prodotto un pensiero estetico nel senso crociano – ovvero come analisi dello spirito espressivo – ma si è concentrata sulla normatività tecnica dell'arte. In altri termini, i greci e i romani non si chiedevano che cos'è l'arte in sé, ma come si fa bene un discorso, una statua, un edificio, una melodia.
I trattati antichi erano quindi manuali tecnici: opere che rientravano nel campo della grammatica e della retorica (per la parola), dell'architettura (per l'edilizia), della musica (per l'armonia), e così via. Questi testi sono per Croce espressione di una "scienza empirica" dell'arte, cioè di un sapere pratico e normativo, non filosofico. Tuttavia, egli riconosce che questi strumenti conservano una loro utilità pratica, e perciò non sono mai stati del tutto accantonati.
Ciò che mancava nel pensiero antico, secondo Croce, erano le condizioni storiche e teoretiche per pensare l'arte come momento dello spirito. La filosofia greca era orientata verso l'ontologia e la cosmologia (fisica e metafisica), e solo occasionalmente si interessava all'interiorità soggettiva, cioè alla psicologia o alla filosofia dello spirito – terreno su cui invece nascerà l'estetica moderna.
Tuttavia, Croce individua tre eccezioni degne di nota nel pensiero antico:
- Platone, che parla d'arte in termini negativi, negandone il valore conoscitivo e relegandola a copia della copia;
- Aristotele, che ne rivaluta invece la funzione, attribuendo alla poesia un'autonomia teoretica rispetto sia alla cronaca sia alla filosofia;
- Plotino, che compie un passo decisivo cercando di unificare l'idea di arte e quella di bellezza in una visione spirituale e metafisica: è il primo a intuire l'unità speculativa tra estetica e metafisica, anticipando così alcuni temi dell'estetica idealistica.
In sintesi, Croce chiarisce che la filosofia dell'arte nasce pienamente solo quando l'arte è ricondotta a una funzione originaria dello spirito, e ciò accade solo nell'età moderna.
![]() Testo : 12,4
Testo : 12,4
Altri pensieri importanti degli antichi furono quelli che alla poesia assegnavano i «miti» e non i «loghi», e che discernevano nelle proposizioni le espressioni meramente «semantiche», retoriche e germinalmente poetiche, dalle «apofantiche» o logiche. Di recente si è discorso di un nuovo filone dell'Estetica greca in dottrine epicuree esposte da Filodemo, in cui è sembrato che si desse alla fantasia un risalto quasi romantico. In ogni caso, questi accenni rimasero allora poco fecondi, e il robusto e sicuro giudizio degli antichi nelle cose dell'arte non si approfondì e compose in vera e propria scienza filosofica, a cagione del limite che era nel generale carattere oggettivistico o naturalistico della filosofia antica, e che solo il cristianesimo, con l'innalzare i problemi dell'anima e collocarli al centro della considerazione, cominciò a rimuovere o preparò le forze onde venne rimosso.
Croce segnala altri momenti significativi, sebbene episodici, del pensiero antico sull'estetica. Tra questi, egli ricorda le dottrine che attribuivano alla poesia un linguaggio distinto da quello filosofico o scientifico: non il discorso dimostrativo, cioè i logoi, ma i miti, intesi come narrazioni simboliche, evocative, non vincolate alla logicità argomentativa.
Egli evidenzia inoltre una distinzione formulata nell'antichità tra proposizioni di natura puramente espressiva – denominate semantiche, di carattere retorico e, in nuce, poetico – e proposizioni apofantiche, cioè assertive, che intendono affermare verità logiche. In tale distinzione, Croce intravede una precoce intuizione della diversità tra linguaggio estetico e linguaggio concettuale.
Croce fa anche riferimento a ricerche più recenti che hanno ravvisato nell'epicureismo, e in particolare negli scritti di Filodemo, l'esistenza di un filone estetico alternativo all'oggettivismo dominante, in cui la fantasia artistica riceve un riconoscimento sorprendentemente accentuato, quasi di matrice romantica. Ciò segnala, secondo lui, una anticipazione isolata e anacronistica della sensibilità moderna.
Tuttavia, questi spunti, per quanto interessanti, non produssero esiti duraturi: non generarono una sistematizzazione teorica dell'estetica. Il giudizio degli antichi in materia d'arte, pur essendo spesso acuto e fondato sull'esperienza, rimase privo di profondità speculativa e non si evolse in una scienza filosofica dell'arte propriamente detta.
Croce attribuisce questa sterilità teorica ad un fattore strutturale: il carattere oggettivistico e naturalistico della filosofia antica, che tendeva a collocare il pensiero fuori dall'interiorità soggettiva. Solo il cristianesimo, ponendo l'anima al centro della riflessione, cominciò a smuovere tale limite e creò le premesse spirituali e culturali che resero possibile l'elaborazione successiva di una filosofia dello spirito e, quindi, di un'estetica vera e propria.
📌 Scheda esplicativa 4
Croce in questo passaggio completa il suo giudizio sul pensiero antico, riconoscendone alcune intuizioni estetiche significative ma ancora frammentarie. In particolare, sottolinea come gli antichi avessero intuito la specificità del linguaggio poetico, riconoscendogli una natura differente da quella razionale e discorsiva della filosofia. Il mito, infatti, non è dimostrazione ma simbolo: esso non afferma una verità logica, ma rappresenta un'esperienza spirituale attraverso immagini.
Anche la distinzione tra proposizioni "semantiche" e "apofantiche" è per Croce assai rilevante. Le prime indicano espressioni che veicolano significato in modo evocativo o simbolico, anticipando l'idea crociana dell'intuizione espressiva. Le seconde, invece, sono proposizioni che asseriscono, cioè che "dicono" qualcosa che può essere vero o falso, tipiche del linguaggio concettuale e scientifico. Questa dicotomia, sebbene formulata in modo non sistematico, prefigura la separazione moderna tra linguaggio poetico e linguaggio logico.
Croce menziona poi un recupero moderno dell'estetica antica: quello operato dagli studi su Filodemo, pensatore epicureo, in cui si è colto un apprezzamento della fantasia che sembra avvicinarsi alla concezione romantica. Si tratterebbe di un'isola teoretica, inattesa per il mondo antico, dove la funzione immaginativa dell'arte viene rivalutata. Tuttavia, Croce non sopravvaluta questo dato: lo considera un sintomo isolato, privo di incidenza strutturale nel pensiero antico.
Il nodo cruciale della riflessione di Croce qui è la mancanza, nel mondo antico, di una filosofia dello spirito. La filosofia greca è, per Croce, oggettivistica: concepisce la realtà come qualcosa da osservare, da comprendere nella sua natura esterna. L'interiorità, la soggettività, l'anima, non sono ancora poste al centro della riflessione filosofica. Questa rivoluzione si realizza solo con il cristianesimo, che sposta l'asse speculativo dall'oggetto all'anima, anticipando le grandi costruzioni della filosofia moderna e idealistica.
Dunque, l'estetica – come disciplina dello spirito – non poteva nascere nella cornice della filosofia antica, e solo il cristianesimo ne preparò le condizioni storiche e culturali.
![]() Testo : 12,5
Testo : 12,5
Per intanto, la stessa filosofia cristiana, così per il prevalere della trascendenza, del misticismo e dell'ascetismo, come per la forma scolastica, desunta dalla filosofia antica, nella quale si venne adagiando, se rese acuti i problemi morali e delicata la loro trattazione, non sentì e non indagò quelli della fantasia e del gusto, allo stesso modo che rifuggì dagli altri (che a essi corrispondono nella sfera pratica) delle passioni, degl'interessi, delle utilità, della politica e dell'economia. Come la politica e l'economia furono concepite moralisticamente, così l'arte fu sottoposta all'allegoria morale e religiosa; e i concetti sparsi negli scrittori greco-romani rimasero dimenticati o superficialmente considerati. La filosofia del Rinascimento, che fu a suo modo naturalistica, restaurò, interpretò e adattò le antiche Poetiche e Retoriche; ma, sebbene non poco si travagliasse sul «verisimile» e sul «vero», sull'«imitazione» e sull'«idea», sul «bello» e sulla mistica del bello e dell'amore, sulla «catarsi», o purgamento delle passioni, sulle aporie dei tradizionali e dei nuovi generi letterarî, non giunse a porre un principio propriamente estetico. Alla poesia e all'arte mancò allora un pensatore che operasse quello che il Machiavelli operò per la politica: tale cioè che energicamente, e non solo in incidentali osservazioni e ammissioni, ne asserisse e definisse l'originale natura e l'autonomia.
Assai maggiore importanza, sebbene per lungo tempo non notata dagli storici, ebbe in questa parte il pensiero del tardo Rinascimento, che in Italia si chiama secentismo, barocchismo o decadenza letteraria e artistica; perché allora si cominciò a distinguere con insistenza, accanto all'«intelletto», una facoltà che fu detta «ingegno», ingenium o «genio», propriamente produttrice dell'arte; e, in corrispondenza con essa, una facoltà giudicatrice, che non era il raziocinio o il giudizio logico, perché giudicava «senza discorso» ossia «senza concetto», e venne prendendo il nome di «gusto». Aiutava queste parole un'altra parola, che pareva accennare a qualcosa di non determinabile in concetti logici e come di misterioso, il «nescio quid», il «non so che»: espressione che ricorreva particolarmente nel parlare degli italiani e dava da riflettere agli stranieri.
Nonostante il cristianesimo abbia contribuito a porre al centro della riflessione i problemi dell'anima, la filosofia cristiana, per diversi motivi strutturali e storici, non riuscì a sviluppare una riflessione autenticamente estetica. Da un lato, ciò fu dovuto alla prevalenza di elementi trascendenti, mistici e ascetici; dall'altro, all'adozione del metodo scolastico derivato dalla filosofia greca, che irrigidì l'indagine in schemi formali.
Se da un canto, quindi, questa impostazione rese più raffinata e penetrante l'analisi dei problemi morali, dall'altro trascurò del tutto l'ambito della fantasia e del gusto, così come evitò – per analoghe ragioni – di approfondire altri ambiti "pratici", come le passioni, gli interessi umani, le utilità materiali, la politica e l'economia. Questi ambiti furono concepiti in modo moralistico, e così anche l'arte fu ridotta a un mezzo allegorico e didattico, asservito a fini morali e religiosi.
Con il Rinascimento, si assiste a una rivalutazione del pensiero antico: la filosofia rinascimentale, che aveva un carattere in parte naturalistico, recuperò e reinterpretò le Poetiche e le Retoriche greco-romane. Tuttavia, sebbene si discutesse ampiamente di concetti cruciali come il verisimile, il vero, l'imitazione, l'idea, il bello, la mistica dell'amore, la catarsi, e le aporie dei generi letterari, mancò ancora un'autentica fondazione teorica dell'estetica.
In quell'epoca, sottolinea con forza Croce, mancò una figura capace di definire l'arte nei termini della sua autonomia teorica e spirituale, così come Machiavelli aveva fatto per la politica. Le intuizioni estetiche rimasero frammentarie, espresse solo incidentalmente e prive di sistematicità speculativa.
Croce rivaluta invece con decisione un periodo tradizionalmente considerato decadente: il tardo Rinascimento, noto in Italia come secentismo, barocco o decadenza letteraria. Qui, secondo lui, si sviluppano concetti decisivi per la nascita dell'estetica moderna: si distingue una facoltà autonoma, detta ingegno (o genio), diversa dall'intelletto, considerata come la vera sorgente dell'arte. A essa si associa un'altra facoltà, quella del gusto, che non ragiona concettualmente ma giudica senza discorso, ossia senza passare per l'astrazione logica.
Accanto a queste due categorie, emerse anche un'espressione suggestiva, il nescio quid, ossia il "non so che", impiegata in particolare nel linguaggio artistico italiano. Questa locuzione, che indica un quid ineffabile dell'esperienza estetica, attirava la curiosità degli osservatori stranieri e segnalava un'intuizione nuova: che l'arte non è pienamente riducibile al concetto.
📌 Scheda esplicativa 5
Croce, in questo denso passaggio, elabora una duplice critica e una rivalutazione storiografica. Innanzitutto, egli critica la filosofia cristiana per non aver elaborato un'estetica autentica. Sebbene abbia portato al centro della riflessione la soggettività e l'interiorità, il cristianesimo filosofico si è rivolto prevalentemente all'etica e alla teologia mistica, disinteressandosi delle forme dell'espressione sensibile come la fantasia e il gusto. Ciò è avvenuto perché dominavano una visione trascendente dell'essere, l'ideale ascetico del distacco dal mondo sensibile e l'adozione della scolastica come metodo rigido e derivativo.
Allo stesso modo, Croce rileva una ritrazione verso un moralismo sistematico: tutte le attività pratiche umane – le passioni, l'economia, la politica – venivano subordinate all'etica cristiana. L'arte, in tale cornice, non poteva essere pensata come autonoma, ma solo come strumento simbolico e allegorico, al servizio della morale o della religione. In questo quadro, i concetti greco-romani sull'arte vennero dimenticati o trattati superficialmente.
Croce guarda quindi al Rinascimento, che pur non fondando ancora un'estetica autonoma, resta importante per aver riattivato il patrimonio speculativo classico. I filosofi dell'epoca, pur discutendo con profondità problemi come la verosimiglianza, l'imitazione, il bello e la catarsi, non giunsero mai a stabilire un principio fondativo dell'estetica, mancando un pensatore che facesse per l'arte ciò che Machiavelli fece per la politica: riconoscerle una struttura autonoma e una logica propria.
Il momento realmente innovativo, secondo Croce, arriva nel tardo Rinascimento e nel Barocco, tradizionalmente giudicato con sospetto o disprezzo. In questo periodo emergono due concetti centrali:
- L'"ingegno" o "genio", inteso come facoltà spirituale creativa, distinta dall'intelletto discorsivo. È un'anticipazione del concetto moderno di ispirazione e produttività artistica.
- Il "gusto", inteso non come semplice preferenza soggettiva, ma come capacità di giudizio non concettuale: un'intuizione sensibile e immediata del valore estetico.
A coronamento di questa nuova sensibilità estetica, Croce cita il "nescio quid", il "non so che": una formula apparentemente vaga, che però indica la consapevolezza di una dimensione dell'arte che sfugge al raziocinio, che non può essere detta ma solo sentita. Questa intuizione – tanto più viva nel linguaggio degli italiani – rappresenta per Croce un segno dell'avanzare di una coscienza estetica moderna.
![]() Testo : 12,6
Testo : 12,6
Anche allora si celebrò la «fantasia», maga incantatrice, e il «sensibile» o «sensuoso» che è nelle immagini della poesia, e nella pittura i miracoli del «colore» a fronte del «disegno», che sembrava ritenere alcunché di logico e di freddo. Talvolta queste tendenze spirituali, che erano alquanto torbide, si purificarono, innalzandosi a ragionate teorie: come nel caso dello Zuccolo (1623), che criticò la metrica e sostituì ai criterî di questa il «giudizio del senso», che era per lui, non già l'occhio o l'orecchio, ma «una potenza superiore, unita ai sensi»; del Mascardi (1636), che negò le partizioni oggettive e retoriche degli stili, riducendo lo stile alla maniera particolare e individua nascente dal particolare ingegno di ciascuno, e affermò che tanti sono gli stili quanti gli scrittori; del Pallavicino (1644), che criticò il verisimile e riconobbe proprio dominio della poesia le «prime apprensioni» o fantasie, «né vere né false»; del Tesauro (1654), che cercò di svolgere una Logica retorica, distinta dalla Logica dialettica, ed estese le forme retoriche di là da quelle verbali, alle espressioni pittoriche e plastiche.
La nuova filosofia di Cartesio, se in lui e nei suoi prossimi successori si atteggiò ostile alla poesia e alla fantasia, per un altro lato, cioè, come si è detto, con l'indagine che promuoveva del soggetto o dello spirito, aiutò questi sparsi conati a comporsi in sistema e a ricercare un principio a cui ridurre le arti; e anche qui gl'italiani, accogliendo bensì il metodo ma non il rigido intellettualismo di Cartesio né il suo disdegno verso la poesia, le arti e la fantasia, col Calopreso (1691), col Gravina (1692, 1708), col Muratori (1704), e con altri, dettero le prime Poetiche nelle quali dominò o ebbe parte rilevante il concetto di Fantasia; e non piccola fu la loro efficacia sul Bodmer e sulla scuola svizzera, e, attraverso di essi, sulla critica ed estetica tedesca, e in genere europea: tanto che si è potuto perfino parlare in questi ultimi anni (Robertson) della «origine italiana dell'Estetica romantica».
Anche nel tardo Rinascimento e nell'epoca barocca si assistette a una viva celebrazione della fantasia, rappresentata come una forza incantatrice, capace di operare magie nell'ambito dell'immaginazione artistica. Allo stesso modo, si esaltò il sensibile o sensuoso, ovvero quella qualità immediata e viva che appartiene alle immagini poetiche e ai valori cromatici nella pittura.
Croce mette in rilievo che, in tale contesto, si contrapponeva il colore – percepito come elemento vibrante e spirituale – al disegno, che invece appariva come una componente razionale, forse troppo logica e fredda per esprimere l'autenticità dell'esperienza artistica.
Talvolta, queste istanze spirituali – inizialmente confuse e irregolari – giunsero a una certa purificazione teorica, assumendo la forma di riflessioni più meditate. È il caso, ad esempio, di autori italiani come:
- Lo Zuccolo (1623), che mise in discussione la metrica tradizionale e vi sostituì il giudizio del senso: non una mera percezione sensoriale, ma una facoltà superiore connessa ai sensi, capace di cogliere armonie e valori estetici;
- Il Mascardi (1636), che respingeva la classificazione oggettiva e retorica degli stili, sostenendo che lo stile è sempre un'espressione individuale e unica dell'ingegno personale, e che dunque vi sono tanti stili quante sono le soggettività creative;
- Il Pallavicino (1644), che criticava il criterio del verosimile, ritenendo che la poesia non debba imitare il reale ma si fondi sulle prime apprensioni, ovvero sulle fantasie originarie che non sono né vere né false;
- Il Tesauro (1654), che tentò di elaborare una logica retorica distinta dalla logica dialettica, estendendo le forme della retorica non solo alla parola, ma anche alle arti visive e plastiche.
Croce sostiene infine che la nuova filosofia cartesiana, sebbene inizialmente ostile alla poesia e alla fantasia per la sua impostazione razionalistica, contribuì indirettamente alla sistemazione dell'estetica. L'indagine sul soggetto e sullo spirito, avviata da Cartesio, rese infatti possibile il passaggio da intuizioni sparse a riflessioni più coerenti, capaci di fondare le arti su un principio unitario.
Egli osserva che alcuni pensatori italiani accolsero il metodo cartesiano senza assumerne il rigido intellettualismo né il disprezzo per la fantasia. È il caso di Calopreso (1691), Gravina (1692, 1708), Muratori (1704), e altri, i quali formularono Poetiche innovative, nelle quali il concetto di fantasia divenne centrale o comunque rilevante.
L'influenza di questi autori italiani non fu marginale: essi esercitarono un impatto significativo su Bodmer e sulla scuola svizzera, e, tramite questi, sulla critica e l'estetica tedesca ed europea. Tanto che alcuni studiosi moderni – come Robertson – hanno potuto parlare dell'origine italiana dell'estetica romantica.
📌 Scheda esplicativa 6
In questo articolato passaggio, Croce approfondisce il fermento teorico dell'età barocca, valorizzando l'elaborazione italiana che aveva fino ad allora ricevuto scarso riconoscimento storico. Egli descrive un momento di transizione, in cui la celebrazione spontanea della fantasia e del sensibile comincia ad assumere una forma più teoricamente consapevole.
La fantasia viene qui esaltata come una forza creativa e misteriosa, "maga incantatrice", che contrasta la rigidità razionalistica. Nello stesso modo, il sensibile – colore, immagine, immediatezza – viene privilegiato rispetto alla costruzione formale, simboleggiata dal disegno. Croce coglie qui la contrapposizione tra vita estetica e struttura logica, tra espressione e concettualizzazione.
I quattro autori citati rappresentano per Croce una precoce "protospeculazione estetica":
- Lo Zuccolo reinterpreta la metrica non come schema tecnico ma come espressione che deve rispondere al "giudizio del senso" – un'anticipazione dell'intuizione estetica crociana, che è senso spirituale, non semplice sensazione.
- Il Mascardi critica le tassonomie retoriche e afferma il valore unico di ogni individualità stilistica. Qui emerge il principio della singolarità creativa, secondo cui non esistono generi o regole universali, ma solo personalità espressive.
- Il Pallavicino contesta la centralità del verosimile (categoria aristotelica), sostenendo che la poesia nasce da visioni originarie, non assoggettabili a verità logica. Questa intuizione della neutralità di vero/falso nell'arte è una svolta importante.
- Il Tesauro, nel tentare di costruire una logica retorica, anticipa l'idea che esistano forme di ragionamento espressive e non argomentative, presenti tanto nel linguaggio quanto nelle arti figurative.
Croce poi riconsidera il cartesianesimo, mostrandone una duplice eredità: da un lato, Cartesio e i suoi primi seguaci rifiutano la fantasia, ma dall'altro – promuovendo l'indagine sul soggetto – forniscono un modello metodologico che favorisce lo sviluppo dell'estetica moderna, soprattutto in ambito italiano.
Il vero salto avviene con gli autori italiani tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, che integrano metodo razionale e valorizzazione della fantasia. Nelle loro Poetiche, la fantasia non è più accidente romantico, ma funzione essenziale dello spirito. La loro influenza si estese, tramite Bodmer e la scuola svizzera, fino all'estetica tedesca (Lessing, Herder, Kant, Schiller).
Croce rivendica così un primato italiano nella genesi dell'estetica moderna, che la storiografia precedente aveva trascurato. L'"origine italiana dell'estetica romantica" non è un semplice slogan, ma una tesi storiografica che egli rafforza con solide connessioni intellettuali.
![]() Testo : 12,7
Testo : 12,7
Il pensatore, nel quale tutti questi minori teorici misero capo, fu G. B. Vico, che nella Scienza nuova (1725, 1730) propose una «Logica poetica», distinguendola da quella intellettuale; considerò la poesia modo di conoscenza o forma teoretica che antecede quella ragionante e filosofica; ripose l'unico principio di essa nella fantasia, che è tanto più forte quanto più è libera di raziocinio, suo nemico e dissolvitore: esaltò padre e principe di tutti i veri poeti il barbarico Omero, e accanto a lui, sebbene turbato dalla cultura teologica e scolastica, il semibarbarico Dante, e spinse l'occhio, senza riuscire a ben vederla, alla tragedia inglese, allo Shakespeare, che gli rimase nascosto e sarebbe stato certamente, se l'avesse potuto conoscere, il suo terzo barbarico e grande poeta. Ma il Vico, così in questa teoria estetica come nelle altre sue, non formò scuola, perché troppo anticipava sul suo tempo, e anche perché il suo pensiero filosofico era avvolto in una sorta di simbolica storica. La «Logica poetica» si fece strada, quando ricomparve dì gran lunga meno profonda ma in ambiente più propizio col sistematore della alquanto ibrida estetica leibniziana, il Baumgarten (Meditationes, 1735, Aesthetica, 1750-58), che le dette varî nomi, tra i quali ars analogi rationis, scientia cognitionis sensitivae, gnoseologia inferior, e, quello che le rimase, Aesthetica.
La scuola del Baumgarten, che distingueva e non distingueva la forma fantastica da quella intellettiva, trattandola come cognitio confusa, fornito per altro di una sua propria perfectio, e le speculazioni e le analisi degli estetici inglesi (Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Home, Gerard, Burke, Alison, ecc.) e, in genere, i tanti «saggi» sul bello e sul gusto, moltiplicatisi in quel tempo, e le teorie e le trattazioni storiche del Lessing e del Winckelmann, concorsero come stimolo ora positivo ora negativo alla formazione dell'altra grande opera di Estetica del secolo decimottavo, la Critica del giudizio (1790) di Emmanuele Kant, nella quale l'autore (dopo che ne aveva dubitato nella prima Critica) scoprì che il bello e l'arte porgono argomento a una particolare scienza filosofica, cioè scoprì l'autonomia dell'attività estetica. Contro gli utilitaristi egli dimostrò che il bello piace «senza interesse» (senza interesse utilitario); contro gli intellettualisti, che esso piace «senza concetto»; e di nuovo, contro gli uni e gli altri, che esso ha «la forma della finalità senza la rappresentazione del fine»; e, contro gli edonisti, che esso è «oggetto di un piacere universale». Il Kant sostanzialmente non andò oltre questa formulazione negativa e generica del concetto del bello; come nella Critica della ragion pratica, messa in salvo la legge morale, non era andato oltre la forma generica del dovere. Ma quel che egli assodò rimane assodato per sempre; e, dopo la Critica del giudizio, i ritorni alle spiegazioni edonistiche e utilitarie dell'arte e della bellezza sono bensì possibili, e si sono avuti, ma soltanto mercé l'ignoranza e l'incomprensione delle dimostrazioni kantiane.
Croce individua in Giambattista Vico il punto di convergenza e di superiore sistemazione di quelle tendenze estetiche che, nei secoli precedenti, avevano trovato espressione in forma parziale o episodica. Con la Scienza nuova (1725, 1730), Vico elabora il concetto di "logica poetica", ponendola in netta distinzione rispetto alla logica intellettuale. Egli concepisce la poesia come una modalità conoscitiva originaria, anteriore alla riflessione raziocinante e filosofica, e fonda tale forma teoretica sulla fantasia, ritenuta tanto più potente quanto più è autonoma rispetto alla ragione, la quale agisce come forza disgregatrice.
Croce sottolinea che Vico eleva Omero, figura poetica primigenia e selvaggia, a padre e principe di tutti i poeti veri. Accanto a lui colloca Dante, che pur essendo influenzato dalla cultura teologica e scolastica, conserva un nucleo di barbarica ispirazione poetica. Vico, inoltre, intuisce l'esistenza della grande poesia shakespeariana, pur non riuscendo a coglierla pienamente a causa della sua limitata conoscenza dell'inglese e della sua epoca, che ancora non recepiva tale grandezza. Se l'avesse conosciuto, Shakespeare sarebbe stato per Vico il terzo dei poeti originari e barbarici, insieme a Omero e Dante.
Croce precisa tuttavia che il pensiero estetico di Vico, come il resto della sua filosofia, non diede origine a una scuola, a causa sia del suo carattere fortemente anticipatore rispetto allo spirito del tempo, sia della complessa struttura simbolico-storica che rendeva ardua la sua comprensione.
La logica poetica trovò invece una forma più sistematica, seppur assai più superficiale, nell'opera di Alexander Baumgarten, il quale, nella Meditationes (1735) e poi nella Aesthetica (1750–58), riprese il tema dell'attività estetica, coniando per essa denominazioni come ars analogi rationis, scientia cognitionis sensitivae, gnoseologia inferior, e infine aesthetica, nome destinato a prevalere.
Croce osserva che la scuola di Baumgarten oscillava tra distinzione e confusione: da un lato separava la conoscenza estetica da quella logica, dall'altro la riduceva comunque a cognitio confusa, seppur dotata di una propria forma di perfezione.
Nel medesimo periodo, anche le riflessioni degli estetici inglesi (Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Home, Gerard, Burke, Alison, ecc.) e una miriade di "saggi" sul bello e sul gusto, nonché le teorie e le ricostruzioni storiche di Lessing e Winckelmann, alimentarono – talvolta positivamente, talvolta per contrasto – l'elaborazione di un'estetica filosofica vera e propria.
Croce riconosce in La critica del giudizio (1790) di Immanuel Kant la seconda grande opera di estetica del Settecento, dopo quella di Vico. Dopo averne messo in dubbio la necessità nella Critica della ragion pura, Kant giunge a riconoscere che l'arte e il bello costituiscono l'oggetto di una scienza filosofica autonoma, scoprendo dunque l'autonomia dell'attività estetica.
Kant, secondo Croce, combatte su più fronti:
- contro gli utilitaristi, afferma che il bello piace senza interesse;
- contro gli intellettualisti, che piace senza concetto;
- contro entrambi, che ha la forma della finalità senza rappresentazione del fine;
- contro gli edonisti, che è oggetto di un piacere universale.
Tuttavia, Croce osserva criticamente che Kant non va oltre questa formulazione negativa e astratta del bello, così come nella Critica della ragion pratica, pur salvaguardando la legge morale, non supera mai la dimensione puramente formale del dovere.
Ciò nondimeno, afferma Croce con decisione, quel che Kant ha stabilito rimane acquisito in modo definitivo: dalla Critica del giudizio in avanti, ogni ritorno a spiegazioni edonistiche o utilitarie dell'arte non può più essere filosoficamente giustificato, e sussiste solo come esito di ignoranza o incomprensione della svolta critica kantiana.
📌 Scheda esplicativa 7
In questo importante passaggio, Croce delinea la nascita della vera estetica filosofica, attraverso due figure cardine: Vico e Kant.
Giambattista Vico, per Croce, è il primo pensatore a concepire una vera e propria "logica poetica". Lontano dal razionalismo imperante, Vico comprende che la poesia non è una mera decorazione del pensiero, ma una modalità originaria della conoscenza, più antica della riflessione discorsiva. Egli riconosce nella fantasia non un accessorio emotivo, ma la fonte primigenia della comprensione del mondo. La fantasia – nella sua piena libertà, non soggetta alla razionalità – è per Vico potenza conoscitiva autonoma, generatrice di miti, simboli, poesia.
Croce valorizza anche l'estetica implicitamente contenuta nella rivalutazione di Omero, Dante e, potenzialmente, Shakespeare. Questi tre poeti rappresentano, nella visione vichiana, la creatività originaria dell'umanità, in fasi e culture diverse. Vico, pur non conoscendo Shakespeare, ne avrebbe riconosciuto il carattere barbarico e primigenio, lo stesso che aveva intuito in Omero e Dante: l'arte come espressione della natura umana prima della riflessione filosofica.
Tuttavia, la grandezza di Vico restò incompresa nel suo tempo. Croce attribuisce questa marginalizzazione sia alla sua precocità storica, sia allo stile "simbolico" e denso della sua filosofia, che non si prestava a essere sistematizzata secondo i criteri accademici del Settecento.
Fu invece Alexander Baumgarten a sistematizzare – seppur con minor profondità – la riflessione estetica. Coniando il termine aesthetica, egli definì l'estetica come scienza della conoscenza sensibile, cioè una forma di sapere distinta da quella logico-discorsiva, anche se – come critica Croce – la ridusse a cognitio confusa, cioè una conoscenza vaga, inferiore. Baumgarten non comprese pienamente l'autonomia positiva dell'estetico, ma il suo contributo fu essenziale per l'istituzionalizzazione della disciplina.
Parallelamente, in Inghilterra e in Germania, il Settecento fu teatro di numerosi tentativi di definire il bello e il gusto. Gli estetici britannici si mossero per via psicologica, morale, empirica; Lessing e Winckelmann cercarono di fondare un'estetica storica o filologica. Ma il vero punto di svolta, per Croce, fu Kant.
Kant, con la Critica del giudizio, compie il passo decisivo: riconosce che l'estetica è una sfera autonoma dello spirito. Le sue tesi contro utilitarismo, intellettualismo ed edonismo sono, per Croce, inconfutabili e definitive:
- il bello non serve a nulla, ma piace in sé (senza interesse);
- non è concettuale, ma è giudicato senza regole logiche;
- non è finalizzato, ma ha la forma della finalità;
- non è soggettivo, ma il piacere che provoca è universalmente comunicabile.
Croce però denuncia la "negatività" di Kant, cioè il suo restare fermo a ciò che l'estetico non è, senza arrivare a dire positivamente cosa sia. Lo paragona alla morale kantiana: anche lì Kant salva il dovere, ma non ne sviluppa il contenuto concreto. Tuttavia, il fondamento critico da lui posto è irremovibile: chi lo nega, afferma Croce, lo fa solo per ignoranza.
![]() Testo : 12,8
Testo : 12,8
Neppure i ritorni del leibnizianismo e baumgartenianismo, cioè della dottrina dell'arte come concetto confuso o immaginoso, sarebbero dovuti più accadere, se al Kant fosse riuscito di ricongiungere la sua teoria del bello, che piace senza concetto ed è finalità senza rappresentazione di fine, alla teoria vichiana, piena d'imperfezioni e altresì di oscillazioni ma possente, circa la logica della fantasia, la quale teoria allora, in Germania, era in certo qual modo rappresentata dallo Hamann e dallo Herder. Ma egli stesso riapriva le porte al «concetto confuso», quando attribuiva al genio la virtù di combinare intelletto e immaginazione, e distingueva l'arte dalla «pura bellezza», definendola «bellezza aderente».
Nella filosofia postkantiana si ha per l'appunto la ripresa della tradizione baumgarteniana, riconsiderandosi la poesia e l'arte come una forma di conoscere l'Assoluto o l'Idea, ora pari a quella della filosofia, ora inferiore o preparatoria, ora superiore, come nella filosofia dello Schelling (1800), nella quale essa diventa l'organo dell'Assoluto. Nell'opera più ricca e cospicua della scuola, nelle Lezioni di estetica dello Hegel (1770-1831), l'arte, insieme con la religione e la filosofia, è trasferita nella «sfera dello spirito assoluto», in cui lo spirito si affranca dal conoscere empirico e dal fare pratico, e si beatifica nel pensiero di Dio o dell'Idea. Incerto rimane se, nella triade così costituita, il primo momento sia l'arte o la religione, perché c'è, in questo punto, varietà nelle esposizioni fatte dallo Hegel della sua dottrina; ma non incerto che l'una e l'altra, l'arte e la religione, vengano superate e inverate nella sintesi terminale, che è la Filosofia: il che vuol dire che l'arte vi è trattata come filosofia inferiore o imperfetta, filosofia immaginosa, una contradizione di contenuto e di forma a esso inadeguata, che solo la Filosofia scioglie. Lo Hegel, che tendeva a far coincidere il sistema della filosofia e la dialettica delle categorie con la storia reale, giunse per tal modo al famoso suo paradosso della mortalità dell'arte, forma non rispondente al più alto interesse mentale dei nuovi tempi.
Se Kant fosse riuscito a congiungere la sua teoria del bello – inteso come ciò che piace senza concetto e manifesta una finalità priva di scopo – alla teoria vichiana della logica della fantasia, allora non ci sarebbe stato motivo per il ritorno del leibnizianismo e del baumgartenianismo, cioè della concezione dell'arte come cognitio confusa o come forma immaginosa del concetto.
La teoria vichiana, pur imperfetta e contraddittoria, era dotata di una potenza speculativa profonda. Essa, nel contesto tedesco, trovava una certa risonanza nel pensiero di Hamann e Herder, che riconoscevano alla fantasia un ruolo essenziale nella conoscenza e nell'espressione.
Tuttavia, Croce rimprovera a Kant di aver lui stesso, in qualche misura, riaperto la porta all'equivoco concettualistico, quando attribuì al genio la capacità di combinare immaginazione e intelletto, e quando distinse l'arte dalla pura bellezza, definendola come bellezza aderente, ossia condizionata da un concetto o una funzione.
Con la filosofia post-kantiana, prosegue Croce, si assiste a una vera e propria ripresa della tradizione baumgarteniana. L'arte viene reinterpretata come forma di conoscenza dell'Assoluto o dell'Idea, e le posizioni oscillano:
- ora l'arte è equiparata alla filosofia;
- ora è subordinata ad essa, come preparazione;
- ora è addirittura superiore, come nella filosofia di Schelling, in cui essa assurge a organo diretto dell'Assoluto.
Croce riconosce che la trattazione più sistematica e imponente di questa linea si ha nelle Lezioni di estetica di Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Qui l'arte, insieme alla religione e alla filosofia, viene inserita nella sfera dello Spirito Assoluto – la dimensione in cui lo spirito si emancipa sia dalla conoscenza empirica sia dall'agire pratico, e si contempla nella forma dell'Idea divina.
C'è una certa ambiguità nella posizione hegeliana riguardo alla gerarchia interna tra arte e religione: a volte l'una è presentata come prima, a volte lo è l'altra. Ma non vi è incertezza circa la conclusione del processo dialettico: arte e religione vengono entrambe superate e inverate nella filosofia, che rappresenta il momento culminante dello Spirito Assoluto.
L'arte, in tale schema, è trattata da Hegel come filosofia "inferiore" o "immaginosa": una forma di pensiero in cui vi è contraddizione tra contenuto (l'Idea) e forma (l'immagine sensibile), una contraddizione che solo la filosofia – nel suo rigore concettuale – può dissolvere.
Croce conclude sottolineando che, poiché Hegel identificava la dialettica speculativa con il corso storico effettivo, arrivò alla sua celebre tesi della "mortalità dell'arte": l'arte, nella sua forma tradizionale, non sarebbe più adeguata a esprimere il pensiero dei tempi moderni, in cui il concetto ha ormai superato l'immagine.
📌 Scheda esplicativa 8
In questo passaggio, Croce approfondisce un punto critico della storia dell'estetica idealistica: la frattura mancata tra Kant e la tradizione precedente. Egli sostiene che, se Kant avesse saputo connettere la propria teoria del giudizio estetico con la logica della fantasia vichiana – riconoscendo così alla fantasia un'autonomia teoretica vera – non ci sarebbe stato il ritorno al concetto di arte come "cognizione confusa", proprio del pensiero leibniziano-baumgarteniano.
Vico, nella lettura crociana, rappresentava una via più feconda, poiché poneva la fantasia come fondamento originario della conoscenza poetica, non come un difetto della conoscenza razionale. Tuttavia, Kant, pur affermando l'autonomia dell'estetico, ricade in parte in un'ambiguità: quando introduce il genio come sintesi di immaginazione e intelletto, e quando distingue tra bellezza pura e bellezza aderente (cioè funzionalizzata), lascia aperta la strada alla riduzione dell'arte a un ibrido concettuale-sensibile.
La filosofia post-kantiana, invece di radicalizzare la svolta critica, tornò a interpretare l'arte come una forma di conoscenza dell'Assoluto. A seconda degli autori, l'arte fu considerata:
- equivalente alla filosofia, come intuizione intellettuale immediata;
- inferiore, come fase intermedia e prelogica;
- superiore, come espressione originaria dell'infinito, come in Schelling, dove l'arte diviene organo dell'Assoluto, cioè mezzo privilegiato per rivelare l'Unità trascendente.
Hegel rappresenta il punto culminante di questa impostazione. Nelle sue Lezioni di estetica, egli inserisce arte, religione e filosofia nella triade dello Spirito Assoluto, il momento in cui l'umanità supera la prassi empirica e si raccoglie nel pensiero dell'Idea. Tuttavia, la gerarchia è chiara: la filosofia è il culmine, perché è il momento in cui contenuto e forma coincidono, mentre arte e religione esprimono ancora l'Idea in forme sensibili o rappresentative.
L'arte, quindi, per Hegel è una filosofia imperfetta, una forma in cui il concetto si veste di immagini e simboli. Da ciò deriva la celebre "morte dell'arte" hegeliana: l'idea che, nei tempi moderni, lo spirito umano non trovi più adeguata espressione nell'arte sensibile, perché il concetto ha ormai preso il sopravvento.
Croce giudica severamente questa impostazione. Pur riconoscendo l'importanza storica di Hegel, ne contesta la riduzione dell'arte a forma secondaria di pensiero. Per lui – che proporrà invece una teoria dell'arte come espressione pura – l'arte non è una filosofia imperfetta, ma una funzione autonoma e originaria dello spirito, parallela e non subordinata alla logica o all'etica.
![]() Testo : 12,9
Testo : 12,9
Questa concezione dell'arte come filosofia o filosofia intuitiva o simbolo di filosofia, e simili, si ritrova in tutta l'Estetica idealistica della prima metà del secolo decimonono, salvo rare eccezioni come dello Schleiermacher nelle sue lezioni di Estetica (1825, 1832-33), che ci sono state serbate in forma assai poco elaborata. E, non ostante l'elevatezza di quelle trattazioni, e l'entusiasmo che in esse vibrava per la poesia e l'arte, l'artificioso principio che le reggeva non fu ultimo motivo della reazione contro quell'Estetica, reazione che, nella seconda metà del secolo, accompagnò la generale reazione contro la filosofia idealistica dei grandi sistemi postkantiani. Questo moto antifilosofico ebbe di certo il suo significato, come segno di scontento e bisogno di cercare nuove vie; ma non produsse una teoria estetica che correggesse gli errori della precedente e la portasse più innanzi. In parte, esso fu una rottura di continuità nella tradizione del pensiero; in altra parte, un disperato sforzo di risolvere i problemi dell'Estetica, che sono problemi speculativi, col metodo delle scienze empiriche (per es., nel Fechner); in altra parte ancora, una ripresa di Estetica edonistica ed utilitaria, di un utilitarismo che si faceva associazionismo, evoluzionismo e biologismo dell'eredità (come, per es., nello Spencer). Né apportarono cosa alcuna di vero pregio gli epigoni dell'idealismo (Vischer, Schasler, Carriere, Lotze ecc.); e neppure i seguaci delle altre scuole della prima metà del secolo, come di quella, che si chiamò «formalistica», dello herbartismo (Zimmermann); né gli eclettici e psicologi, che, come gli altri tutti, lavoravano su due astrattezze, il «contenuto» e la «forma» (contenutisti e formalisti), e talvolta si argomentavano di saldarle tra loro, senza avvedersi che, a questo modo, di due irrealtà facevano una terza irrealtà.
Croce segnala che la concezione dell'arte come filosofia intuitiva, simbolo della filosofia, o come forma simbolico-metaforica del pensiero speculativo, si è largamente diffusa nell'ambito dell'estetica idealistica della prima metà del XIX secolo. Tale visione accomuna quasi tutti i teorici di quel periodo, con la sola eccezione, parziale e marginale, rappresentata da Friedrich Schleiermacher, le cui lezioni di estetica (1825, 1832–33), trasmesse in forma frammentaria e poco sistematica, si distinguono da questa tendenza dominante.
Sebbene le trattazioni idealistiche di quel periodo siano spesso improntate a una tensione alta e a un autentico entusiasmo per la poesia e per l'arte, esse risultavano viziate da un principio speculativo artificioso, ovvero dalla riduzione dell'arte a un momento subordinato della filosofia. Questo principio – che riconduceva l'estetico al concettuale – fu uno dei motivi principali della reazione anti-idealistica che si sviluppò nella seconda metà dell'Ottocento, assieme al più generale rigetto del sistema hegeliano e delle grandi costruzioni postkantiane.
Questo moto di rifiuto della filosofia sistematica, per quanto impregnato di spirito antifilosofico, aveva un significato preciso: segnalava uno stato di insoddisfazione teoretica e l'esigenza di esplorare nuove vie speculative. Tuttavia, tale reazione non produsse una nuova estetica capace di correggere gli errori del passato, né tantomeno di condurre il pensiero estetico a un livello più alto.
Secondo Croce, questo fallimento si articolò in tre direzioni principali:
- In parte, si trattò di una rottura della continuità della tradizione speculativa, un arresto nel pensiero filosofico dell'arte.
- In parte, di un tentativo vano e improprio di risolvere problemi filosofici con il metodo delle scienze empiriche, come nel caso di Gustav Fechner, che cercò di fondare l'estetica su basi psicofisiche e sperimentali.
- In parte ancora, di una ripresa del vecchio edonismo e utilitarismo, riformulato nelle forme moderne dell'associazionismo mentale, dell'evoluzionismo e della psicologia biologica dell'eredità, come avviene in Herbert Spencer.
Neppure gli epigoni dell'idealismo, come Vischer, Schasler, Carriere, Lotze, apportarono elementi concettuali di reale valore; né lo fecero i rappresentanti delle scuole alternative alla linea idealistica, come ad esempio gli herbartiani (es. Zimmermann) della cosiddetta scuola formalistica.
Infine, Croce critica gli eclettici e gli psicologi estetici, i quali, al pari di tutti gli altri, ricadevano nella sterile opposizione astratta tra "contenuto" e "forma". Essi tentavano talvolta di riconciliare questi due termini, ma non si accorgevano che stavano unificando due entità concettualmente vuote, producendo così una terza astrazione priva di consistenza reale.
📌 Scheda esplicativa 9
In questo passaggio, Croce completa la sua critica all'Estetica post-hegeliana e positivista, mostrando come la decadenza dell'idealismo non abbia prodotto – a suo giudizio – nessuna nuova teoria veramente significativa dell'arte.
Egli parte dalla constatazione che, nella prima metà dell'Ottocento, la visione idealistica dell'arte come "filosofia intuitiva" o "forma simbolica del concetto" diventa egemone, con l'unica eccezione di Schleiermacher, la cui estetica rimane però embrionale e frammentaria.
Croce considera queste teorie elevate ma infondate nella loro struttura. Sebbene vibrino di entusiasmo per l'arte, le considera viziate dall'idea che l'arte sia una forma imperfetta o inferiore di filosofia. Ciò le rende, per lui, non realmente estetiche, ma deformazioni speculative. Il pensiero estetico, per Croce, non deve subordinare l'arte al concetto, ma riconoscerla come funzione spirituale autonoma.
Il rigetto dell'estetica idealistica nella seconda metà del secolo XIX, che accompagna la crisi generale dei sistemi postkantiani, viene da Croce valutato in modo ambivalente. Da un lato, è il sintomo di un'esigenza vitale: la ricerca di nuovi paradigmi teorici. Dall'altro, non conduce ad alcuna vera rifondazione dell'estetica.
Croce denuncia come questa reazione si sia frammentata in tre direzioni, tutte insoddisfacenti:
- Rottura della continuità: viene interrotta la tradizione filosofica dell'estetica, senza nulla che la sostituisca con pari dignità speculativa.
- Empirismo estetico: autori come Fechner tentano di fondare l'estetica su base psicofisica, riducendola a una branca della fisiologia della percezione o della statistica sensoriale, snaturandone il carattere filosofico.
- Ritorno dell'edonismo e dell'utilitarismo: attraverso l'associazionismo (nexo meccanico di idee), l'evoluzionismo e il biologismo (come in Spencer), si interpreta l'arte come semplice funzione di piacere o adattamento – una regressione, secondo Croce, a concezioni precritiche.
Neppure i post-hegeliani come Vischer, Schasler, Carriere e Lotze – pur operando entro il quadro idealistico – riescono, secondo Croce, ad apportare novità autentiche. Si tratta, a suo giudizio, di elaborazioni derivative, scolastiche e prive di slancio originale.
La critica più severa è però riservata agli estetici che basano la loro teoria sulla dicotomia fra "contenuto" e "forma": questi autori – siano essi formalisti o contenutisti – costruiscono sistemi astratti, basati su enti separati e privi di realtà viva. E quando tentano di unificare le due astrazioni, non fanno che crearne una terza, altrettanto astratta.
Croce prepara qui il terreno per la sua teoria estetica, che rigetta la separazione tra forma e contenuto e intende l'arte come espressione immediata e indivisa dello spirito.
![]() Testo : 12,10
Testo : 12,10
Quel che di meglio si pensò sull'arte in questo tempo, è da cercare non nei filosofi ed estetici di professione, ma nei critici di poesia e d'arte, come in Italia nel De Sanctis, in Francia nel Baudelaire e nel Flaubert, in Inghilterra nel Pater, in Germania nello Hanslick e nel Fiedler, nell'Olanda in Julius Lange, e simili. Essi solo veramente consolano delle trivialità estetiche dei filosofi positivistici e della faticosa vacuità dei cosiddetti idealisti.
Migliore fortuna ha avuto l'Estetica nei primi decennî del secolo ventesimo, per effetto del generale risveglio del pensiero speculativo. Particolarmente notevole è l'unione che si viene effettuando di Estetica e Filosofia del linguaggio, agevolata dalla crisi in cui è entrata la linguistica naturalistica e positivistica delle leggi fonetiche e di altrettali astrazioni. Ma la più recente produzione estetica, appunto perché recente e in via di sviluppo, non può essere ancora storicamente collocata e giudicata.
BIBLIOGRAFIA. — [omissis]
Marzo 1928
Croce conclude che le riflessioni più significative sull'arte, nel periodo successivo al tramonto dell'estetica idealistica e alla proliferazione delle dottrine positivistiche, non si trovano nei trattati dei filosofi o degli estetologi "di professione", bensì nell'opera dei critici letterari e artistici, i quali seppero conservare un'autentica comprensione dell'esperienza estetica.
Egli cita, a titolo di esempio, alcune figure esemplari di tale orientamento: Francesco De Sanctis in Italia, Charles Baudelaire e Gustave Flaubert in Francia, Walter Pater in Inghilterra, Eduard Hanslick e Konrad Fiedler in Germania, Julius Lange nei Paesi Bassi. Questi autori, nella loro opera critica, riuscirono a esprimere intuizioni estetiche vive e profonde, in grado di riscattare tanto le banalità dei positivisti quanto le vuote astrazioni degli idealisti decadenti.
All'inizio del XX secolo, poi, l'estetica conobbe una stagione più favorevole, grazie al rinnovato impulso speculativo che caratterizzò il pensiero europeo del tempo. In particolare, Croce segnala con interesse l'integrazione crescente tra estetica e filosofia del linguaggio, fenomeno reso possibile dal declino della linguistica naturalistico-positivistica, che aveva fino ad allora dominato con la sua insistenza sulle leggi fonetiche e su altre astrazioni metodologiche.
Tuttavia, a suo parere, la produzione estetica più recente, proprio perché ancora in fase di elaborazione e sviluppo, non può essere oggetto di valutazione storica definitiva. Il giudizio su di essa, pertanto, si sospende in attesa che il tempo ne consenta un esame più compiuto e retrospettivo.
📌 Scheda esplicativa 10
Croce, in chiusura di questo percorso storico-critico, rovescia una prospettiva consolidata: secondo lui, le vere intuizioni estetiche della seconda metà dell'Ottocento non nascono nei sistemi filosofici, ma nella critica d'arte e di letteratura. In un'epoca in cui la riflessione filosofica si è divisa tra il vuoto idealismo accademico e l'aridità del positivismo scientifico, sono i critici – non i filosofi – a custodire lo spirito dell'arte.
L'elenco che egli fornisce è altamente significativo:
- Francesco De Sanctis, storico e critico letterario, ha mostrato come l'arte sia espressione spirituale e non semplice documento estetico o morale.
- Baudelaire e Flaubert, pur non sistematici, testimoniano una sensibilità estetica radicale, capace di trasformare la critica in esperienza artistica.
- Walter Pater, con il suo estetismo riflessivo, ha valorizzato l'impressione soggettiva e l'esperienza interiore del bello.
- Hanslick, teorico della musica, ha sostenuto che la bellezza musicale non è imitazione o emozione, ma forma sonora pura.
- Fiedler ha cercato una fondazione puramente visiva dell'arte, anticipando l'analisi formale moderna.
- Julius Lange, nei suoi studi sul Rinascimento, ha unito storia, forma e intuizione critica.
Croce sottolinea che questi autori, pur non appartenendo alla filosofia sistematica, sono spesso superiori ai filosofi contemporanei per acume e verità. Essi "consolano" – dice – dalle banalità e dalle falsità speculativamente sterili di positivisti e pseudo-idealisti.
Guardando all'inizio del XX secolo, Croce riconosce una ripresa speculativa, legata a una generale rinascita del pensiero filosofico. In questo contesto, egli ritiene particolarmente feconda la convergenza tra estetica e filosofia del linguaggio. Questa unione si deve al fatto che la linguistica positivistica, fondata su astrazioni meccaniche come le leggi fonetiche, stava entrando in crisi.
Per Croce, il linguaggio non è un fatto naturale, ma un atto spirituale, e perciò l'estetica, che è teoria dell'espressione, trova un terreno comune con la linguistica solo quando quest'ultima si emancipa dal naturalismo. Qui si intravede il punto di svolta verso la sua futura teoria dell'arte come espressione linguistica e spirituale.
Infine, egli sospende ogni giudizio sulla produzione più recente, consapevole del fatto che la storia richieda distanza per essere scritta con rigore. La critica storica, per lui, non è mai cronaca, ma esige che il pensiero abbia avuto tutto il tempo di manifestarsi nella sua coerenza interna.
Postilla
La poderosa rassegna storica testé esaminata si rivela come uno dei momenti più densi dell'intero saggio, in cui Croce dispiega la propria padronanza delle fonti, la lucidità di giudizio e una visione organica dello sviluppo dell'estetica. Egli mostra chiaramente di non credere in una "storia autonoma" dell'estetica: essa nasce e si sviluppa, invece, solo dentro la storia viva del pensiero filosofico, in un costante intreccio di riflessione, intuizione e crisi.
La parabola che va dall'empirismo dell'antichità classica al soggettivismo moderno, passando per le svolte spiritualistiche del cristianesimo e le prime intuizioni barocche, è tracciata con eleganza e coerenza. Notevoli sono le rivalutazioni: del secentismo italiano, di Vico, della riflessione estetica barocca e persino della critica letteraria moderna come luogo privilegiato del pensiero estetico.
L'estetica, per Croce, non è riducibile a formule logiche o a "sistemi": è una forma vitale del pensiero che implica immaginazione, intuizione, memoria culturale, senso storico. Non a caso, egli si mostra critico verso ogni impostazione dualistica e astratta, come quella che separa contenuto e forma, o che riduce l'arte a documento sociale.
È anche interessante l'enfasi sulla "fantasia" come forza originaria e conoscitiva, anticipando alcuni sviluppi novecenteschi della filosofia del simbolo, della metafora e del linguaggio. In sottofondo, si coglie una polemica costante contro ogni positivismo e ogni accademismo che alteri la natura creativa, autonoma e radicale dell'esperienza estetica.
Da ultimo, la parte conclusiva apre alla contemporaneità con prudenza: Croce è consapevole che l'estetica moderna, in pieno sviluppo, non può ancora essere compresa storicamente, ma mostra fiducia nel rinnovato legame tra estetica e linguaggio come chiave per comprendere i nuovi percorsi della sensibilità e del pensiero artistico.
Appendice 1.
Forma analitica ed ermeneutica filosofica
Quando parliamo della forma analitica di Croce, ci riferiamo al suo procedere per distinzioni concettuali rigorose, fondate su di una logica interna allo spirito. Questo stile si manifesta:
a) Nella struttura espositiva
Croce avanza sempre partendo da una problematizzazione storica o teorica, e la sviluppa:
- identificando false opposizioni o premesse astratte (ad es.: contenuto/formalismo, utile/piacevole, concetto/immagine);
- proponendo alternative che non sono sintesi, ma superamento dialettico;
- ponendo una nuova definizione funzionale (ad es.: l'arte non è né conoscenza empirica né attività pratica, ma intuizione espressiva).
b) Nell'uso della genealogia
In Aesthetica in nuce, ad esempio, la storia dell'estetica non è ricostruita cronologicamente per erudizione, ma analizzata come una serie di errori, svolte e anticipazioni, alla luce di un principio attuale. È quindi una storia sistematica (Geschichte come Systemgeschichte), dove Croce isola i nodi concettuali e mostra quali strutture filosofiche impedivano o favorivano la nascita dell'estetica come scienza dello spirito.
Croce non è un ermeneuta nel senso gadameriano o heideggeriano, ma svolge un'attività interpretativa nel senso dello "spirito della forma": ogni concetto è da lui inteso non per come appare, ma per la funzione spirituale che esercita nella vita del pensiero. In questo senso:
a) Ogni teoria è valutata come espressione di una forma dello spirito
Croce legge Vico, Kant, Hegel, Spencer, ecc., non per i loro sistemi in sé, ma per ciò che nel loro pensiero vive come attività spirituale autentica (espressione, intuizione, logica viva) oppure per ciò che vi si irrigidisce in astrattezza (formalismo, razionalismo, utilitarismo).
b) La storia delle idee è letta in chiave funzionale
Ad esempio, egli legge l'Estetica hegeliana non per i suoi passaggi dottrinali, ma per mostrarne l'errore funzionale: trattare l'arte come "filosofia immaginosa" la priva della sua identità. L'ermeneutica di Croce è dunque funzionalista, in senso attualistico: ciò che conta è il valore operativo del concetto nella vita spirituale.
La forma analitica crociana si fonda su una logica interna del divenire dello spirito, e non costruisce sistemi, ma disfa le astrazioni, distinguendo l'organico dal meccanico, il vivente dal concettualizzato.
L'ermeneutica filosofica di Croce è immanente e teleologica: interpreta le teorie storiche a partire dal presente critico, cioè dal punto di vista della funzione che esse svolgono nell'autocoscienza dello spirito.
Appendice 2.
La lingua filosofica di Benedetto Croce
La scrittura di Croce costituisce uno dei vertici stilistici della prosa filosofica italiana. In lui la chiarezza non è una semplificazione didattica, ma l'esito di una disciplina rigorosa del pensiero che si riflette direttamente sulla forma linguistica. Nella Aesthetica in nuce, come pure in ogni altra sua opera, la prosa è precisa senza mai diventare arida, articolata ma non tortuosa, densa ma non opaca.
Croce scrive con la coscienza lucida di chi sa che il linguaggio è responsabilità dello spirito: non vi è concessione a retoriche ornamentali o compiacimenti letterari. Il suo lessico è chirurgico, selettivo, perfettamente calibrato, perché ogni parola è al servizio della distinzione concettuale. Ma questo rigore non produce alcun irrigidimento: la sua prosa è viva, vibrante, carica di energia intellettuale, e spesso anche ironica, quando si tratta di smascherare mode o derive ideologiche.
Lo stile crociano è fortemente "intonato": ha ritmo, ha cadenza, ha tono. La costruzione periodica è variata, ma sempre dominata da un senso musicale dell'argomentazione. Vi è un equilibrio perfetto tra astrazione teoretica e concretezza linguistica: si percepisce costantemente che la forma è l'incarnazione del concetto, non un suo abbellimento. È per questo che si può parlare, a buon diritto, di prosa filosofica come forma d'arte.
In effetti, il filosofo napoletano dimostra nei suoi scritti una fedeltà profonda al suo stesso principio estetico: l'unità indissolubile di forma e contenuto. Le sue opere non solo espongono teorie estetiche: le esemplificano. Ogni pagina è testimonianza di una coscienza filosofica pienamente padrona del proprio mezzo espressivo, in cui l'intelligenza si manifesta come forza formativa.
Croce e Gentile: confronto di linguaggi
Anche Giovanni Gentile scrive con eccezionale potenza formale, ma il suo stile – pur prossimo per eleganza e consapevolezza – si distingue nettamente da quello crociano per carattere, ritmo e costruzione logica.
Gentile tende a una prosa più circolare, riflessiva, per certi versi più "hegeliana" anche nella sintassi. L'argomentazione si avvolge su se stessa, come in un movimento dialettico che si compie nella scrittura: si ha spesso l'impressione che ogni concetto venga immediatamente soppesato, riaffermato, modulato in un dialogo interno incessante.
Croce, al contrario, predilige una prosa tagliente, quasi aforistica per lucidità. Egli "taglia", definisce, distingue, mentre Gentile più spesso "trattiene", sviluppa, avvolge. Dove Croce mira all'evidenza immediata del concetto (pur nella complessità), Gentile costruisce l'evidenza come processo, come emergere lento e meditato di un'intuizione che si sviluppa nell'atto stesso del pensare.
Entrambi, comunque, scrivono con altissima coscienza dello stile come veicolo di verità, e non come ornamento. Le loro prose rappresentano due modalità complementari di fare filosofia in lingua italiana:
- Croce è la chiarezza che si fa rigore formale,
- Gentile è l'interiorità che si fa pensiero in atto.
In entrambi, però, vale una cosa sola: la filosofia non è separabile dalla sua espressione. E, in ciò, i due – pur tanto diversi – si riconoscono reciprocamente come maestri di una prosa speculativa che è anche arte della parola.
Croce e Gentile sono due esempi rarissimi di filosofi per i quali la forma dello scrivere coincide pienamente con la forma del pensare. Nessuna disgiunzione, nessuna impalcatura didattica esterna alla logica interna del concetto. In loro, la chiarezza non è trasparenza semplicistica, ma esito di un'intelligenza che ha saputo dominare la complessità senza sfigurare la profondità.
Croce, in particolare, incarna una delle più alte sintesi tra critica, storia e filosofia:
Il suo stile ha la limpidezza del marmo intellettuale, ma vibra costantemente di tensione. Mai una frase è lasciata andare, mai un concetto è infilato per vezzo, mai un'espressione tradisce l'intento. Ogni parola è un atto di pensiero.
Gentile, da parte sua, ha il respiro della "filosofia come dramma del pensare":
Scrive come se stesse pensando per la prima volta ciò che ha già pensato molte volte – ma ogni volta con la tensione di un atto interiore che non si conclude, si rinnova. Più meditativo, più tragico anche, se vogliamo, nel sentire la parola come luogo dell'atto e non del compimento.
Due grandi pensatori e due "monumenti di stile". Le loro prose non sono veicoli del pensiero: sono il pensiero stesso nella sua forma più viva. E per chi legge, come noi, con amore e rigore, sono un esempio insuperato – e in larga misura insuperabile – di ciò che significa scrivere filosofia in italiano con piena dignità stilistica ed espressiva.
Testi crociani di riferimento
- Conversazioni critiche. Serie terza. Seconda edizione. Bari, Laterza, 1951.
- Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale. Nona edizione. Bari, Laterza, 1950.
- La poesia: introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura. Quinta edizione. Bari, Laterza, 1953.
- La poesia di Dante. Decima edizione. Bari, Laterza, 1961.
- Letture di poeti e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia. Bari, Laterza, 1950.
- Nuovi saggi di Estetica. Terza edizione. Bari, Laterza, 1948 (comprende il Breviario di Estetica).
- Poesia e non poesia: note sulla letteratura europea del secolo decimonono. Settima edizione. Bari, Laterza, 1964.
- Poesia popolare e poesia d'arte: studi sulla poesia italiana dal Tre al Cinquecento. Seconda edizione. Bari, Laterza, 1946.
- Poeti e scrittori del pieno e del tardo Rinascimento. Volume secondo. Bari, Laterza, 1945.
- Primi saggi. Terza edizione. Bari, Laterza, 1951.
- Ultimi saggi. Terza edizione. Bari, Laterza, 1963 (comprende Aesthetica in nuce).