Benson Boone, Rilke e Keats
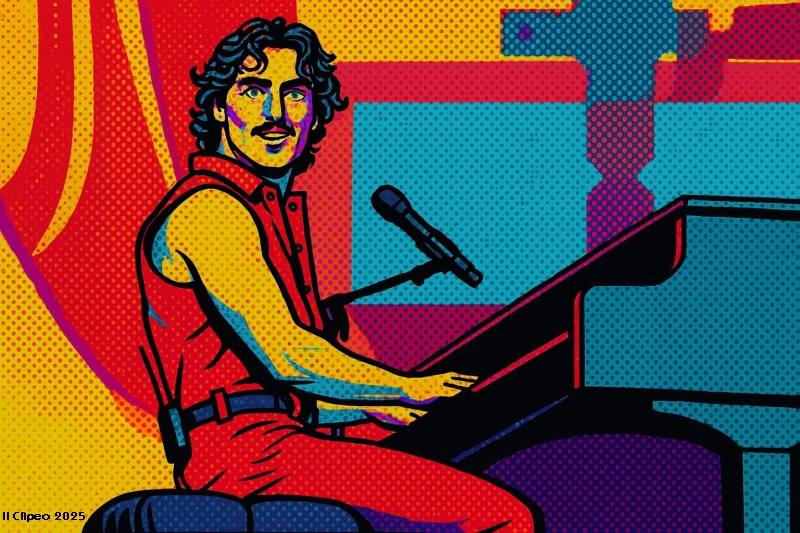
 eautiful Things di Benson Boone è una delle rare canzoni pop contemporanee a raggiungere una dimensione lirica compiutamente autentica. In essa, la voce non è un semplice veicolo emotivo, ma lo strumento di una confessione, fragile e potente insieme, in cui la musica diventa forma di pensiero. ✦
eautiful Things di Benson Boone è una delle rare canzoni pop contemporanee a raggiungere una dimensione lirica compiutamente autentica. In essa, la voce non è un semplice veicolo emotivo, ma lo strumento di una confessione, fragile e potente insieme, in cui la musica diventa forma di pensiero. ✦
Il canto di Boone si muove dentro una dialettica antichissima: la gratitudine e la paura, il desiderio di ringraziare e il terrore di perdere ciò che si ama. È una coscienza dell'impermanenza che un tempo apparteneva ai mistici e ai poeti romantici: il sentimento che ogni bellezza, proprio nel suo darsi, porta in sé la possibilità di svanire.
Il linguaggio della preghiera si intreccia qui con quello dell'amore. L'uomo che parla è riconoscente e spaventato allo stesso tempo: «I thank God every day / For the girl he sent my way / But I know the things he gives me / He can take away». È il riconoscimento di un bene ricevuto e, per ciò stesso, revocabile. Boone canta come chi ha attraversato un inverno dell'anima – «four cold Decembers» – e ora ritrova la luce, la famiglia, la donna amata, la fede. Ma nel momento stesso in cui pronuncia il suo "ho tutto", sente che ogni dono implica la possibilità della perdita. L'atto di gratitudine si trasforma in supplica: «Oh God, don't take these beautiful things that I've got».
È qui che la canzone diventa, letteralmente, una preghiera. Non laica, non simbolica, ma reale: un dialogo diretto con Dio, dal denso tono introspettivo, pronunciato nella lingua del pop e nella metrica del respiro. Boone non canta la certezza della fede, ma il tremore di chi teme di non meritarla. E in questo tremore si rivela la verità spirituale del brano: chi ama davvero teme. Non perché la paura contraddica l'amore, ma perché ne è la forma più pura – la coscienza della fragilità dell'altro e del dono ricevuto. «There's no man as terrified / As the man who stands to lose you»: questo verso è la chiave dell'intero pezzo. È la rivelazione di un sentimento che non può durare se non nel rischio della perdita, e che anzi proprio in quel rischio trova il suo senso.
Dal punto di vista formale, la canzone costruisce un arco emotivo netto. L'inizio è sommesso, quasi confessionale, come un diario detto a voce bassa; poi, a poco a poco, l'intonazione cresce, incombente, incalzante, fino al climax mozzafiato e all'esplosione del ritornello. È la stessa dinamica del sentimento che cerca di resistere alla perdita: una voce che, per non annegare nel silenzio, deve gridare. Anche l'orchestrazione accompagna questa parabola: la chitarra iniziale è nuda, quasi esitante, e poi, con l'ingresso della batteria, del pianoforte e degli archi sintetici, l'emozione si amplifica e sfocia nel coro vocale, senza però disperdersi, ripetendosi per due volte. È un crescendo non retorico ma necessario, perché riflette la progressione psicologica del testo.
Il ritornello, reiterato come una giaculatoria, unisce due direzioni di preghiera: Please stay – rivolta all'amata – e Oh God, don't take – rivolta al divino. L'una supplica orizzontale, l'altra verticale; due voci che si intrecciano nello stesso respiro. Musicalmente, l'alternanza tra sussurro e grido amplifica questa duplicità: la voce si alza e si ritrae, come una marea che non sa se ritirarsi o infrangersi. È la forma sonora di una tensione: chi ama ringrazia e teme nello stesso istante.
Boone giunge infine a una domanda di limpida disperazione: «If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone?». È la domanda di chi vive il bene sotto il segno dell'impermanenza, di chi sa che la felicità non è mai possesso ma tregua. La canzone termina come un ciclo che non si chiude: la voce continua a chiedere "please stay", ma ciò che resta non è la risposta, bensì la domanda stessa. È il canto di un uomo che non chiede la certezza, ma la grazia di continuare a ringraziare anche nella paura.
In questo paradosso – la gratitudine che genera timore, e il timore che intensifica la gratitudine – sta la verità profonda del brano. Beautiful Things non consola, ma rimette nel vero. Ti ricorda che amare è avere paura, che la preghiera non serve a trattenere, ma a custodire. E che il nome delle "cose belle" – l'amore, la pace, la mente ritrovata, la fede che ritorna – non indica un privilegio, ma un fragile altare domestico. Il bello, qui, non è spettacolo: è ciò che va protetto. E proteggerlo è già pregare.
È proprio tale drammatica continuità – tra parola umana e ascolto divino, tra fragilità e gratitudine – a rendere il brano del giovane cantautore statunitense, al di là del successo discografico (singolo più venduto al mondo nel 2024), una delle più autentiche preghiere musicali della nostra epoca.
🎧 Ascolta e guarda il lyric video ufficiale:
Benson Boone – "Beautiful Things"
© 2024 Warner Records / Night Street Records
Benson Boone official site
🔎 Note testuali
- Esaminata con le lenti della lettura critica, Beautiful Things appare come un salmo moderno in forma di ballata pop. L'incipit, con il suo tono prosastico, costruisce una piccola cronaca dell'ordinario – "famiglia, amore, serenità ritrovata" – che si trasfigura presto in teologia affettiva. La canzone riconosce il dono e la possibilità della sua revoca, proprio come accade nei Salmi o nel libro di Giobbe: il bene appartiene a Dio, non all'uomo, e la riconoscenza deve convivere con il timore.
- Da qui, la preghiera "a doppia voce": Please stay (rivolta all'amata) e Oh God, don't take (rivolta a Dio). La ripetizione agisce come un rosario, dove la parola non descrive ma resiste: ogni invocazione è un atto di difesa contro la dissoluzione. Il ritmo stesso della canzone – alternanza di cronaca e invocazione, calma e implorazione – traduce la condizione dell'uomo nuovo che ha ritrovato la fede ma non la sicurezza.
- La seconda parte del testo, con versi come "I found my mind, I'm feeling sane / It's been a while but I'm finding my faith", introduce un tono di veglia interiore. L'uomo possiede la pace e l'amore, ma la notte lo trova sveglio: "I'm up at night thinking I just might lose it all". Non è disperazione, ma vigilanza amorosa. Boone riscopre la fede come forma di paura benedetta: la coscienza che tutto ciò che è buono è fragile.
- In questa dialettica tra gratitudine e perdita, risuona la grande tradizione elegiaca: non il pianto sul già perduto, ma la tensione del perdentesi. La canzone è, in fondo, un'elegia dell'istante, simile alle Odi di Keats o ai Sonetti a Orfeo di Rilke. Di Keats conserva la visione del bello come verità – ciò che è vero proprio perché è mortale; di Rilke la percezione che il bello è "l'inizio del terribile", perché mostra all'uomo la misura di ciò che non può trattenere.
- Nel linguaggio popolare e diretto di Boone, questi archetipi si incarnano in un'esperienza quotidiana: la fede, la famiglia, l'amore, la serenità dopo la tempesta. Ma il messaggio non cambia: la vita buona fa paura proprio perché è buona. Il nome ripetuto di Dio non è decorazione, ma segno di un'alleanza fragile. Se il dono è suo, l'unico modo per amarlo è temerlo.
- Beautiful Things si colloca, perciò, in una linea di poesia religiosa e amorosa che va dai Salmi di Davide alle preghiere di Hopkins, fino ai frammenti di Emily Dickinson: un parlare con Dio non per convincerlo, ma per non smettere di parlargli.
📌 Nei concerti di Benson Boone, la tensione fra grazia e timore si rovescia in un linguaggio del corpo che ne prolunga e ne amplifica il senso. Al termine delle sue performance, l'artista salta giù dal palco e corre tra la folla, in lungo e in largo, a braccia aperte, cercando un contatto quasi sacramentale con il pubblico, con la maggior parte possibile dei presenti: abbraccia, tocca le mani, sorride, ringrazia con i palmi uniti, come in un gesto di devozione. Poi, risale sul palco e trasforma quella comunione in energia pura: balza, ruota su se stesso, compie capriole e spericolati salti mortali, si inginocchia e lancia baci come fossero benedizioni.
Non è esibizionismo, ma epifania: corpo che si fa veicolo di una gratitudine incontenibile.
La stessa voce che in Beautiful Things teme di perdere ciò che ama, qui sembra volerlo trattenere con il contatto, con la prossimità, con la generosità fisica.
È una sorta di liturgia del dono, in cui il gesto diventa parola, e la parola – una volta uscita dal brano – si reincarna nel corpo dell'artista.
Ciò che Boone restituisce al suo pubblico non è soltanto musica, ma un'immagine di sé interamente offerta, quasi oblativa. È il prolungamento naturale della sua preghiera: dopo aver chiesto a Dio di non portargli via le "cose belle", egli le restituisce – quelle stesse "cose belle" – ai volti e alle mani che lo circondano.
È come se la canzone, uscita dal registro interiore, trovasse nel gesto acrobatico e nell'abbraccio la sua piena rivelazione: la grazia diventa movimento, il timore diventa contatto.
👉 V. QUI (Algés, PT, luglio 2025) e QUI📣 Concerti pop ed esperienza collettiva
Uno studio del 2016 di Kulczynski, Baxter e Young (università australiane di Newcastle e Sydney) ha messo in luce che la partecipazione ai concerti di musica pop nasce dall'intreccio complesso di diverse spinte emotive e sociali, che possono agire con intensità variabile da individuo a individuo, assumendo di volta in volta un carattere esclusivo o dominante.
Il concerto è, insieme, esperienza estetica, identitaria e relazionale: un rito collettivo in cui si condensano memorie, desideri e appartenenze.
Fra i fattori più ricorrenti, la nostalgia occupa un posto centrale: il concerto diventa il luogo dove riemergono ricordi personali e affettivi, un ponte tra passato e presente che consente di ritrovare la propria storia attraverso le canzoni che l'hanno accompagnata.
Accanto a questo elemento, agisce l'apprezzamento estetico e artistico, ossia l'ammirazione per la qualità dell'esecuzione, per la bellezza sonora e visiva della performance, per la maestria con cui l'artista costruisce la scena e la trasforma in emozione condivisa.
C'è poi la spinta all'evasione, il desiderio di sospendere per qualche ora la quotidianità, di dimenticare gli obblighi e le ansie del giorno, di immergersi in un tempo "altro", liberato e gioioso.
Talvolta, questa libertà assume anche la forma di un coinvolgimento fisico e sensuale: il fascino della presenza scenica, la gestualità dell'artista, il carisma che passa dal corpo e dal volto e che trascina il pubblico in una partecipazione empatica.
Un'altra motivazione, più sottile ma non meno incisiva, è quella del rafforzamento dello status personale e sociale: assistere a un concerto importante significa potersi riconoscere come parte di una comunità culturale, o distinguersi in essa. È un modo di dire "io c'ero", di affermare la propria appartenenza a un momento unico e condiviso.
Altre volte, l'attenzione si concentra sull'ammirazione per l'abilità tecnica: il piacere di vedere un musicista o un cantante esibirsi con padronanza, energia, precisione, offrendo la dimostrazione tangibile del talento umano nella sua forma più immediata.
Ma l'esperienza dal vivo è anche socialità e appartenenza: un incontro con amici, sconosciuti, altri fan, in un'atmosfera che crea legami temporanei ma intensi. L'energia del gruppo amplifica quella individuale, e la musica diventa il linguaggio comune di un'identità collettiva.
Importante è pure la ricerca di esperienze musicali irripetibili, ciò che l'ascolto in streaming non può dare: una variazione improvvisa, una versione acustica, un gesto inaspettato dell'artista. L'unicità del momento è il cuore dell'esperienza live, la sensazione che ciò che si sta vivendo esista solo qui, ora, e non tornerà più.
Molti spettatori vivono poi una forma di identificazione con l'idolo: la presenza fisica del proprio artista preferito suscita devozione, gratitudine, e un desiderio di comunione quasi affettiva. È un sentimento di ammirazione profonda, a volte idealizzante, ma che contribuisce a rafforzare il senso di legame e di significato personale.
Infine, vi è la libertà espressiva che il concerto concede: la possibilità di lasciarsi andare, di gridare, ballare, piangere o ridere senza paura del giudizio. È la dimensione catartica dell'esperienza musicale, quella che trasforma l'ascolto in liberazione, l'emozione in corpo, la musica in gesto.
Insieme, queste dimensioni qualificano il concerto pop come un atto di comunione emotiva, dove la musica diventa veicolo di identità e di autenticità. L'evento live appare così non solo momento di intrattenimento, ma rituale contemporaneo: luogo simbolico in cui la memoria, la libertà e la relazione si intrecciano, restituendo all'individuo la pienezza sensoriale e affettiva che il consumo digitale tende a dissolvere.
💬 La ricerca citata – nonché molta neuroestetica contemporanea – lo conferma: durante un concerto, i corpi entrano in risonanza. Il ritmo, la voce, le luci e il contatto visivo creano una sincronizzazione spontanea di battito cardiaco, respiro e tono emotivo. Si liberano dopamina, endorfine, ossitocina: i neurotrasmettitori del piacere, dell'empatia, dell'attaccamento. È un fenomeno di co-regolazione collettiva: la musica allinea, armonizza, e trasforma un insieme di individui in una comunità vibrante.
Quando si vede il pubblico di Boone (o di altri artisti) piangere di gioia o gridare, non è isteria, ma catarsi neuro-emotiva: un rilascio controllato di tensione e gratitudine, un momento in cui l'emozione diventa corpo e il corpo si fa linguaggio comune. In quel frangente, la distinzione tra artista e spettatore vacilla: l'uno e l'altro si rispecchiano, condividendo lo stesso flusso di energia affettiva.
È questo che rende l'esperienza "live" diversa da qualsiasi ascolto domestico: l'intensità sensoriale non è più mediata da uno schermo o da una cuffia, ma avviene nello spazio reale, in tempo reale. La musica non è solo suono, ma vibrazione condivisa, e il pubblico non è solo destinatario: è parte dell'opera.
Per molti, questa immersione totale diventa una forma di trascendenza laica – una sospensione dei confini individuali, un contatto con qualcosa di più grande, che passa attraverso il corpo e le lacrime.